
Officina Letteraria e UDI.
Una donna, un giorno è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre scorso. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni.
Ogni lunedì e ogni venerdì saranno pubblicati su questo Blog i testi delle sedici partecipanti.
“La vasca” un racconto di C.T.
La vasca da bagno è una coperta concava in cui depositare parti del mio corpo che ancora sento rimbombare di eco. Le picchietto con indice e medio, come si fa con le pareti di cartongesso, come farebbe un medico in cerca di qualcosa che non va.
Loro emettono quella che è la conferma ai miei dubbi: ci sono ancora molti vuoti dentro di me.
L’acqua calda e questa vasca servono a questo. È quasi automatica e abbastanza scontata l’immagine dell’utero che mi attraversa i pensieri.
Questa vasca da bagno mi contiene, costruisce intorno a me le pareti che da sola non sono ancora brava ad alzare.
Utero.
Abbasso la sguardo e osservo il mio corpo sotto la trasparenza dell’acqua che ho deciso di non mischiare al sapone: la volevo così, come una lente di ingrandimento attraverso cui scrutarmi.
Ci sono i fianchi, mai abbastanza stretti come li vorrei. Le braccia lunghe e magre. Le mani affusolate. I polsi. Le caviglie. Le gambe respirano felici nello spazio fluttuante e, nello stesso tempo, ben definito, in cui le lascio galleggiare.
E dentro alla mia pancia, lui: l’utero. Quello che non so se userò mai. Non lo so. Perché finché continuo ad avere bisogno della vasca da bagno, non so se è il caso.
La verità è che, per ora, mi sento più simile a materia contenuta che a contenitore. Sono cose a cui penso, ultimamente.
Ultimamente vedo certe pance tendersi su corpi di ragazze che conosco. Non le mie amiche, no. Loro sono come me, stanno ancora cercando troppe cose per pensare di essere già arrivate. La pensiamo così oggi, prima dobbiamo cercare. C’è tempo. O forse per noi ce ne vuole di più, perché tutto, oggi, è più complicato. Ho sentito dire che adesso l’età media delle partorienti è sui trentotto. Non so se è vero.
Mi giro a pancia in giù.
Credo che la questione si possa mettere in questi termini: il mondo oggi è bello collegato, aperto, spazioso per certi versi. Ma anche bello spaventoso.
A volte fantastico di essere una donna del milleottocento. Una di quelle che studiava a casa, ricamava sui fazzoletti, si sposava e passava direttamente dalla tutela paterna a quella maritale, fine della storia. Altro che cercare la propria strada.
È quasi mezzanotte. Infilo la testa sotto l’acqua, spalanco la bocca: la materia liquida è subito pronta ad invadere il mio spazio interno. Io chiudo gli occhi e le urlo contro, sprigionando decine di punti interrogativi sotto forma di bolle d’aria.
Se non lo faccio credo che la tensione sarà troppo alta e che stanotte non riuscirò a dormire.
Il prezzo sarà qualche capillare rotto intorno agli occhi a causa dello sforzo fatto per buttare fuori tutte le particelle di ossigeno che prima erano dentro.
Durante il processo di espulsione, guardo in faccia quel futuro che mi fa tanta paura. Lui si materializza in immagini velocissime e spintonanti.
La laurea, la ricerca del lavoro, le case condivise, le amiche partite, quelle rimaste.
La testa riemerge e aspira aria e poi di nuovo sotto, sotto a chi tocca: comprare il pane ogni giorno in una lingua che non è la mia, sapere che appena parlerò, nonostante tutti i miei sforzi, gli altri capiranno che vengo da un altro paese, che sono vulnerabile.
Un altro vuoto, un altro respiro e un altro urlo: le storie interrotte perché mi dispiace, ma Berlino è troppo lontana e io non so nemmeno in quale parte del mondo sarò nei prossimi tre anni. Le amiche partite, le amiche perse. La spesa tutte le sere, che se non ci pensi da sola stai certa che morirai di fame. E poi i rumori nuovi della tua nuova casa, i soldi dell’affitto, i soldi chiesti ai tuoi, il numero dell’idraulico.
La domanda chi sono?, la risposta ho paura.
Di cosa ho paura?
Di diventare me stessa e nello stesso tempo di non diventarlo. Di non diventare nessuno.
E poi ho paura di Parigi, ma anche di Milano. Della febbre alta e nessuno che ti compri le medicine. Delle domeniche pomeriggio. Della neve. Di stare sola con me.
Sola. Con me.
Ecco, il vortice di bolle trasparenti e di fantasmi ha raggiunto l’apice. Ora c’è silenzio.
Avvolta dalla quiete, svelta, allungo un braccio, afferro l’asciugamano e mi alzo da quell’acqua pericolosa. Dentro di lei adesso nuotano, come tanti piccoli squali, quei miei pensieri dai denti appuntiti.
Ne esco fuori.
Inizio ad asciugarmi.
So già che stanotte dormirò, perché ho guardato in faccia il drago da cui sono scappata tutto il giorno, a partire da questa mattina, quando mi sono svegliata. Ho fatto il caffè. Mi sono vestita. Infilata il casco a cavallo dell’avambraccio. Tirata dietro la porta. Girato i giri, tre, della serratura. Posteggiato il motorino sotto alla biblioteca. Cercato un posto a sedere. Studiato. Pranzato. Parlato al telefono con un’amica. Letto senza capire niente pagina duecentotrentatrè, trentaquattro e trentacinque. Recuperato la borsa con le cose per il teatro. Cenato con una piadina e una birra. Pensato all’ultimo tizio che mi ha lasciata, per andare a Berlino. O per pensare al suo dottorato. O per tornare con la sua ex, che però nel frattempo si è sposata, con un altro.
La vita è un casino, penso. Avrei tanto desiderato che qualcuno me lo dicesse in modo più chiaro invece di farmi vedere i cartoni animati di Walt Disney.
Adesso non avrei bisogno di farmi dosi massicce di Tondelli. O della Szymborska. Prima di addormentarmi.
In fondo, penso, non è nemmeno più una questione di genere, la paura di sporgersi non ha genere. La paura di sporgersi sulla propria vita, di tracciarsi il sentiero. Ce l’hanno tutti. No?
Eppure, c’è una parte di me che non è del tutto d’accordo. Perché una ragazza con a fianco un ragazzo continua a ritenersi più forte. Fosse anche soltanto l’effetto placebo prodotto da un pregiudizio dalle radici millenarie. Di certo non basterà un secolo per farlo arrendere a mettersi da parte.
Oggi, a differenza di qualche decennio fa, le ragazze possono crescere. Vero. Bisogna vedere se vogliono farlo. Perché la paura se ne frega dei diritti acquistati. Anzi, a volte vorrebbe soltanto tornare indietro. E la cultura ci frega, perché spesso, oggi, uomini e donne sono uguali soltanto in teoria.
E i diritti non bastano a farci sentire tutti semplicemente adulti, a prescindere dal genere.
Molte continuano ad essere cresciute sentendosi dire che avranno i propri occhi, la propria bocca, le proprie braccia e le proprie gambe soltanto quando qualcuno le guarderà.
È questo qualcun altro il problema, questo qualcun altro da noi.
Avrei bisogno di essere risarcita dalla mia cultura per ogni uomo per il quale è stato più semplice che per me andarsene. Sporgersi sulla sua vita. Pensare alle proprie gambe, usarle per girare l’angolo e dimenticare. A me hanno insegnato a non dimenticare mai. A me hanno insegnato ad avere più paura, forse.
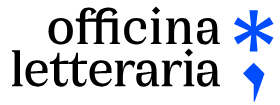

Comments:
emilia
5 Dicembre 2015 at 9:04 amMerviglioso! Grazie C.T.
Licia
5 Dicembre 2015 at 8:08 pmQuella sera all’Udi questo racconto, letto dalla sua autrice, mi entrato nel cuore. Era solo un estratto, quella sera, ma quell’acqua calda, lasciata trasparente, le domande, la paura di un futuro sempre troppo grande per contenerti come vorresti, come una vasca…erano il richiamo di uno specchio.
Le parole che scorrono come acqua, il corpo nudo e inerme che galleggia e poi affonda ed esplode in un urlo di bolle mute, che annegano nel silenzio. Grazie. Semplicemente bellissimo… E dentro quella vasca ci sono anch’io…