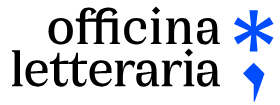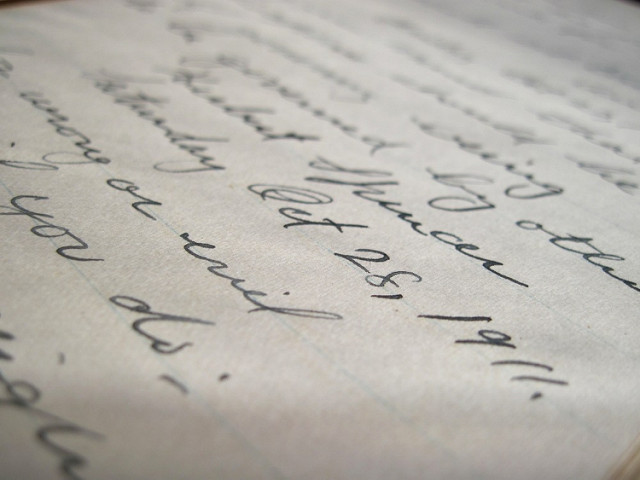
Nono e penultimo racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016.
Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni.
Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo!
Il boia in attività e la contessa decaduta
di Clara Negro
Bastardo d’un gatto! Già, cosa diavolo potevo aspettarmi da un animale? A me, un boia, essere accoppiato a una contessa, dover trovare addirittura il suo passato. Che tu sia una contessa non ci piove. Ti guardo, stai sola in mezzo alla piazza, il naso all’insù, fin troppo all’insù. Come lo chiamano? Alla francese? No, all’insù come quelli che hanno la puzza al naso, narici strette per non sentire l’odore dell’umanità. La puzza della paura e del sangue. Che io amo invece.
Ti muovi e cammini, la testa alta, lo sguardo che non sfiora mai terra. Guarda che così rischi grosso, bella mia, le pietre irregolari sono ingannevoli, non vorrei sbattessi il tuo bel nasino a terra.
Ti seguo verso il Castello della Lucertola. Mentre sali sorridi, come il viaggiatore che, lontano da troppo tempo, torna a casa, e ritrova la sensazione di posti conosciuti. Tentenni sulla porta del castello, ti fermi a guardare per essere sicura che nessuno ti segua. La porta è sbarrata: oggi non è giorno di visita. Appoggi le mani bianche allo stipite scuro, mormori qualcosa poi ti afflosci, come se, quell’abito che porti con sussiego ed eleganza, si fosse improvvisamente svuotato di te. Ti afferro prima che tu cada sulle pietre calde di sole.
Cosa credi bellezza che ti lasci andar giù così, a peso morto? Mi basta un braccio per sollevarti, un corpo troppo leggero, quasi fossi fatta di fumo e non di carne, ossa e sangue, cose di cui io son esperto.
Mi siedo nell’umidità dell’ombra, in modo tu possa sentire l’aria fredda che sgorga dalla bocca della cantina, e ti trattengo tra le braccia. Sento che stai riprendendo coscienza, apri gli occhi e mi vedi: “Chi sei?” Non scappi, non ti agiti, non urli come mi aspettavo, mi guardi dritto negli occhi.
“Chi sei?” ripeti.
“Ecco, questo è il mio problema, proprio uguale al tuo. Io sono un boia, e tu una contessa, mi sembra di aver capito.”
Sollevo la mano e l’avvicino al suo collo bianco. “E questa cos’è?”
“Questa cosa?”
“La cicatrice intendo.”
Non finisco la frase che sei già in piedi. “Di cosa parli? Quale cicatrice? Sono i tuoi occhi di boia vecchio e pazzo a farti vedere cose che non esistono?”
In quel momento la porta del castello si apre. È il custode che finisce il suo giro di ispezione e torna a casa. Lo spingi di lato e sgusci nell’androne buio. Ti seguo e il poveretto mi grida dietro:“Ma dove va? Oggi è chiuso.” Non mi fermo, entro e sbarro la porta con il ferro morto.
Sono sicuro che qui dentro è successo qualcosa. I tuoi e i miei passi rimbombano nelle stanze, sulle mattonelle decorate, tra i mobili antichi, nella corsa rovesci qualche sedia, cadono oggetti che non posso fermarmi a raccogliere. Stanza dopo stanza, corridoio dopo corridoio, sembra persino tu sappia dove andare, come cercassi rifugio o fuggissi da qualcuno.
“Fermati!” Grido.
L’ultima camera si apre su un giardino pensile. “Dove sei caruccia? Che ti nascondi a fare? Mica avrai paura di me? Sono il boia, ma tu che hai da temere?”
“E che ne sai? Magari potrei essere la prossima condannata alla forca, al ceppo.”
“Ehi sei rimasta indietro bella mia! È finita l’epoca delle barbarie. Adesso civili come siamo usiamo i vapori di cianuro, le iniezioni letali. Niente più sangue, purtroppo.”
“Va via boia o mi butto. Giuro mi butto di sotto.” Si avvicina alla balaustra.
“Me ne vado, me ne vado. Tu però non fare sciocchezze!”
Le tende a fiori svolazzano, gonfie di brezza della sera. Anche la luce si smorza, tenera e rosata illumina i ritratti alle pareti.
Mi avvicino a un dipinto, una cornice dorata chiude un paesaggio marino attorno al corpo di una donna sottile, flessuosa, lo sguardo alto, buttato lontano sull’orizzonte e il naso…il naso all’insù. Troppo all’insù. Leggo il cartellino alla base del quadro: Cristina Belforte, contessa di Apricale,15 maggio 1840 – 8 settembre 1865.
Cristina Belforte, sei tu allora, tu: la contessa di Apricale. Mi avvicino alla finestra, sei ancora là: il viso rivolto alla valle, le spalle curve di un peso senza memoria.
Torno al dipinto, accanto c’è un tavolo e sopra al piano lucido libri antichi, documenti dai margini consumati e un quaderno. Lo apro: pagine ingiallite, fitte di una scrittura leggera e incerta. Leggo e la stanza si riempie di voci e di ombre, il passato diventa presente.
Apricale, 12 marzo 1865
Il ventre si è gonfiato, ne spio la curva nel grande specchio della stanza. E faccio del mio meglio per schiacciare la protuberanza maligna con i palmi aperti. Che fare? Alfonso, mio marito, manca da otto mesi. Non posso fargli credere che sia frutto dei suoi lombi. E poi i soli ricordi che mi ha lasciato sono i segni della sua violenza. A lui, la colpa del mio tradimento. A lui e agli occhi e alle mani di Carlo. Alle sue parole di miele, al suo tocco leggero.
Scorro veloce le righe: senti dentro di te quell’essere indesiderato e lo odi. Non sarai mai una madre.
Apricale, 12 luglio 1865
Tutti al castello lo sanno e tutto il paese ne parla. Li odio. Odio me e lui, e Carlo Ratti che è felice, invece. “Fuggiremo lontano!” Mi dice.
Ma dove? Gli dico. Di che vivremo? “D’amore, mia adorata, d’amore e di baci.” Povero pazzo!
8 agosto 1865
È arrivata notizia: Alfonso tornerà prima di Natale. Per allora dovrebbe essere nato. Lo sento scalciare sempre più forte. Ho costretto Mariuccia a legarmi stretto il ventre con una fascia. Stringi, tira forte. Troppo tardi, non servirà a far scomparire la pancia, ha detto.
Si avvicina il momento. Temi per te, non per lui. Gli agi della tua vita, il castello, gli abiti eleganti, le feste, potresti perdere tutto. Stringi i lacci più forte che puoi.
7 settembre: lo butti fuori dal tuo corpo, senza un lamento.
8 settembre 1865
Questa mattina è arrivato il Ratti. Ti ha sollevato, guardato alla luce del sole. Mio figlio, ha detto. Vedrai, saremo felici. Ce ne andremo noi tre, prima che lui torni, ha sussurrato prima di lasciarmi da sola con te. È stato facile. E rapido. Ho barattato la tua morte per la mia vita.
Il diario finisce lì.
Il resto è vergato con una scrittura diversa.
La contessa, al secolo Cristina Belforte, muore assassinata nel dì dell’otto settembre 1865, dal sovraintendente del castello, tale Carlo Ratti, che le ha reciso la gola nel sonno. L’uomo verrà accusato dell’omicidio del piccolo Benedetto, frutto della loro relazione adultera e trovato esanime tra le braccia della madre.
Solo dopo la morte di lui, avvenuta in seguito a condanna capitale e per mano del boia di Apricale, verrà ritrovato il presente scritto dal quale emerge il delitto contro natura della donna. La salma di Cristina Belforte, per ordine del conte Alfonso Doria, è stata riesumata e le spoglie gettate da una rupe fuori dai confini di Apricale nel quindicesimo dì di gennaio 1866.
Dalle finestre aperte arrivano le voci della piazza e il garrire delle rondini.
Dove sei, povera anima dannata, adesso che il tuo passato ha un nome? Fuori, in quel giardino figlio di un tuo capriccio, tra il profumo della lavanda e della mentuccia, ai piedi della balaustra è rimasto il tuo abito rosa pallido: una macchia chiara sul grigio polveroso delle pietre.