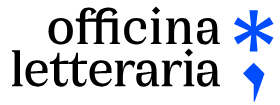Sesto racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo! Il barone rampante (oppure no) e l’oste onesto (oppure no) di Licia Valente Mi sono appoggiato alla balaustra sul sagrato della chiesa. La gente è più bella vista dall’alto. Ricci arruffati, cocce pelate che brillano al sole, ventri gonfi sotto bazze di tordo. Ride il gatto, è disgustoso mentre ammicca e si prende confidenza, quasi fosse uno di noi. Chi siamo noi? Ero un barone, lo so per certo, ché non mi piace star appresso agli altri, né gli altri amano avvicinarsi a me. Chi sono gli altri? Cavalieri, mocciosi, chierici derelitti, musici e contesse decaduti hanno steso sulla piazza le loro vite senza più orme una vicina all’altra. Siamo fantasmi appesi al campanile, in balia del vento che non viene a portarci via. La porta del castello stride con le rondini, si apre su un giardino ombroso che guarda il borgo dall’alto, come me. Senza più una storia che segni il mio confine, provo a immaginarne altre, una per ogni testa. Qual è la tua, oste che ti dici onesto? Le tue spalle piccole si sono posate come un velo sulle pietre aguzze. Hai dormito il sonno dei giusti e ti sei svegliato che non eri più tu. Sarai davvero onesto? Dal fondo del mio nulla ormai perduto suona una nenia antica: L’oste onesto si muove lesto. Non è mai mesto l’oste onesto. Ha le mani fini e sottili, di chi sa dove vuole metterle le mani, e dove tenerle fuori. In sogno, dita simili, di donna, si infilano nel solco della memoria e della mia schiena. “Diritto, devi stare diritto”. La voce che risale da lontano, gira intorno a una tavola imbandita, non ha volto né nome. L’oste sorride a tutti, non separa mai le labbra. Non dice, lascia dire. Annuisce spesso, quasi annotasse un parere da prendere in prestito. Per lui, siamo solo passanti dentro una taverna senza nome o luogo, in una notte senza memoria, uno a fianco all’altro, lo sguardo fisso alla bicicletta appesa al campanile, che nessuno la può rubare. Seduto al lavatoio, l’oste fissa il vuoto e stringe le mani l’una dentro l’altra. Dove vuoi tornare, oste onesto? Un oste è onesto solo se non è un oste. Dalla mia balaustra, osservo la lapide su cui vorrei leggere chi sono stato. Una voce straniera fende l’aria alle mie spalle. Mi inchino d’istinto. “Bonjour mademoiselle l’artiste”, e son già pronto a balzare sul parapetto, di nuovo in alto, lontano. L’ amazzone del popolo che ho davanti non è certo demoiselle, ha mani ruvide con cui si carezza le guance cosparse di vene sottili. – Bonjour, mi dice. – Vous n’êtes donc pas l’artiste? – Eh bien non. Sono l’ostessa, per servirvi, Monsieur. – È incredibile c’è qui tra noi smemorati anche un oste, forse onesto, o almeno comme ça il dit. Forse lo conoscete? – Monsieur mio caro, mi dice allora lei, tout le monde le sait che un oste è onesto solo se non è un oste! Ride così argentina che mi scappa la voglia di saltar sul mio poggio. Ha fianchi larghi e seni poderosi che tiene a bada con le mani mentre ride. E’ desiderio quello che provo? Ho avuto un grande amore? Forse mai. – Ditemi però, Madame, lo avete mai conosciuto, voi, un oste onesto? – Oh moi? Bien sur, certo che sì. Questo sette di luglio non c’è la luna, che se l’è mangiata il gatto, dopo la lucertola. Lei è tornata sotto la mia balaustra. Da lì mi ha detto del suo amore perduto in una notte di nera magia. Oste, hai avuto più di una vita e più di un volto. Eri tu quel giovane delicato e buono, per davvero hai amato e per amore hai abbandonato altezze e distanze. Svelato è il tuo mistero, oste onesto: fosti Alberico, nobiluomo innamorato di una scalcinata forestiera senza passato o blasone. Nel borgo fu l’incontro, per lei lasciasti onore e lustro appesi al gran camino delle feste, nel castello ai piedi del monte. Al borgo passò la strega quella notte e quando tornasti a questo borgo appeso, le campane non si mossero a salutare il tuo ritorno d’eroe senza trofeo. Ti dissero allora che se n’era andata. La notte del 3 di Luglio, quella volta. la strega rubò a lei, straniera, la memoria e a te l’amore. Senza una parola, era fuggita a un passato che credeva per sempre perduto, mentre il gatto rideva, tenendo tra le unghie la vostra storia, come un topo che muore. Senza più nome né amore, cercasti un luogo straniero e ti facesti oste tu stesso, a eterna memoria del sogno fuggito. Sei davvero onesto, oste, perché oste davvero non sei. Per questo sei tornato qui, a cercarla una volta ancora. E sei rimasto tu, questa volta, prigioniero tra le fauci della strega e del gatto. Mi guarda sconsolato, quel nome davvero non è più il suo. “Non sono più io quell’uomo, io sono l’oste portami via al mio banco e al mio grembiule.” Lei spunta da dietro le mie spalle, – Sono io. Sono qui. La seguo scendere lenta, verso di lui. È una stella che scende dentro gli occhi spalancati di lui. Sono quattro ora le mani intrecciate e hanno la forza dell’edera, per non lasciarsi più. Il gatto ulula dal fondo del pozzo. – Finalmente ti ho trovata, le sussurra lui. – Sono io che ho ritrovato te. Leggi gli altri racconti di Apricale 2016!
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. Ancora un’altra giornata la giornata di Sara Sono molto stanca. Sono sempre molto stanca, io. Non si tratta della quantità di cose che faccio in una giornata, certo ne faccio molte, ma non è quello; in una condizione diversa potrei farne altrettante senza essere inguaribilmente stanca. La mia stanchezza è sintomo d’una malattia chiamata abitudine al dovere. Mi esercito con diligenza a questo tipo di abitudine per rassegnazione ed inevitabilità: manco di una strategia alternativa e davanti alla mia disperazione di cambiare le cose ogni progetto si arrende. Il fatto è che andare a rinchiudermi in una stanza, popolata da persone che non ho necessariamente scelto di vedere nove ore al giorno, non mi va proprio giù. Non è per queste persone tuttavia, col tempo abbiamo modulato il nostro essere umani in una vicinanza forzata, abbiamo creato un equilibrio, un clima dopotutto; il fatto è che ho una lunga serie di motivi per essere stanca. Ad esempio, la mia sveglia suona alle sette ogni mattina, e non dico che vorrei dormire, ma che vorrei smetterla di dover correre ogni giorno come se stesse per finire il mondo e mi fossero rimasti solo pochi minuti per salutare la mia famiglia per l’ultima volta, quando lo scopo della mia frenesia in realtà è non timbrare in ritardo un’entrata al lavoro. Ad esempio, odio gli spazi piccoli e sovraffollati e l’ufficio in cui lavoro è un quadrato in un rettangolo di tanti altri quadrati in cui ci si è dati parecchio da fare per aumentare la densità di popolazione per metro quadro. Ad esempio, ci sono giorni in cui vorrei andare a farmi una passeggiata in riva al mare o restare a casa a scrivere il mio romanzo che non finisco mai o andare a leggere un libro in una locanda sorseggiando quel caffè che non posso bere perché il mio colon-irritabile-sempre-irritato me lo impedisce. Ad esempio, fissare un monitor come un serpente che ne ha subito l’incantesimo, restare seduta nella stessa posizione per molte ore, compiere numerosissime ripetizioni in un processo di click automatizzati, sollecitare senza tregua chi mai risponde non mi piace. Ad esempio, lavorare duro, lavorare seriamente, trovare persino un senso alla fine di quelle giornate – che si ricalcano con una precisione tale da farmi dubitare che stia vivendo la stessa unica giornata da molti anni – mi pare un’illusione nel momento in cui mi accorgo che conta solo ciò che appare. Ad esempio, mangiare con un cronometro da centometrista puntato sulla testa a scandire la mia tregua di quarantacinque minuti mi fa restare il pranzo sullo stomaco perlopiù. Ed ecco che il mio apparato digerente mi dichiara sciopero e, almeno lui, di lavorare proprio non vuol sapere. Ad esempio, dopo otto ore di lavoro vorrei uscire; e molto spesso lo faccio, ma il senso di colpa per tutte le cose che ogni giorno lascio da finire viene a farmi visita la sera, quando passo in rassegna tutte quelle maledette scadenze che si accalcano in quella che sembra essere una linea unica, sempre più spessa, su un giorno del calendario. Un calendario in cui numeri sono vaghi ricordi, al di là di queste linee spesse. Poi, quando alla fine riesco ad uscire, viene la stanchezza a prendermi. Il resto della giornata è la coda di un’animale lungo, il cui corpo ormai è uscito dal mio campo visivo da un pezzo. O come titoli di coda di un film che avrei voluto vedere, se fossi arrivata in ritardo per ritrovarmi sulla poltrona del cinema quando gli altri ormai se ne stanno per andare. Quella coda è il mio tornare a casa, accorgermi che non posso avere la pretesa che la cena si sia preparata da sola, decidere per principio o per rispetto che io e mio marito non possiamo fomentare l’industria dei cibi surgelati e mettermi a cucinare, lavarmi e poi lavare il bagno, decidere se fare una lavatrice o tirare avanti, decidere se stirare o tirare avanti, tentare di scrivere qualcosa ma smettere dopo mezz’ora perché l’emicrania incombe, accorgermi che alle nove e quarantacinque sto per addormentarmi e arrendermi in attesa di un’altra giornata come questa. Sono molto stanca. Sono sempre molto stanca perché continuo a vivere giornate come queste, che passano inosservate perché assolutamente normali per l’uomo moderno.
Officina Letteraria e UDI. “Una donna, un giorno” è il titolo del reading che Officina Letteraria e UDI- Unione Donne in Italia – hanno deciso di ideare e mettere in scena presso la Biblioteca Margherita Ferro, il 6 novembre 2015. Ognuna delle partecipanti, in tutto sedici, ha scritto un racconto che aveva come traccia la descrizione di una giornata di una donna oggi. Le parole delle scrittrici partecipanti sono stati accolte presso la sede dell’Udi e lì hanno trovato orecchie coscienti e curiose, entusiasmo e possibilità di confronto. La sede dell’UDI di via Cairoli 14/6 porta appesi alle pareti i manifesti delle battaglie femministe che settant’anni fa iniziavano a diventare fondamentali nella storie delle donne di questo paese: aprire le porte alle parole delle donne oggi, è stato un grande aggiornamento del file, uno sguardo trasversale che ha connesso tutte, lettrici e ascoltatrici, ad una radice comune, dalla quale attingere per interpretare ogni singola posizione. E cercare di capire. Aggiustare un po’ la rotta. Farsi delle domande. Trovare delle risposte, nelle esperienze dell’altra. E soprattutto, forse, sentirsi comprese e rispettate, oggi, nel proprio essere diverse, una dall’altra: oltre ai clichè, oltre alle definizioni. Bussola la giornata di Emilia “The future is dark, which is the best thing the future can be, I think.” Virginia Woolf Premessa: ho chiara la meta, ma non ho mai immaginato la mappa. I numeri che contano: cinque, sei, sette e cinquantacinque, tredici e cinquantacinque, sette, diciannove e trenta, ventuno e trenta, venti, due, quarantadue, settantatre, sessantadue e mezzo, sessanta, diciotto, venticinque, due, quattro. Le azioni: svegliarsi, lavarsi, pesarsi, vestirsi, scusarsi, sorridere, pregare, comprare, mangiare, guidare, preparare, spiegare, sgridare, scrivere, correggere, studiare, parlare, dialogare, telefonare, fare, credere, guardare, dormire, misurare, confrontare, accettare, rifiutare, pulire. Queste sono le ossa del mio tempo. Adesso viene la ciccia. Oggi è mercoledì: io, mi sveglio alle cinque, come al lunedì e al martedì. Ho calcolato tutto: sveglia, pipì, caffettiera, fuoco sotto il caffè, pipì, bilancia, faccia, ascelle, denti, spengo il fuoco sotto il caffè, troppo tardi, non pulisco la pozza sul fornello, non mi faccio domande su chi mi vede dalla finestra di fronte, discinta in varie maniere, mi vesto, sperando in innumerevoli grazie, e oggi non ne ho voglia, vorrei una tuta, ma no, così sacco di patate anche no, allora tutta di nero, che non necessita pensieri e accoppiamenti, e comunque è tutto largo, e un anno fa era troppo stretto, e faccio colazione, e fumo la prima sigaretta e controllo la posta elettronica e, per carità, nessuno che parli alla radio o in generale, e meno male che al momento non vedo nessuno, perché al mattino che parlano o commentano le notizie o ballano canticchiando e leccandosi i capezzoli (storia vera, perdinci!) e allora son soddisfatta della magra però intanto c’ho fatto caso e m’impegno in una dettagliata e puntigliosa discussione immaginaria con l’ultimo dei miei ex, da cui esco vincitrice morale e fattuale. … m’impegno in una dettagliata e puntigliosa discussione immaginaria con l’ultimo dei miei ex, da cui esco vincitrice morale e fattuale. Soddisfatta, finisco la vestizione e guardo l’orologio del bagno. Ho calcolato tutto; ho calcolato male: sono in ritardo. Arrivo alla macchina. Non è la mia. Pausa. Ravvio. Ho trovato la macchina. Alla seconda passata. Metto in moto, accelero in prima, troppo, porcaccia ho dimenticato di preparare la lezione per la bambina straniera che, nonostante le mie distrazioni e casualità, sta imparando l’italiano, devo pure procacciarmi il cibo, perché si ha da mangiar bene, ma non è più così importante (il cibo) finché mi peso, e allora ricalcolo, ripasso e stabilisco soluzioni: gli esercizi per la straniera, il tragitto per il cibo. E mi godo la sopraelevata, che, a Genova fa brutto dirlo, ma è bella, per la vista. E mi godo la sopraelevata, che, a Genova fa brutto dirlo, ma è bella, per la vista. Arrivo a scuola. Cinque ore, due con diciotto, tre con venticinque: Storia, Antologia, Storia, Antologia, Geografia; ogni istante moltiplicato almeno per tre: i tre livelli, i cinque pluribocciati, i sette interessati, non importa, ma almeno tre. Il tempo si dilata sotto il tentativo di stare dietro a tutti finché non tocca la certezza del fondale: sto facendo giusto. (Ogni giorno di scuola non è cinque, ma quindici-trenta ore). Alla fine, oggi soddisfatta: animo leggero, cervello elastico: la seconda ha retto l’analisi degli aggettivi ne “L’Infinito” di Leopardi, la prima inizia a esprimere dubbi. Abbiamo provato l’evacuazione in caso d’incendio e non siamo morti. Dieci minuti e si era di nuovo in classe. Scendiamo, siamo tutti liberi, ma ho parlato troppo presto. Mentre cerco cartine, tabacco e filtri, che hanno la stessa esistenza intermittente di chiavi, portafoglio e cellulare, una mamma mi viene incontro, saluta e chiede cosa è successo con la figlia. Errore uno: mi fermo, dovrei rimandarla all’orario di ricevimento. Errore due: non mi ricordo. Lei incalza, ma sì, l’ha interrogata e l’ha rimanda a posto. Focalizzo: la bimba, prima media, bravina, interrogata di Storia, non la sa, non avevo voglia di dar votacci, l’ho mandata a posto e le ho detto di tornare la volta dopo. Lei incalza. “Ma c’era un cinque!” “Signora, poi le ho dato sei e mezzo.” “Ma c’era un cinque!” “Si, ma non c’è più.” Alziamo la voce. Maledetta io che mi dimentico, maledetto registro elettronico, tento di spiegare che quel voto non l’ho detto alla bambina, che era un promemoria per me, ma niente, lei insiste. “C’era un cinque!” ripete “E la bambina ha pianto! Sa quando sua figlia piange?” No, non lo so, io non ce l’ho una figlia. Non ho un figlio. Non ho una cane. Non ho un gatto. Ho due piante del buio e un’orchidea dell’Ikea. Il resto della mia capacità di cura l’ho messo in vendita, e va bene così. Ma ho capito. Mi calmo. Rispiego. La mamma non è convinta ma molla il colpo. Mi guarda, mi saluta e se ne va. E, giuro, abbraccia la figlia. Il resto della giornata ha il ritmo della
Quinto racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo il racconto del vecchio musicista e del barone rampante! Il vecchio musicista (oppure no) e il barone rampante (oppure no) di Paolo Silingardi «Barone, credo che il gatto sia stato oltremodo magnanimo nell’assegnarmi questo compito. Abbiate solo la compiacenza di sfilarvi il guanto in modo che possa osservare l’anello con il sigillo del casato e il mistero sarà subito risolto» «Ma certo! Nonostante l’età il suo cervello è davvero… ahi» la bocca si piega in una smorfia di dolore. «Diavolo, mi sono ferito. Mi era parso in effetti di avvertire un fastidio.» «E’ un taglio.» «Non ho la minima idea di come me lo possa essere procurato» «E il suo anello è sparito.» «Forse sono stato rapinato.» «È quello che intendo scoprire, signor barone. I miei ossequi.» Immerso nei miei pensieri ho abbandonato la cacofonia della piazza per trovare rifugio nella quiete dei vicoli ombrosi. Il gatto ha detto che l’incantesimo colpisce solo i forestieri. Senza dubbio il primo passo è dunque quello di domandare nelle locande. Mi metto quindi in cammino mentre riassumo nella mente le caratteristiche del barone. I vestiti paiono di eccellente fattura, il portamento è nobile, la voce è bassa e impostata. Solo quel barbone nero da brigante stona con il resto, ma vai a sapere come sono adesso le mode dei giovani. Assorto in questi pensieri mi ritrovo infine davanti a una locanda, l’insegna malandata che cigola alla brezza del mattino. Non pare posto adatto a un signore, ma da qualche parte si deve pur cominciare. E poi ho bisogno di andare in bagno e riposare qualche minuto. «Mi hanno detto che in questa locanda alloggia il barone di… di… Mi aiuti bella signorina ché alla mia età la memoria gioca brutti scherzi…» La fanciulla scoppia a ridere così forte che quasi rovescia il mio bianco amaro. Il suo petto sussulta meraviglioso come quello di certi soprani… «Un barone qui. Questa è bella davvero bella» i seni palpitano ancora mentre si curva sul tavolino. «Eppure dovrebbe alloggiare in una locanda come questa, se non erro.» «Voi forestieri in questi giorni… I nobili non alloggiano alla locanda, ma al castello, in cima alla rocca. » Ringrazio allungando una moneta. «Questa è per il vino, per l’informazione e per la grazia delle sue risate.» Mi scocca un bacio sulla tempia e si allontana ancheggiando tra le risa. Metto in tasca un sottobicchiere per ricordarmi della bella cameriera ed esco salutando con un sorriso sornione. Il bianco ghiacciato mi ha un po’ rinfrancato, ma tutte queste scale con gli alti scalini e le pedate irregolari che spezzano il ritmo… Mi tuffo nella garitta del guardiano come in un laghetto gelato. «Il signore è atteso?» «Ma certo! Io sono… Sono Giacomo Puccini!» «Un musicista. È il primo questa settimana» declama il servitore attraversando a passo troppo svelto, l’ampio salone silenzioso. «Tuttavia il barone è assente. Non so quando tornerà. Come ben saprà si tratta di un uomo piuttosto eccentrico» soggiunge quindi in tono confidenziale. Poi indica una sedia e si dilegua. Mi guardo intorno mentre recupero il fiato e le gambe rallentano il tremore. La grande sala colpisce per il silenzio del suo spazio. Un soffitto spiovente in legno, sorretto da robuste capriate, veglia muto sull’aria immobile. La campana rintocca una volta. Poi tace. Passeggio un poco per mantenere attiva la circolazione. Ho bisogno di andare in bagno e ne ho bisogno in fretta. Forse dietro questa porta… In un attimo mi ritrovo nel gabinetto particolare del barone. Alle pareti scaffali ingombri di libri. Al centro un pesante tavolo di quercia ricoperto di faldoni e strumenti musicali. Su un leggio, illuminato dalla luce polverosa, uno spartito scritto a meno: una ballata ingenua, ma orecchiabile. Sgattaiolo via furtivo e in pochi istanti ritrovo sotto i piedi i ciottoli sconnessi dei vicoli. Un cane orina contro un muro, innaffiando incurante un vaso di gerani. Beato lui, penso mentre cerco un angolino appartato per imitarlo. Trovo un anfratto e finalmente mi libero, beandomi del rintocco delle gocce nella piccola pozzanghera che si va formando accanto a quell’altra macchina scura che pare…sì, pare proprio… sangue. Sangue non del tutto asciutto. Accanto altre chiazze più piccole si allontanano fitte lungo il muro perdendosi nel buio. Da una finestra giunge a tratti un fischiettare sommesso. Un gatto nero mi sguscia accanto scomparendo nell’ombra alle mie spalle. Qualche metro più avanti il vicolo termina in una lunga ripidissima scala che conduce a una botola fradicia e rappezzata. Il fischiettare è ora più nitido. Forse qualcuno intento a imbottigliare vino o ad accatastare legna, penso mentre istintivamente riprendo l’arietta in contrappunto e… Un minuto dopo le mie nocche percuotono la porticina con tutta la forza rimasta. «Apra Barone!» «Temo di non esserne in grado» la voce baritonale ha preso il posto del fischio e giunge nitida da dietro la botola. «Sono legato come un salame». Provo a scuotere il portello con uno spintone, ma invano. «Bisogna sollevare il ferro morto, amico mio. Possedete una spada o un pugnale?» Mi viene in mente il sottobicchiere affondato nella tasca. Lo infilo nella fessura facendolo scorrere piano verso l’alto. Al quarto tentativo la botola si apre e quasi precipito all’interno inciampando nel gradino. «Dunque ha riconosciuto la mia ballata. Notevole.» «Penso di aver riconosciuto anche vostro fratello, ora che vi osservo meglio.» «Il mio gemello. Secondogenito per quaranta minuti» sorride il barone massaggiandosi i polsi. «Un usurpatore, dunque. Bisogna dare subito l’allarme. E chiamare un medico per la vostra ferita.» «Calma, amico mio. Io sto benissimo. È stato Rinaldo a ferirsi nel duello di stanotte. Io a quel punto mi sono arreso prima che finissimo per farci male davvero.» «E se vi avesse ucciso?» «Sciocchezze. Ha bisogno di tenermi vivo per estorcermi tutte le informazioni necessarie
873 racconti in quattro mesi: sono questi i numeri raggiunti dal concorso proposto per i vent’anni di D, in collaborazione con Alessandro Baricco e la Scuola Holden. L’iniziativa. La vicenda iniziale, scritta da Baricco per D, e lasciata in sospeso per essere continuata, ha dato il via a un susseguirsi di storie, ipotesi, immagini. Più di ottocento, tra lettori e lettrici, hanno raccolto la sfida lanciata, e hanno deciso di partecipare, inviando uno o più racconti. L’incipit. La storia iniziava con un lago, e un padre, che porta il figlio a pescare. Poi una telefonata, una donna che risponde “Amore?“ (la stessa che, a casa, attende il rientro del marito e del figlio? Un’altra?). Da quel momento, uno stacco temporale, un salto lungo vent’anni. Cosa è successo, in quel tempo taciuto? Un’allieva di Officina tra i pubblicati. Il concorso ha raggiunto tutta Italia, ed è stato proposto all’interno delle Case Circondariali di San Vittore e Milano Opera. Tra tutti gli elaborati arrivati, ne sono stati selezionati dieci. Migliori per contenuto, forma, creatività, atmosfera. Tra i pubblicati, anche il racconto di Laura di Biase, affezionata allieva di Officina Letteraria. Di seguito potete leggere il racconto di Laura. Leggi l’incipit di Baricco. Sei sempre stato così. Facevi finta di sapere, volevi dire, volevi insegnare. A quel figlio che ti faceva paura. Più del bosco che hai attraversato quella notte. Avevi paura dell’oscurità di tuo padre, che non avevi conosciuto se non nei momenti più bui, quelli che avresti voluto più accesi di luce. Che lui invece spegneva, ogni volta. Ogni volta che ti avvicinavi. Ogni volta che chiedevi. E lo vedevi sempre più lontano. Lontano fino a nascondersi in un ripostiglio che tenevi nell’angolo più inaccessibile della tua mente, del tuo ricordo, seppellito dalle foglie e dagli stracci della vita. Avevi gettato lontano la chiave, che invece era ritornata tra le tue mani quando ti avevo detto di essere incinta. Avevi paura. Pianificavi tutto quello che avresti fatto, che avresti detto. Poi tutto svaniva, la realtà non è i nostri desideri, i nostri piani. È la realtà, dicevi. E così mi avevi telefonato dal lago, quella sera. Avevi freddo e sudavi. Dovevi tornare e non avevi detto niente a tuo figlio. Non avevi detto niente a te stesso, cioè. Volevi dargli forza e sicurezza, sulla vita, essere un grande padre. Ed eri caduto nella trappola. Tutte quelle parole morivano dentro di te prima di uscire fuori. Troppo grandi, troppo pesanti, per un bambino di dieci anni. E la paura ti aveva morso. Una scossa rovente nella pancia. Ti ho sentito respirare, in quel bosco lontano. Neanche a me sei riuscito a dire niente. Un concentrato d’aria usciva dai tuoi polmoni a fatica. Quella che hai tolto a nostro figlio. L’ho capito dopo, quando non sei rientrato e ho chiamato la polizia. Ti hanno ritrovato nel lago. Poi hanno trovato Jimmy. E io ho perso me. Ho perso la luce e l’ombra, il sangue e la carne. L’ho capito dopo, quando non sei rientrato e ho chiamato la polizia. Ti hanno ritrovato nel lago. Poi hanno trovato Jimmy. E io ho perso me. Ho perso la luce e l’ombra, il sangue e la carne. Non ricordo più, dopo. Un buco, una ragnatela di nulla. Così ho preso un martello e ho distrutto tutto. La mia casa, mattone dopo mattone. Il mio corpo, vene, pelle e budella. Ho vomitato, ho asciugato tutto, mi sono seccata. Sono andata in letargo. Ho aspettato. Atteso silenziosa. Che arrivassero i primi segnali, i primi movimenti sotterranei. Che una piccola radice sentendo l’umidità della notte venisse di nuovo fuori. Ed eccomi qui adesso. In questo posto assurdo, alla soglia dei miei cinquant’anni, che sono arrivati così, alba dopo ogni tramonto. Un posto che nessuno sceglierebbe per festeggiare. Infatti non l’ho scelto, è il posto che ha scelto me e mi ha attirata con la sua voce. Una voce fatta di vento e di foglie marce, le foglie ormai cadute da tempo sulla riva di un lago. Laura Di Biase A questo link potete trovare tutti i racconti pubblicati.
È tempo di Natale. Tempo di un libro davanti al caminetto mentre fuori nevica. Un periodo nordico, come nordico è il libro di cui vogliamo parlare oggi. Si tratta di Joe Speedboat di Tommy Wieringa, Iperborea edizioni. Questione di pelle: “Joe Speedboat” di Tommy Wieringa, Iperborea edizioni 2009 vs 2015. La casa editrice Iperborea nasce nel 1987, con l’intento di fare conoscere ai lettori europei la letteratura nordica. A Emilia Lodigiani, fondatrice di Iperborea, è apparso chiaro che i suoi libri dovessero distinguersi dal mare editoriale in cui navigavano. La scelta, quindi, fu quella di dare ai libri Iperborea una particolare connotazione fisica, che li avrebbe subito resi differenti, o meglio: una novità. Stiamo parlando del caratteristico formato super-verticale. Come un mattone di cotto. Strettissimo e lungo, 10×20 cm, ispirandosi al formato tradizionale del mattone di cotto. Una sorta di misura modulare ed elementare, che rappresenta l’unità prima sulla quale si è – in un certo senso – costruita tutta la nostra civiltà. A prima vista, può capitare di pensare che questa forma longilinea possa risultare scomoda al lettore: ma si aprirà? Come faccio a sfogliare le pagine? Devo inclinare la testa ogni volta che arrivo a fine riga? Accadeva in minima parte con la vecchia impostazione di Iperborea. Per esempio, la prima edizione di Joe Speedboat (2009) può risultare un po’ difficile da maneggiare. Stiamo parlando di un volume importante, più di 300 pagine, che diventa di difficile consultazione, specialmente dopo la metà del libro; le pagine finali tendono a sfuggire dalle mani, il libro rimane difficilmente aperto e, in effetti, bisogna leggerlo quasi come un manga: senza aprirlo del tutto e assumendo con la testa l’angolazione migliore per leggere fino all’ultima lettera della riga. Il restyling del 2015. Problema che, di certo, non si riscontra con la nuova edizione di Joe Speedboat, del 2015, anno in cui Iperborea ha rinnovato grafica e materiali raggiungendo un netto miglioramento estetico e funzionale. I progettisti di Studio Xxy, firma del progetto di restyling grafico, si sono dedicati con particolare attenzione alla scelta della carta. Divertendosi a sezionarea metà un volume Einaudi, fino a ridurlo alle stesse proporzioni di un Iperborea, hanno appurato che il moncherino rimanente non era comodamente sfogliabile. Il problema tecnico non era dato tanto dal formato, bensì dallo spessore della carta. In sostanza, la grammatura comunemente usata per i volumi di formati “standard” non è adatta al formato di Iperborea. Studio Xxy si è, quindi, per una carta Imitlin di Fedrigoni, una carta pregiata, ma, allo stesso tempo, ruvida, che sa di tela d’artista, trasformando ogni libro Iperborea in una piccola opera d’arte. Inoltre, la nuova carta è più morbida, permettendo di “squartare” (come dice la stessa casa editrice) il libro, aprendolo più facilmente e leggendo con più gusto. Il formato super-verticale non è solo potenziali difetti. Anzi! La gabbia allungata rende più rilassante la lettura, che va a capo più volte; inoltre, i libri stretti sono facilissimi da tenere con una mano, per gli amanti delle letture “on the road”. Il formato di Iperborea si odia o si ama, ma, a mio avviso, dopo il restyling è molto più facile amarlo. “Joe Speedboat” di Tommy Wieringa. Finalmente parliamo di Joe Speedboat. Ve lo dico subito: un libro meraviglioso. Oserei dire uno dei miei romanzi preferiti. Per chi ama le epopee, le grandi avventure, i romanzi di formazione alla Stevenson, il libro dello scrittore olandese non deluderà le vostre aspettative. Un accenno alla trama. Molto brevemente: Fransje è un ragazzo che, dopo un incidente, si ritrova bloccato su una sedia a rotelle, che può spostare grazie al suo braccio destro, l’unico arto ancora mobile. Nel paese di Fransje si trasferisce un misterioso e affascinante ragazzo che si fa chiamare con un soprannome: Joe Speedboat, appunto. I due fanno subito coppia, e si perdono in strabilianti avventure. Non vi anticipo nulla, ma di mezzo c’è anche un campionato di braccio di ferro. Straordinario. Cambio di titolo, cambio di immagine. Possiamo notare che dalla prima alla seconda edizione per conto di Iperborea, oltre all’immagine, cambia anche il titolo. Da semplicemente Joe Speedboat, si passa a Le avventure di Joe Speedboat (raccontate da un campione di braccio di ferro). Ma dicevamo, soprattutto cambia l’immagine (oltre alla grafica, di cui parleremo nel capitolo successivo). Benché la figura del bambino sull’aeroplano della prima edizione sia forse più rappresentativa del libro (per chi leggerà), la nuova immagine spicca per i suoi colori armoniosi. Iperborea ha infatti sempre manifestato grande gusto cromatico nelle sue copertine. Se le mettessimo tutte in fila e le guardassimo da lontano, sembrerebbero piccoli pixel color pastello, freddi, algidi, ma al contempo accoglienti; formerebbero un grande quadro paesaggistico, riassumibile con le parole “Grande Nord”. La grafica. Fin dalle prime edizioni, le copertine di Iperborea hanno dimostrato originalità con le immagini a vivo, che in quel tempo ancora nessun editore applicava. Dal 2015, le immagini delle copertine si estendono, fino a girare intorno a tutto il libro, andando a occupare anche i (nuovi) risvolti che impreziosiscono l’edizione. Cambia la collocazione del titolo del libro, che ora si trova su un fondo a tinta unita, generalmente in armonioso abbinamento con i colori dominanti dell’immagine di copertina. Scelta apprezzabile, che rende più leggibile i caratteri, rispetto alla vecchia scelta di testo bianco direttamente sovrapposto all’immagine. Il font. Anche il font di Iperborea ha subito una trasformazione dopo il restyling del 2015. Prima era un graziato, del tutto simile a un Garamond allungato (e come poteva non esserlo?) in verticale. Adesso (anche se la nuova edizione di Joe Speedboat conserva ancora il vecchio font) si è passati a un bastone, sempre maiuscolo: più massiccio, più leggibile, forse più attuale. Lo possiamo vedere nella copertina de Il re dell’uvetta di Fredrik Sjöberg (2016, P.S.: divertentissimo libro anche questo!). Il logo. Per finire, è stato cambiato il logo stesso della casa editrice. Prima era una runa che sormontava il nome della casa editrice. La runa si è evoluta, abbandonando il testo scritto, passando da segno a simbolo. Autosufficiente. In breve: Font: 8 Immagine: 7 Titolo: 8.5 Complessivo: 7.8
Quarto racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo il racconto del cavaliere inesistente! Il cavaliere inesistente (oppure no) e il vecchio musicista (oppure no) di Manuela Romeo Non è il gatto parlante a sorprendermi: ne è piena la letteratura. Non è l’austerità della pietra grigia a incutermi soggezione: mi fa sentire a casa. Non è il canto lontano delle rane a turbarmi: di acquitrini sono piene le campagne battute dai cavalieri, la loro nenia mi rasserena. A crearmi imbarazzo è qualcosa che non comprendo. Quale incantesimo mi ha condotto qua? Non so più chi sono. A crearmi imbarazzo è qualcosa che non comprendo. Quale incantesimo mi ha condotto qua? Non so più chi sono. Mi trascino in salita tra le case che il tempo ha gettato come per scherzo, a manciate, sui colli intorno a me. Dame e baroni, contadini e artigiani, cavalieri di tutti i tempi devono essere passati di qua. E anch’io, che mi porto addosso il peso di un’armatura che mi schiaccia le ossa che non ho. Dentro questo involucro di ferro che emette suoni striduli, io sono vuoto, disfatto, consistente di niente. Non che io sia frivolo o privo di sostanza e significato: sono un cavaliere ricco di idee e curiosità. Ad esempio un paio di giorni fa, nell’ora del tramonto, proprio qui, davanti alle grandi fontane della piazza, un tale dall’aria misteriosa ha attirato il mio interesse. C’era qualcosa di severo e malinconico nel suo portamento. Quasi pelato, sull’ottantina, se ne stava seduto a un tavolo della Ciassa con le gambe accavallate, cellulare in mano, ogni tanto allungava le braccia e le incrociava sul petto o dietro la nuca. Non riusciva a star fermo. Quasi pelato, sull’ottantina, se ne stava seduto a un tavolo della Ciassa con le gambe accavallate, cellulare in mano, ogni tanto allungava le braccia e le incrociava sul petto o dietro la nuca. Non riusciva a star fermo. Si guardava intorno, non rideva, né sorrideva, la sua bocca conosceva solo la smorfia del beffardo seduttore. Fingeva premure nei confronti degli occasionali interlocutori ma accendeva uno sguardo che diceva “Che ne sai della mia vita? Sono mica uno qualunque io. Vengo dritto dritto da un set di Hollywood e posso legarti a me in un istante, per la vita, fosse anche per un mio capriccio. Fai bene a temermi, potrei diventare la tua ossessione”. Corteggiava tutte le donne del paese, di tutte le età, ma esibiva con più evidenza una seduzione nei confronti di se stesso, in fondo era innamorato pazzo solo della propria arte. Lo manifestava canticchiando arie d’opera, muovendo le belle dita sul muretto come sulla tastiera di un pianoforte e mimando, occhi chiusi, la direzione di un grande concerto per orchestra. Ce la metteva tutta perché voleva piacere e giocava tutte le sue carte per catturare l’attenzione altrui. Non aveva conquistato la mia simpatia, ma di certo la mia curiosità. Era un personaggio sui cui valeva la pena indagare o che poteva fornirmi indizi utili per fare chiarezza su che cosa facessero un cavaliere inesistente e un vecchio sciupafemmine in un posto come questo. Così, stamani, rieccomi sulla piazza del borgo a fissare il castello sonnolento e la torre col suo orologio severo. Prima o poi, il mio uomo passerà di qua. Il gatto parlante attraversa la piazza senza parlare, mi strizza l’occhio. Che mi legga nel pensiero? Eccolo, il mio uomo, appare all’improvviso come il primo violino di un’orchestra e avanza immaginandosi gli occhi di una platea infinita addosso. “Per caso ha visto vagabondare un gatto nero?”, la voce è chiara, ma non profonda. Che sia un tenore? Mi chiedo. “Da ieri avrò incontrato almeno una decina di gatti, almeno cinque o sei erano neri. Forse lei si sta riferendo a un gatto in particolare, con qualche caratteristica curiosa e insolita?”, chiedo al mio interlocutore che si avvolge in un unico gesto solenne e deciso nel suo anacronistico mantello di raso. “Beh, sì, insomma, trattasi di un gatto speciale, potrei dire magico.” “Ma certo, caro signore, questi, si sa, sono luoghi in cui tanto tempo fa streghe e megere furono perseguitate, processate e massacrate o arse vive sotto gli occhi della folla crudele, bramosa di atrocità e fatti di sangue. Queste creature del demonio, si dice, si sono poi impossessate delle anime dei gatti neri e le hanno moltiplicate nel fluire delle generazioni”. “Già, ma il gatto che cerco io è buono e simpatico” dice “La sola cosa che lo distingue dagli altri gatti è che, se gli gira, ha un mucchio di storie da raccontare.” Il mio uomo ora è sceso dal podio della sua solitudine, si guarda attorno sornione. “Eccolo”, esclama ad un tratto. “E’ quel gattone laggiù, proprio ora sta inarcando la schiena e sta stiracchiandosi. Lo vede?” Avevo bisogno di quel gatto, creatura buona o malvagia che fosse: era l’unico che potesse aiutare sia me, sia il mio nuovo compagno, un vecchio musicista oppure no. Quel diavolo d’un gatto mi passa davanti muovendo le anche come un divo e pretendendo attenzione. “Vuole che lo seguiamo, ci porterà in qualche luogo segreto e magico, vedrai. Dai, andiamo”, non esisto, ma so trovare un timbro di voce convincente, all’occorrenza. Il presunto vecchio musicista sembra non aver notato che sono un’armatura senza uomo, gli sembra normale il vuoto che mi riempie, il niente che mi appartiene. Sa guardare oltre, si vuole fidare di me, perché anche lui ha bisogno di andare in fondo a questo mistero. Ci incamminiamo fianco a fianco, io cigolando lui intonando una qualche melodia, prendendo la salita ripida e disconnessa che conduce in cima al paese, dentro il grappolo di case. Non incontriamo nessuno lungo il sentiero, non udiamo voci, non si aprono porte o persiane. Anche i fantasmi stanno attenti a non essere maldestri, in
Una volta ero a Genova per fare un seminario di letteratura e a me a Genova, non so perché, la gente, mi sembrano tutti un po’ squinternati, e ai ragazzi che facevano il seminario, quando ho letto dei pezzi dal Repertorio dei pazzi della città di Palermo, di Roberto Alajmo, ho chiesto ai ragazzi che facevano il seminario “Ma perché non fate il Repertorio dei pazzi della città di Genova? Paolo Nori Cos’è un repertorio dei matti? A prima vista sembrerebbe un seminario di scrittura creativa. Paolo Nori, il curatore del seminario, sembrerebbe di fronte a semplici aspiranti scrittori, pronti a cimentarsi in nuove prove. Invece, Nori è di fronte a dei cronisti medievali, che racconteranno quello che succede oggi. E ogni scrittore dovrà rinunciare al proprio stile, per dare vita a un prontuario omogeneo dei matti della propria città. Chi sono i matti? Il matto viene prima dello scrittore, dell’astrologo, dell’alchimista; in qualche modo, è la figura archetipa, l’esempio che costoro imitano. È ovvio che non si valuta un matto: non si dice “costui è un matto bravo”, non ci sono matti migliori di altri; un matto è un capolavoro inutile, e non c’è altro da dire. Giorgio Manganelli Chiariamo che non si parla di matti “veri”. Più che veri, non si parla di matti “seri”, ossia quando la pazzia porta serie devianze fisiche e mentali, e altrettante serie conseguenze. I matti di cui si scrive al Repertorio dei matti sono altri. Matti sono coloro che su un attraversamento pedonale con semaforo verde non attraversano se non hanno visto, con i loro occhi, scattare il verde e allora aspettano il giro successivo cercando di darsi un tono. Matti quelli che, per non far vedere che si possono permettere gli abiti griffati, quando noti che ne indossano uno dicono “ah sì , era la sola cosa stirata che avevo nell’armadio”. O quello che in un racconto di Andrea Bajani cerca sempre di pagare con dieci euro falsi e poi, se lo scoprono, si scusa e tira fuori quelli veri. Ne abbiamo tutti un elenco. Siamo sicuri che lo avete anche voi, un vostro elenco personale di matti. Sì, ma quanto si deve scrivere? I Repertori dei matti sono brevi documentari. Cose del tipo: C’era uno che passava le giornate affacciato alle finestre aspettando l’incidente. O un poco più lunghe: C’era uno che tutte le sere andava a sedersi su una panchina davanti al tramonto. Fissava il mare, l’orizzonte e aspettava con pazienza che il sole sparisse. E tutte le sere ci rimaneva male. Comunque non si va mai oltre la pagina. Ma ognuno scrive di più matti, e tutti i matti si mischiano dentro queste magiche antologie che raccolgono gli scarti di ogni città italiana. Gli scarti che forse, come il grasso che cola, sono anche il meglio di quelle città, ciò che le caratterizza. Lo voglio fare. Quando inizia? Il Repertorio dei matti della città di Genova inizia a Gennaio. Il corso si tiene durante due week-end, più un incontro conclusivo. È un’occasione unica e irripetibile; sarebbe da matti, lasciarsela sfuggire. Per tutte le informazioni dettagliate, vi rimandiamo a questa pagina. Uno soffriva talmente tanto doversi alzare presto la mattina che quando poteva dormire rimetteva lo stesso la sveglia, la faceva suonare e poi, con un ghigno di rivalsa, le diceva “Ma vai in culo!” e la spegneva rimettendosi a dormire. Gli estratti presenti in questo articolo sono tratti dal “Repertorio dei Matti della città di Livorno”, a cura di Paolo Nori, edito da Marcos Y Marcos (2016).
Terzo racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo il racconto della pittrice francese! La pittrice francese (oppure no) e il cavaliere inesistente (oppure no) di Annalisa Soldà Voici l’histoire. Sono sospesa nell’aria, da questa terrazza si vedono solo le cime delle colline. È un paesaggio diviso a metà. Metà verde e metà azzurro. Mi trovo nel verde di questa tavolozza. Bastarebbe una leggera pennellata verso l’alto… et voilà,un piccolo spostamento del pennello verso l’alto e sconfinerei dove i colori si mescolano, sarei prima in un vert-bleu, poi in un bleu un po’ sporco di verde e poi in un bleu assoluto. Il verde è tutto intorno al paese. Lo abbraccia come una cornice. Mi sporgo dal parapetto di ferro. Guardo giù. In basso è grigio pietra: strade, muri e tetti si confondono. Il sole colora di giallo solo la piazza e gli ombrelloni dei ristoranti. Fra i turisti seduti ai tavolini, una sagoma di ferro con un pennacchio in cima. È un cavaliere rinchiuso in un’armatura. In molti si voltano a guardare, ma nessuno lo ferma per sapere la sua storia. Mon Die! Je dis, se pa possible un chevalier con l’armatura e tutto il resto cosa ci fa qui ad Apricale? Dunq je attend, per vedere come se la cava. Una nuvola fa sparire il sole, la piazza diventa bianca, poi all’improvviso ritorna gialla. Il cavaliere è fermo in mezzo ad una chiazza di sole che si spegne e si riaccende. Decido di capire. Lo raggiungo, è alto come me. Gli dico: “Bonjour. La posso aiutare?” Lui non si muove. Mi avrà sentito? Come arrivano i suoni dentro un elmo? Allungo una mano per bussare sull’armatura. Una voce sottile deformata dal riverbero del ferro che la contiene, mi parla. “Mi perdoni se non mi volto a guardarla ma è difficile per me rimanere in equilibrio, se vado in avanti nessun problema, se mi volto rischio di cadere, può venire davanti all’elmo per cortesia?” Non è il tipo di voce che mi aspettavo da un cavaliere, ma non glielo dico per non sembrare scortese, dato che la cortesia è uno dei valori a cui i cavalieri tengono molto. Sono davanti a lui e muovo una mano per salutarlo. “Ca va bien?” Gli chiedo. “Mah!?!” mi risponde e non dice altro. Lo guardo, so che mi sta guardando. Resto in attesa per qualche minuto, poi di allontanarmi. Mi chiama. “Aspetti. Credo di sì. Di avere bisogno di aiuto. Vede, il mio è un problema singolare.” “Aspetti. Credo di sì. Di avere bisogno di aiuto. Vede, il mio è un problema singolare. So di essere venuto qui mosso da alti ideali, per portare a termine una missione. Ma, ecco, il mio problema è che non ricordo.” “Non ricorda?” “No. Non ricordo la missione.” “E tutto il resto?” “Neppure.” “E il suo nome?” “Nemmeno.” “Bel nome. Se original!” “No. Nemmeno non è il mio nome, o almeno credo, il mio nome non lo ricordo.” “Capisco.” “Davvero?” “Biensure. Ho il suo medesimo problema. Ma dato che non posso far nulla per me vediamo se posso fare qualcosa per lei. Per esempio l’elmo. Potrebbe toglierlo così ci sarebbero più possibilità che qualcuno la riconosca.” “Ho già provato. Non c’è modo.” “Ai ai ai… Mi faccia pensare. Un fabbro. Me ui. Il fabbro se la solution!” “No. No. Non voglio.” “Pourquois?” Ho paura. “Ma non è da lei. Un cavaliere che ha paura di un fabbro?” “Ma non è da lei. Un cavaliere che ha paura di un fabbro?” “Beh, ho paura.” “Se il fabbro non va bene allor, proviamo con qualcos’altro. Qualche elemento che potrebbe aiutarci. Che cos’ha lì?” “Questo?” “No. Non l’alabarda.” “Questo?” “Nemmeno lo scudo. No. Che cos’ha nella mano sinistra? Un manuale? Una mappa?” “No. È un libro. Di poesie.” “Se magnific! Mi fa dare un occhiata?” Lui senza dire nulla allunga il braccio verso di me, io prendo il libro, sposto una sedia e mi accomodo di fronte a lui. La copertina è di cartoncino ruvido di un celeste sbiadito con il titolo scritto a caratteri di colore nero che riproducono una scrittura in corsivo: “Poesie per una sposa” di Augusto Pontini. Lo sfoglio. Una dedica. La leggo ad alta voce: “A te. A nessun altro. Solo a te. Augusto.” Alzo lo sguardo verso il suo elmo e dico: Se Facil! Sei Augusto! “Mmmh… dici?” “Ma sì. Sei Augusto adesso dobbiamo solo capire a chi hai dedicato le poesie in modo che tu possa consegnarle alla tua amata. Era questa la tua missione.” “Ok. Ma come?” “Leggiamo le poesie. Leggo la prima” A volte chiudo gli occhi. I miei pensieri come rondini incrociate in voli sciocchi Il cielo ha il tuo colore Nel celeste, mio amore Si rinnova il mio ardore Nel celeste voglio stare Se tu mi vorrai amare. Chiudo il libro. Penso di avere intuito il nome della donna a cui sono dedicate le poesie. “Celeste.” Gli dico. “Bisogna cercare Celeste.” Mi alzo dalla sedia. Andiamo. Le strade sono strette, percorse dal vento che sale e che scende veloce su e giù. Domandiamo ad uomo che sta giocando a pallapugno: Mi scusi conosce Celeste? Domandiamo a una donna che ha un viso scolpito e un fazzoletto legato in testa. Domandiamo e domandiamo, ma questo paese è un rompicapo, si sale, si scende, si fanno scale, si volta a destra e a sinistra e alla fine a forza di camminare ci si ritrova da dove si è partiti. Inseguiamo il rumore di un tagliaerba, io raggiungo l’uomo e gli domando. Lui mi dice: “Sì, la conosco.” Inseguiamo il rumore di un tagliaerba, io raggiungo l’uomo e gli domando. Lui mi dice: “Sì, la conosco.” Arriviamo ad una porta di legno piccola e bassa come tutte le altre porte del paese. Sopra la porta in
Secondo racconto del nostro laboratorio estivo di Apricale 2016. Un gioco di ruolo narrativo durato cinque giorni. Ciascuno dei personaggi, delineati con una sorta di “binomio fantastico”, aveva il compito di scoprire e raccontare la storia di uno degli altri personaggi. Come? Scopritelo leggendo il racconto del bambino americano (oppure no)! Il bambino americano (oppure no) e la pittrice francese (oppure no) di Roberta Bracco Un gatto che parla. Wow! Come Puss in Boots di Shrek! Mi chiedo cosa abbiano tanto da preoccuparsi questi tipi assai più strani e incredibili di lui. Certo, qualcosa non torna: dove può essere finita mum? Mi sarò addormentato mentre facevo la conta e lei sarà ancora nascosta da qualche parte? O forse mi avrà iscritto lei a questa specie di caccia al tesoro e salterà fuori solo alla fine? Tanto sono libero, dai! Quasi quasi salgo un pochino sulla fontana, o corro fino agli orti fuori le mura o mi infilo sotto questo tavolo e vado a tirare la coda a quel cane che dorme, così magari trovo anche un compagno per giocare a palla più sveglio di questi. “Nessuno ha qualcosa in contrario, giusto? Forse tu, bella signora dagli occhi azzurri?” Silenzio, lei non mi guarda nemmeno. “Il gatto ha detto che tocca a me trovare la tua storia, ma puoi fidarti sai? Io sono un vero esperto di storie. Conosco a memoria tutti i film di Walt Disney, non potrà essere così difficile trovare una storia per te.” Ancora niente, proprio non c’è verso di smuoverla. “Ehi, mi senti, sono qui in basso, non vedi? – ritento – Non fingere di non vedere che continuo a tirarti questa tua gonna nera, che ti fa sembrare una vecchia. Insomma, ti muovi, per favore? What’s up? Dobbiamo vincere la caccia al tesoro, ti vuoi decidere a darmi la mano? Magari se io trovo la mia mamma finisce persino che tu riesci a trovare il Principe Azzurro e diventi un po’ più felice…” Fa una smorfia terribile. Per un attimo ho paura che voglia uccidermi proprio. Ok, magari provo con una voce un pochino più dolce. “So che non ricordi niente, darling, ma non devi essere triste per questo. Pensa a me, che sono piccino e senza mamma e devo anche occuparmi di te. Preferirei scoprire come ha fatto quella bicicletta ad arrampicarsi fino in cima al campanile. Ma a noi ora tocca stare insieme. Quindi, let’s go. Il gatto ha detto che sei una pittrice francese. Perciò adesso noi ci sediamo a questo tavolino e tu fai un disegno per me. Se ti tira su posso darti un bacio, anche se io, di solito, non le bacio mica le ragazze!” Si scosta brusca ma alla fine mi segue e dice qualcosa che non capisco, in una lingua che però ha un suono dolcissimo. Magari salterà fuori che questa tipa è una sirena e mi toccherà pure riportarla al mare. Si mette al lavoro in silenzio e poi mi allunga un foglio. Sussurra ancora qualche parola con quella sua voce che sembra far le fusa, non so perché, mi fa stropicciare tutta la faccia. Quando mi riprendo, Quando ha finito guardo il disegno e non mi piace: ha fatto solo case arrampicate con forme strambe, buie come i suoi vestiti. ”Non puoi fare qualcosa di meglio? Non c’è nessun colore qui!” Mi sa che devo averla offesa perché di colpo si mette a piangere e mi allontana “Laisse-moi tranquille! Non sai di cosa parli… Io… ho perduto tutti i miei colori…!” “Cosa vuol dire perduti? You mean che non li trovi più?” Non mi risponde. La tiro forte per un braccio, per convincerla ad alzarsi. Devo trovare un modo, comunque. Non può esistere una pittrice felice senza colori. “Stop crying, my friend! Ti aiuterò io a trovare i tuoi colori!” Mi prende per mano, finalmente: questo è il momento di insistere. “Vieni, muoviamoci di qui. Ho appena visto un passaggio segreto che ci porterà velocemente oltre queste case grigie di pietra, in un posto coloratissimo. Inizieremo a cercare da lì. Dammi la mano e non avere paura. È una via stretta e c’è puzza di pipì di gatto, ma tu sei magra e ci passi.” Quando siamo dall’altra parte, le chiedo come fa la gente, secondo lei, a vivere in questo posto così piccolo senza McDonald’s, centri commerciali e neppure una gelateria. Mi sa che non capisce e non mi ascolta neanche: fissa i tetti delle case come se non fossero tutti uguali. Anyway, mi sa che sta cominciando a sentirsi una vera pittrice: si è fermata a disegnare ancora. “Fa’ vedere un po’? Bello, questo! Wow! Sempre un po’ scuro, ma I love very much quella buffa casetta con mulino. La conosci?” “Peut-etre”, sussurra, e sembra perplessa. Intanto, eccoci fuori dalle mura. Finalmente un po’ di colori. “Ci arrampichiamo su quell’albicocco lassù per vedere le rondini?”, propongo, ma lei non mi pare affatto convinta. Corro ad arrampicarmi – se non altro per mettere qualcosa nello stomaco, visto che lei a mangiare non ci pensa proprio – quando mi accorgo di qualcosa di strano. “Un momento, guarda, non noti niente? Confronta il tuo disegno con questo angolo qui! Se provi a immaginare la tua casa piccina al posto di quest’albero, il luogo che hai disegnato è lo stesso. I tetti delle case vicine combaciano perfettamente, isn’t it? Non è che vivevi qui? Ma la casa che era al centro del disegno dov’è finita? Presto, dammi una mano a scendere. Dobbiamo rientrare in paese e chiedere notizie della casetta mulino. Sento che è la strada giusta, trust me.” Rotolo a tutta velocità giù dal sentiero e mi infilo nella prima casa che vedo. Sono fortunato: trovo due vecchietti che di certo devono abitare qui da tanto tempo. “Scusate, siete di Apricale? Sapete dirmi se un tempo laggiù c’era una casetta con mulino?” “Certo, bambino”, mi risponde gentile il signore, abbassando il giornale, “una casa abbandonata da prima che tu nascessi, però. È andata distrutta qualche anno fa,
Per la serie di post Questione di pelle, analizziamo la copertina dell’ultima fatica di Don DeLillo: Zero K, pubblicato da Einaudi nella collona dei “Supercoralli”. Questione di pelle: “Zero K” di Don DeLillo, Einaudi, 2016. Bisogna dire che qualunque titolo – anche il decimo pezzo della saga di Twilight – sembra subito un classico, se a pubblicarlo è Einaudi. Gli ingredienti sono pochi, semplici e immortali: il bianco di sfondo, un’immagine centrata, una scritta asciutta. Che la copertina sia rigida o morbida, i libri Einaudi sembrano sempre pronti per entrare nello scaffale di una biblioteca e restarci per sempre. E spesso lo fanno. L’ultima perla di Don DeLillo è certamente ben inquadrata all’interno della collana Einaudi. Pochi altri editori avrebbe potuto restituire a uno dei più grandi scrittori americani viventi una veste degna del suo Zero K; un libro che porta con sé gli ingredienti che lo consacrano già a classico per licei: distopia, futuro ma non troppo, grandi temi come l’immortalità e le nuove tecnologie, senso metaforico, frasi ispirate. I Supercoralli Einaudi. Zero K abita la collana dei “Supercoralli” di Einaudi, istituita da Cesare Pavese poco prima degli anni ’50. “Supercorallo” vuol dire un punto fermo della letteratura (che sia italiana o estera), in genere ancora più fermo di un semplice “Corallo”. Possiamo dire che il titolo si prepara quasi certamente a entrare nei “Millenni”. I “Supercoralli” hanno principalmente tre opzioni di veste grafica: La classica impostazione bianca con immagine centrata (quella che analizzeremo a breve); Un’immagine espansa a piena pagina (con foto al sangue), che funge da sfondo al titolo e autore. Talvolta, come in questo caso de L’uomo che cade, titolo e autore lasciano la loro posizione alta e centrata, a favore dell’immagine di sfondo; L’immagine come banda passante su sfondo bianco, un’interpretazione più attuale della classica gabbia centrata che possiamo vedere appliacta in Candore di Mario Desiati (2016). I font Einaudi. Parliamo due secondi del font Einaudi. Senza addentrarci nel dibattito del font utilizzato per i testi interni (anche se pare definitivamente che sia un Simoncini Garamond, anche detto Einaudi Garamond), osserviamo com’è scritto il titolo in copertina: Il font di copertina appare come un Helvetica Neue Bold, leggermente tirato in orizzontale. Per i fan della bianca, un font poco graziato potrebbe stonare con lo stile Einaudi. Se devo dirlo, analizzando il font a sé stante, non lo trovo squisito nemmeno io: le lettere sono larghe, stretchate in orizzontale. Ma riconosco all’Helvetica l’imponenza necessaria a dare peso a un titolo. La distinzione tra titolo del libro e nome dell’autore viene resa palese ai minimi termini. Einaudi cambia giusto il colore (nero / rosso). Stessi punti tipografici, allineamento a lapide. Ringraziamo comunque dell’accorgimento, perché nei primi “Supercoralli” non era concesso neanche il cambio di colore, lasciando spazio a possibili ambiguazioni. Immagine e Immortalità. La scelta del soggetto per l’immagine di copertina è a dir poco azzeccata: è intitolata Sime ed è opera del fotografo Jasper James. Lo scatto della statua vuole farci capire subito e bene il tema del libro: l’immortalità. E cosa meglio di una statua classica – fredda e pietrificata – può farci immaginare cosa voglia dire uno stato di criogenesi, il congelamento necessario per arrivare nel futuro, oltre il proprio tempo? L’impaginazione grafica. Proviamo a entrare nel merito dell’impaginazione con qualche speculazione. Sappiamo che è facile avere una copertina bianca e un’immagine potente; meno facile è sapere come collocare l’immagine all’interno del vuoto. Si può notare una cosa interessante. L’area rossa indica la sezione aurea della copertina, ottenuta riportando la dimensione della base sull’altezza. Salta all’occhio che il naso del viso cade proprio sulla linea di demarcazione del quadrato rosso: si trova quindi in sezione aurea con la dimensione totale della copertina. Otteniamo di conseguenza che la linea del naso divide perfettamente a metà la copertina, e la linea orizzontale degli occhi fornisce l’ascissa del nostro sistema. Nonostante il volto di pietra non sia visibile nella sua interezza, esso è collocato in modo da costituire il centro focale della copertina. Saranno pure speculazioni. Però anche nelle riconosciute proporzioni del volto, la radice del naso si trova in sezione aurea con l’altezza del volto: tracciando un cerchio che ha come diametro la larghezza del volto, la radice del naso si trova sulla circonferenza del cerchio, esattamente nel centro di esso. In conclusione. Il volto di pietra di Zero K è perfettamente proporzionato con se stesso e con la sua copertina. Volute o casuali, queste coincidenze geometriche donano un grande senso di pace; una fermezza, una quiete degna di un grande classico. Nonostante sia stato appena pubblicatob (e noi siamo andati ad ascoltarlo al Ducale). “Zero K” è un libro sulla percezione. DeLillo riesce a far parlare i morti (in 1ª e in 3ª persona, contemporaneamente). #ZeroK #DonDeLillo — Officina Letteraria (@OfficinaLettera) 26 ottobre 2016 In breve: Font: 7 Immagine: 9.5 Titolo: 10 Complessivo: 8.5
Vi siete mai avvicinati a un autore sconosciuto, solo perché il suo libro aveva una bella copertina? Avete mai comprato un libro perché sarebbe stato proprio bene tra i vostri scaffali? Accarezzate i libri, mentre li leggete? Scegliete un ebook perché la copertina vi ha ammiccato dallo store? Perché una buona copertina? Da sempre la confezione di un libro – dalla copertina, passando per la carta, il formato, i colori, i font – influisce in modo significativo sulla promozione del titolo e sul successo di un titolo. Ogni casa editrice cerca di sviluppare un proprio linguaggio estetico; in questo modo, i libri della casa editrice sono più riconoscibili. Tramite una buona copertina è possibile comunicare al lettore di cosa tratta il volume in questione, ma non solo. È una comunicazione visiva, che prescinde dal linguaggio verbale, ma che si esprime attraverso forme e colori. Insomma, è una questione di pelle! In questa rubrica, proveremo a “smontare” la copertina di un libro, cercando di capire le dinamiche grafiche e – di sponda – editoriali che hanno portato a quel risultato. O semplicemente, spiegheremo perché quella determinata pelle è adatta al contenuto o perché, secondo noi, non funziona. Gli articoli. Il primo appuntamento è con Don DeLillo e il suo Zero K (Einaudi editore, 2016).
Edicolibro è uno spazio per scambiare libri. Vi suggeriamo di portare a Edicolibro quei libri che, per voi, sono importanti, in certo momento. Potete portarne da 1 a 3 e prenderne altrettanti in cambio. Se vi va, sul frontespizio potete scrivere le ragioni che vi hanno portato a condividere quel libro, invece di un altro. Cos’è Edicolibro. C’è una piazza, a Genova, che da un po’ di tempo era più vuota del solito. È nel cuore del centro storico, e accoglie uno dei palazzi più belli della città, ma lì, proprio al centro, il crocevia di storie e voci era venuto meno. Così la immaginiamo, l’edicola. Un viavai di scelte, il solito giornale, anzi no, oggi cambio, cosa c’è di nuovo? Un viavai di chiacchiere, del più e del meno, le stagioni che cambiano, i bambini e le bambine che escono da scuola, e la sera chi porta a spasso il cane. Un viavai di parole scritte, parole lette. In questa piazza, piazza della Meridiana, da qualche tempo si è ridata vita all’edicola. A Edicolibro, talvolta capita che accadano altre cose, come reading o Laboratori di scrittura en plein air. Chi anima Edicolibro. Edicolibro è una rete di associazioni che operano con il patrocinio del Municipio Centro Est: insieme a Officina Letteraria, ci sono A.M.A. Associazione Abitanti Maddalena, Collettivo Linea S, Fischi di carta, Progetto Santiago, Scuola Daneo, Scuola don Milani, UDI Unione Donne Italiane. Quando c’è Edicolibro. Il calendario di Edicolibro cambia e si aggiorna di mese in mese: puoi sapere le aperture in corso leggendo qui sotto, o nella pagina Facebook, o sul calendario che appendiamo all’inizio di ogni mese all’esterno dell’edicola. Ti aspettiamo! Calendario di novembre 2016: Sabato 19 novembre ore 10:00-12:00 con Officina Letteraria; Domenica 20 novembre ore 16:00-18:00 con il Collettivo Linea S; Venerdì 25 novembre ore 15:00-17:00 con UDI; Sabato 26 novembre ore 10:00-12:00 con AMA; Domenica 27 novembre ore 10:00-12:00 con Officina Letteraria.
Andrea Bajani entra nella libreria, la percorre in longitudine e si siede accanto a Emilia Marasco, di fronte alle persone venute lì a ascoltarlo. Poi prende il microfono nelle mani e, con un gioco di passaggi, parla, legge e risponde alle domande che lei gli porge, insieme al microfono, e a molti sorrisi. Introduzione. Genova. Via Luccoli 98r. Libreria L’amico ritrovato. Venerdì 4 Novembre. Ore 18 (e qualcosa). Godersi le cose belle a volte non è facile, non è facile non farsi prendere da una certa ansia di non riuscire a raccogliere tutte ma proprio tutte le pietre preziose che, con semplicità e onestà, Andrea Bajani tira fuori dalle sue tasche, presentando il suo ultimo romanzo. Forse sarà perché si intitola Un bene al mondo, e tutti quanti abbiamo, credo, disperatamente bisogno di trovare un bene, almeno uno, al mondo. Questo lo dice anche lui. E forse sarà perché, dentro al libro, Bajani ha messo proprio questo. Un bene al mondo racconta di un paese sotto a una montagna, a pochi chilometri da un confine misterioso, Un paese come gli altri: ha poche strade, un passaggio a livello che lo divide, e una ferrovia per pensare di partire. Nel paese c’è una casa. Dentro c’è un bambino che ha un dolore per amico. Lo accompagna a scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin dove l’infanzia resta indietro. E ci sono una madre e un padre che, come tutti i genitori, sperano che la vita dei figli sia migliore della loro, divisi tra l’istinto a proteggerli e quello opposto, di pretendere da loro una specie di risarcimento. Ma nel paese, soprattutto, c’è una bambina sottile. Vive dall’altra parte della ferrovia, ed è lei che si prende cura del bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa battere il cuore, che per prima accarezza il suo dolore. (Dalla bandella) La mia maestra di Officina Letteraria, Chicca Gagliardo, poco tempo fa ci ha detto che la letteratura è un dono. È stata Laura Bosio a definirla così. È quando puoi donare qualcosa che sei autentico, che vale la pena di provare a farlo arrivare agli altri. E Andrea Bajani questo libro stava aspettando di scriverlo da quarant’anni. Tutti sanno cosa è un bambino e tutti sanno cosa è un dolore, anche se per tutti è una cosa diversa. Vorrei scrivere un piccolo diario di quello che è successo davanti (e dentro) ai miei occhi durante la presentazione, vorrei che fosse una mappa capace di segnare almeno i punti cardinali, anche se le mappe, come le parole, stanno sempre un passo indietro a ciò che accade. Vorrei che ci fossero tre voci, che sono la voce delle domande di Emilia, la voce delle parole dell’autore e la voce della mia penna a riportare le risposte sulla carta. Un flusso di domande e di risposte. Da dove nasce l’idea di rappresentare uno stato d’animo, il dolore, come un qualcosa di concreto, di esterno a noi? Il dolore di Bajani ha una forma di carne e di ossa, ha fatto un balzo dal territorio interno, quello di cui siamo fatti, per materializzarsi letteralmente a fianco del suo padrone, il bambino. Insieme sono i protagonisti della storia. L’incipit letto dall’autore. C’era un bambino che aveva un dolore da cui non voleva mai separarsi. Se lo portava dappertutto, ci attraversava il paese per andare a scuola tutte le mattine. Quando arrivava in classe, il dolore si accucciava ai suoi piedi e per cinque ore se ne stava senza fiatare. […] Il dolore era fedele al bambino, ed era solo con il bambino che voleva giocare. Mentre il bambino pedalava, il dolore a volte correva più veloce di lui con la lingua che gli pendeva tra i denti. […] Quando arrivavano al ruscello, il bambino appoggiava la bicicletta contro il tronco di un albero. Poi cercava dei pezzi di legno e delle foglie, e con quelli costruiva una barca e lasciava che salpasse verso il mare. Il dolore gli portava le foglie e i rametti e si avvicinava alla riva per vederla partire. Quindi tornavano a casa passando per i boschi. […] La sera il bambino si lavava, perché così gli avevano insegnato. Poi si metteva il pigiama. Sua madre e suo padre guardavano la televisione, e quando lui si affacciava a piedi nudi per la buonanotte non si voltavano. Il bambino e il suo dolore si incamminavano lungo il corridoio, che la sera sembrava infinito. Quindi aprivano e chiudevano la porta della camera, e il bambino si infilava sotto le coperte. C’era un giaciglio accanto al letto perché il dolore avesse un suo posto e una coperta per ripararsi dal freddo. Ma il dolore non ci dormiva mai. Saltava sul letto e si addormentava appoggiando la testa sui piedi del suo padrone. A metà della notte si infilava sotto le coperte con il bambino e lo riscaldava alitandogli in faccia fino al mattino. E quando suonava la sveglia, la prima cosa che faceva il bambino, ancora prima di aprire gli occhi, era cercare il dolore col braccio. Il dolore di Bajani è una presenza reale, visibile, che si può toccare con le mani, vedere con gli occhi. Una creazione letteraria che costruisce una via più accessibile per capire ciò che, accadendoci dentro, a volte è impossibile da decifrare. Una idea geniale che è arrivata all’autore dopo un lungo periodo di grande difficoltà nella scrittura. Ci racconta che stava scrivendo un altro romanzo, ma non riusciva a finirlo. Racconta che era come essere finiti in un buco. E che questo lo stava facendo quasi impazzire. Per salvarsi da questo buco in cui era finito, in quel periodo dice di aver scritto cinquanta brevissime poesie, molte di più in realtà, ma dopo una attenta scelta ne sono rimaste cinquanta. Ha sempre letto e scritto poesia, ha iniziato così a scrivere. Ma non erano le poesie che l’editore stava aspettando di ricevere. Lui gliele ha mandate lo stesso, in una e-mail ha scritto: Forse
Anche il dolore – come la vita – non si può mettere in ordine alfabetico. Il dolore è un disegno senza colore, è un cibo senza sapore, è una consolazione, una difesa. Ci sono dolori che non fanno male a nessuno e altri che possono anche ammazzare. Ci sono dolori che si possono lasciare a casa quando usciamo e dolori che sono sempre con noi, ci seguono dappertutto. Ci sono dolori da chiudere a chiave e dolori da prendere in braccio. Ci sono dolori che qualcuno ci lascia e dolori che lasciamo a qualcuno. Un bene al mondo, l’ultimo libro di Andrea Bajani per Einaudi, comincia con il “C’era una volta…” delle favole per bambini anche se non è una storia per bambini. Il protagonista è un bambino, un bambino come tanti altri, come quello che siamo stati o che ci circola per casa; un bambino senza nome proprio perché è un bambino come ce ne sono tanti. Il bambino ha un dolore per amico che lo accompagna a scuola, nei boschi, lo consola e lo difende. Stare vicini al dolore di un bambino è la prova più difficile che possa capitare agli adulti. Andrea Bajani ci chiede di farlo, di essere vicini al dolore del bambino però ci accompagna, ci tiene per mano perché sa che certi territori sono difficili da attraversare e che è possibile solo se qualcuno ci tiene per mano. Entriamo in una casa e in un paese, osserviamo gli adulti con le loro miserie e le loro fragilità, osserviamo i bambini con la loro crudeltà e la loro innocenza, incontriamo la bambina sottile che lascia il dolore a casa, si lega i capelli sulla nuca e affronta con coraggio le situazioni. Sperimentiamo i confini, quelli della casa e del paese e i confini dello spazio nel quale si muove il dolore. Con il bambino cerchiamo di passare inosservati, di essere bravi, proviamo a scappare e a nasconderci, con il bambino sperimentiamo il vuoto, il silenzio che a volte è un posto sicuro. Con il bambino entriamo in un mondo in cui è più facile che siano i bambini a proteggere gli adulti piuttosto che il contrario. Con il bambino viviamo una emozionante storia d’amore che ci tiene con il fiato sospeso fino alla fine. Il racconto di Bajani chiede molto al lettore, gli chiede di sostenere una grande tensione, gli chiede di percepire quasi fisicamente la fatica che il bambino fa per mantenere un equilibrio, perché le cose non si rompano. Ma poi, c’è sempre un momento in cui qualcosa cede e quasi tutto va in frantumi. La fine è un nuovo inizio, non meno difficile ma ricco di possibilità. Le cose che si aprono e le cose che si chiudono fanno sempre un rumore caratteristico, quando si aprono e quando si chiudono. Il bambino lo sa e a un certo punto decide di raccontarlo, di usare le parole per descrivere il rumore che fanno le cose quando si aprono e quando si chiudono. E tutto cambia.