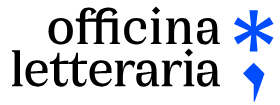La gonna della contessa di Clara Crovetto “La conosci la storia del baldacchino di Apricale?” esclama all’improvviso Gatto Bardo a Gatto Rosso, davanti alla loro biblioteca. “No ma invero non me ne importa gran che” di rimando lui. ”Fai male bello mio, è la più bella, intrigante, sanguinolenta storia della nostra Apricale, fatta di spie, di morti più o meno precoci, di battaglie legali, ma soprattutto di amori. E se ti dicessi che la gran contessa Cristina aveva un gatto grosso e rosso come te, ti attizzerebbe?” “ Ma non raccontare frottole, ammettiamo tu l’abbia visto in una foto: allora erano in bianco e nero, tutt’al più color seppia, COME FAI A SAPERE CHE ERA ROSSO?” “ Così sembra abbia scritto alla sua nipote- di rimando l’altro- quando era alla corte dello zar, ma sei troppo polemico, mi fai passare la voglia di raccontare”. “E vabbè, attacca un Do, e vediamo se mi intrighi” Gatto Bardo stupì l’amico, stupì assai: attaccò a sciorinare una lunga, lunghissima poesia, in rima baciata, come un vero cantore provenzale. “ La contessa Cristina era bella e un po’ pienotta, e perciò sopranominata la ‘Bassotta’.”. E così creò lì per lì, nella penombra della crosa che porta al Castello, un grande poema. Gatto Rosso era allibito: con la bocca semi aperta, il linguino fuori, e le orecchie moderatamente abbassate, seguiva il racconto rapito Da allora la stanza d’albergo detta Della Contessa, è la più ambita, con i due gattoni che si offrono per una foto ricordo sul lindo baldacchino bianco. Nasce, inoltre, nel borgo, un’ incantevole compagnia teatrale itinerante che, ancor ora, su tutta la costa ponentina ligure offre spettacoli in versi, nello stile degli antichi trovatori provenzali, che narrano di gesta, amori, motti frizzi e lazzi di quella terra.
Prefazione Apricale è un luogo del cuore per noi di Officina Letteraria, lo è da quel primo laboratorio quasi a fine estate nel 2012. Arrivare nella piazza di Apricale è come entrare nello spazio di una storia. Bisogna addentrarsi per i vicoli, salire e ancora salire, andare al vecchio frantoio, al castello della Lucertola, bisogna parlare con gli anziani e con i bambini, bisogna ascoltare quello che anche le pietre hanno da raccontare. Solo allora troveremo una storia. Per questo il laboratorio ha conservato nel tempo il titolo originario: Cercatori di storie. Chiudiamo l’anno pubblicando i brevi racconti di Apricale 2017 scritti da Alessandra, Angela, Clara, Cristina, Lena, Marco. Racconti nati da spunti e appunti visivi, racconti semplici e un po’ surreali, perché così si diventa quando si arriva ad Apricale. Marco, apricalese doc, si è assunto il ruolo di cronista del laboratorio e Lena, svedese che vive in Germania, ha partecipato anche come rappresentante della comunità di stranieri che frequentano il paese da tanto tempo. Lei ha imparato l’italiano per amore di Apricale. Leggi i racconti di Apricale!
Il bosco odorava di more selvatiche. Un riccio, poco più grande di una zucca, si faceva strada nel sottobosco umido, in cerca di vermi e lombrichi carnosi. A un tratto sollevò il muso e corse via zigzagando tra le foglie. Gretel fece un balzo e soffocò un grido. ― E’ solo un riccio. La apostrofò Hansel, sbuffando sonoramente. ― Shh… ho visto un’ombra, lì, dietro quel tiglio. Ho paura. Gretel si aggrappò al braccio del fratello e si guardò attorno tenendo una mano sulla bocca. Il bosco scricchiolò nella luce del pomeriggio e un lembo di rosso spuntò da un cespuglio di rovi. ― Ma è solo una bambina! Gretel scoppiò in una risata aperta e la bimba si rivelò del tutto. ― Scusate se vi ho spaventato. Mi sono persa, ho sentito dei rumori e temevo fosse il lupo. Hansel e Gretel si avvicinarono alla bimba facendo scricchiolare le foglie secche. Un sol boccone di Antonella Botti ― Io mi chiamo Hansel e lei è mia sorella Gretel. Non abbiamo visto nessun lupo. Girovagavamo nel bosco, poi abbiamo sentito un profumo invitante di burro e zucchero e abbiamo seguito la traccia fin qui. ― Mi chiamano Cappuccetto rosso, non ho nulla da mangiare. Mostrò un cestino vuoto e aggiunse. ― Sento che il lupo mi sta seguendo. Si voltò verso nord con le mani strette sul cestino, le nocche chiare, gli angoli della bocca all’ingiù. ― Mia nonna abita oltre il fiume, stamattina abbiamo mangiato le focacce al miele ― abbozzò un sorriso ― mi sembra passata un’eternità. ― Vieni con noi, segui questo profumo. Lo senti? Gretel allungò una mano aperta verso Cappuccetto rosso. Le bimbe sorrisero. I tre si presero per mano e si addentrarono nel bosco. Camminarono il tempo che impiega un tasso a scavare una galleria profonda e ritrovarono quel profumo. A occhi chiusi la seguirono, mani sudate e testa in su. Il lupo ripartì, col muso a terra e l’animo leggero. Le prede erano aumentate. E poi, i tre bambini, finalmente, la videro. Morbidi fiori colorati, coperti da cristalli di zucchero, circondavano una piccola casetta dai muri soffici di focaccia dolce. Archi di cioccolato circondavano le lastre delle finestre ambrate, erano così simili al caramello. I bambini lasciarono andare le mani, finalmente alla meta, corsero verso quel sogno dolce e attraente. Con le dita affondate nei vasi ricolmi di cioccolato, intravidero la porta socchiusa. Cappuccetto rosso richiamò i fratelli con le mani sporche di crema e un largo sorriso di cacao. Gretel corse in direzione di lei ― Se fuori è così, immagina dentro. Rise in direzione di Hansel. ― Forse è meglio di… Ma Cappuccetto rosso e Gretel erano già scomparse all’interno. Hansel guardò intorno il bosco buio e immobile ed entrò, facendo cigolare il grosso biscotto che lo divideva dalle bambine. ― Non vedo nulla. Cappuccetto rosso procedeva tentoni sul pavimento, scontrò un tavolo di legno e si fermò. ― Qui non c’è quel buon odore, usciamo ― fece Hansel. Uno scricchiolio più lungo e la porta si chiuse sbattendo. I tre bambini non videro chi li raccolse come legna da ardere e li caricò all’interno di una casetta di legno, un tetto, sbarre e troppa distanza da terra. Sentirono solo un odore asciutto di polvere antica che tolse loro il fiato mentre cercavano di urlare. La mattina successiva, appena svegli, i bambini trovarono tre piatti ricolmi di frutta, patate dolci, frittelle e succhi profumati. Mangiavano e piangevano, guardandosi muti e incapaci di darsi una ragione. Di sera, al buio, una figura si muoveva attorno al camino, sorbiva al tavolo da ciotole di legno, si avvicinava alla gabbia in silenzio e lasciava sui vestiti dei bambini lo stesso odore secco di polvere antica. Trascorsero gli stessi giorni che impiega un merlo a costruire un nuovo nido. Quel lupo magro e grigio si aggirava da giorni intorno alla casa. Forse aspettava che i bambini uscissero o forse no. Annusava i dolciumi che grondavano da quella casetta isolata e si allontanava disgustato. Tornò ogni giorno, senza mollare l’odore della sua preda che si faceva sempre più fievole e si mescolava a un sentore di latte grasso, fresco, appena munto da gonfie mammelle di mucca. Una notte, quella più scura che Hansel e Gretel avessero mai ricordato, quella figura restò attorno a loro più a lungo. Armeggiava in un vano che i bambini avevano sempre visto chiuso da uno sportello pesante. Rumore di legna, crepitio e poi il fuoco. Una voce rauca, di donna, o forse no, con un alito caldo che sembrava vivo e che si infilò tra le sbarre pesanti, disse: ― Questa notte vi mangerò. I tre bambini si aggrapparono alle sbarre e liberarono tutta la voce che in quel tempo indefinito era rimasta prigioniera nelle loro gole. Cappuccetto spalancò quanto più possibile gli occhi per vedere quella figura, Hansel urlò: ― Non toccherai mia sorella, brutta strega. Gretel lo guardò. Appena ebbe ascoltato quel nome, capì finalmente e cadde immobile. Cappuccetto guardò la bimba nel suo vestito azzurro ormai sgualcito e interrogò con lo sguardo Hansel. ― Una… mangiabambini? Hansel si accasciò in un angolo senza annuire e la porticina, al buio, si aprì. ― Comincerò da voi due. La figura spalancò la gabbia e infilò un braccio robusto dentro, senza guardare, cercando di afferrare qualunque cosa viva si muovesse sotto le sue mani. Strinse Hansel nella sua morsa, il ragazzino cercò di opporre resistenza, ma venne portato fuori come un giunco. Toccò a Cappuccetto, immobilizzata dalla paura. Appena sentì quel tocco capì che quella figura era una donna. Il fuoco ormai sfavillava nel forno e i ciocchi di legno di castagno crepitavano e rischiaravano a sprazzi la casetta umile: un tavolo, un mobile, un camino, un pagliericcio e vasi a terra sparsi senza ordine. Cappuccetto rosso aveva finalmente visto dove aveva trascorso tutto quel tempo. Quella donna gettò la bimba accanto a Hansel, sotto il forno, tra le faville e le lingue di fuoco che bucavano i vestiti e
Nella guida di Londra che ho comprato tengo il segno sulla pagina della Westminster Abbey. C’è scritto che qui sono sepolti ventotto sovrani e più di cinquanta grandi personalità della storia dell’arte, della letteratura e della tecnica. Gente che ha lasciato un segno imperituro. Sopravvissuti di Andrea Suma E io? Io sono qui, in mezzo a loro, nel cuore prospettico della croce latina, con la guida da 14,99 in mano e l’indice infilato tra le pagine, perché il segnalibro che ho comprato in quella bancarella di souvenir, figuriamoci, l’ho già perso. Chissà dove l’ho lasciato. Da qualche tempo dimentico tutto. La morte dà così tanto da pensare che non riesco a organizzarmi più come prima e dimentico persino il bagaglio a mano sull’aereo. Meno male che Giulia, come sempre, è qui con me, in un questo viaggio post laurea, a ricordarmi del bagaglio a mano, a ricordarmi del mio spazio umano incatenato alle piccole incombenze quotidiane. Eccomi qui, all’incrocio tra la navata e il transetto, una ragazza convinta di poter morire da un momento all’altro dopo sole ventiquattro primavere una laurea e niente di straordinario, schiacciata da due dimensioni: quella orizzontale dei morti che non sono morti, della gente che ha lasciato un segno imperituro, e quella verticale delle crociere goticheggianti, campate che toccano il cielo, molto più alte più vecchie più durature più importanti di me. Mi guardo attorno e il mio cuore, il mio ritmo su questa terra, è sempre più veloce, fibrilla come un pazzo. Cerco di respirare per placarlo ma l’aria è densa e immobile e lui corre senza briglie, vuole scappare via da me. Aspetta cazzo, non sono pronta, non ora! Aspetta! Il pavimento della navata mi sembra si inclini, mi manca l’equilibrio; le navatelle si inviluppano, vogliono farmi scivolare giù, insieme ai morti che sono davvero morti, milioni di vite che non lasciano il segno. No, non ci sto. Ho solo una laurea ventiquattro primavere e niente di straordinario, non sono pronta. Devo correre verso l’uscita e mettermi in salvo. “Nella vita bisogna ascoltare il proprio cuore”, ci dice la retorica, e qualcuno si sente forse rassicurato, ma nessuno sa bene cosa significhi. Io invece sì. Sin da bambina sono sempre riuscita ad ascoltare il mio cuore. Ben presto ho scoperto che non era una cosa da tutti e ho iniziato ad esserne orgogliosa. Ero decisamente più avanti dei miei coetanei e credo dipendesse anche da questo: sentire il funzionamento involontario di un organo interno, in un battito ritmico e rumoroso, dà una profonda coscienza di sé. In più erano battiti giovani, battiti forti che picchiavano insolenti contro il petto. Amo lo sport dal mio primo respiro. Sono sempre stata la numero uno, mi piaceva esserlo. Vincere non era il superamento dell’altro, ma la sperimentazione del corpo, che portavo al massimo per sentire forte e chiaro quel battere sordo dentro di me: “sono qui, sono viva, lo sarò per sempre.” Quasi quasi non ti ascolto. Quasi quasi ho il vomito. Quasi quasi esagero. Se mi sopravvaluto. Anche a Giulia piacciono i Subsonica e cascasse il mondo non ci perdevamo un concerto, ma quella sera c’era qualcosa che non andava. Nulla di grave, sentivo il mio cuore come sempre, anche in mezzo a quel casino, ma Cristo come mi bruciavano gli occhi! La mattina dopo me li sentivo talmente grossi e pesanti che credevo mi cascassero. L’apprensione nella voce di mio padre era una nota per me sconosciuta, per questo me ne ero fidata ciecamente e avevo acconsentito senza fiatare. Il medico era un amabile dinosauro prossimo alla pensione, uno di quelli che ancora “ascolta” il corpo del paziente. Parlava con lui, lo toccava, lo picchiettava, ascoltava silente il suo rumore e ne decifrava concentrato i segnali. Mi era venuta un’infezione agli occhi; sicuramente la colpa era delle lenti a contatto. Avevo stabilito che era meglio scegliere un bel paio di occhiali, magari con una bella montatura tartarugata e un taglio da intellettuale. Dopotutto ero quasi una dottoressa, visto che mancavano solo tre settimane alla laurea. Ci voleva un bel paio di occhiali. “Perché? Cos’ha che non va?”. Che stronzate, il mio cuore stava benissimo. “Perché ha un battito molto forte. È anomalo. Sicuramente non è nulla, ma è meglio sincerarsene”. Era stato mio padre a rispondere. Io ero talmente incredula da non riuscire a proferire nemmeno le più banali formule di cortesia. Il cardiologo era un aitante quarantenne brizzolato con gli occhi arroganti. Seguivo con lo sguardo il suo incedere sicuro mentre, cartella alla mano, entrava nello studio in cui noi eravamo già seduti da un pezzo, chiudeva la porta e si accomodava sulla sua sedia imbottita. Mi ricordo quei dieci secondi in cui aveva fatto finta di leggere i risultati delle analisi. Mi ricordo che aveva alzato gli occhi arroganti e aveva guardato i miei con il rimprovero per un peccato che non sapevo di avere commesso. No, non me n’ero resa conto. Peccato mio. Peccato mio pensare di essere invincibile, credere che un cuore che fa un rumore forte è un cuore che vive forte. Adesso che sono corsa fuori dall’abbazia, con il cuore l’affanno e il vomito in gola, lo so che sono sopravvissuta, ancora un altro giorno. Mi guardo intorno, guardo tutti questi individui che, grazie ai loro cuori silenziosi, sopravvivono senza saperlo. Beati loro.
Me la sogno ancora, precisa in ogni dettaglio. Le piastrelle di cemento bianche e nere del corridoio, tirate a lucido dalla domestica senza collo che passava lo straccio di lana con la galera; il parquet del salotto, che per me, abituata ai pavimenti di graniglia alla genovese, sembrava una cosa esotica; la grandissima cucina dove mi abbuffavo di biscotti strapieni di marmellata pucciati nel tè. Casa di bambola di Elisabetta Pellegrino Tutte le stanze si aprivano sul corridoio centrale e ognuna era un mondo a sé, come in una casa di bambola. Nella stanza dove erano cresciute mia zia e mia madre, con i letti di ferro gemelli coperti da tante mani di vernice da avere un colore indefinibile, si respirava ancora l’entusiasmo di due ragazzine che crescevano. La stanza di mia nonna era oberata da mobili neri e minacciosi e lì spesso passavo le mie notti insonni ad ascoltare la sua implacabile sveglia di latta e i tubi dell’acqua che cantavano incessantemente, lottando contemporaneamente con le zanzare e il caldo della Lomellina. Mia madre era solita spedire lì uno o più dei suoi cinque figli, per tentare di alleggerire un po’ la sua ricca ma impegnativa esistenza. Che io fossi sola o in compagnia di mia sorella o qualcuno dei fratelli, per me era sempre un piacere grandissimo andare a casa della nonna. Significava essere in vacanza e libera di misurare la mia indipendenza, anche a costo di scontrarmi con la nonna, che mettendosi sullo stesso piano di noi bambini ci impegnava in furibonde discussioni sulle nostre pretese di autonomia. Ma se non potevo andarmene in giro da sola per il paese, come avrei voluto nell’incoscienza dei miei pochi anni, allora mi dedicavo alle avventure in interni. Sceglievo una delle camere e la esploravo scientificamente, cominciando coll’annusare l’atmosfera che mi evocava. Poi mi sedevo su una poltrona o mi sdraiavo su un letto e guardavo ogni particolare, come per fissarlo bene a mente: le maniglie incongruamente rosse di un armadio davvero brutto nella camera degli ospiti, i pomi di un letto di ottone che molto mi piaceva e già avevo messo nella lista della mia eredità, i vetri istoriati del buffet e del controbuffet del salotto, il sacchetto pieno di caramelle aromatiche di mio nonno, che ogni tanto rubavo e assaporavo con gran gusto. Poi, cercando di non farmi scoprire, aprivo tutti i cassetti e i ripostigli di ogni mobile e esaminavo con interesse filologico tutto il contenuto. La casa era per me un enorme giocattolo e mentre esploravo le stanze, mi inventavo grandi storie, ispirate dai particolari che mi avevano colpito e il mio tempo passava felice. Quando mio nonno andò in pensione, lasciarono la casa e vennero a vivere vicino a noi, ma in quel momento io stavo finalmente esplorando la vita vera e non detti molto peso a quell’abbandono. Dopo qualche anno seppi che la casa era stata trasformata in un ufficio e provai un dolore immenso, che con mio sconforto e stupore ci mise molto tempo a passare. Avevano cancellato per sempre i miei sogni di bambina nella sua casa di bambole.
Cosa so veramente delle mie figlie. Se lo sta domandando mentre piega maglie, ripone reggiseni e raccoglie collant sparsi tutt’attorno. Dalle finestre aperte le arriva sul petto la lama affilata della tramontana e l’abbaglio di un cielo che oggi, dopo tanto piovere, non ha neanche una nuvola. Fra poco metterà fuori un altro bucato, entro l’ora di pranzo sarà tutto asciutto. Quando lo hanno dato, il loro primo bacio. E a chi. Nessuno se ne accorgerà di Stefania Passaro Nei loro cassetti ha appena trovato della biancheria nuova, mai notata prima. Devono essersela comprata con i soldi ricevuti in regalo a Natale. Quando e con chi hanno fatto per la prima volta l’amore. Perché l’avranno già fatto, sicuro, ci puoi giurare. Forse la più piccola no, Sami è sempre così presa dallo studio, forse lei no, ma le due grandi, figurati. Le ha preso questa cosa, oggi – che non le succede mai, fra l’altro – e non riesce a smettere di pensarci. È come se all’improvviso qualcuno le avesse aperto uno spiraglio proprio davanti agli occhi e la costringesse da dietro, con una mano fra la nuca e il collo, a restare appiccicata a quella fessura, perché veda finalmente quello che non ha voglia di vedere. Stamattina si è alzata che tutti dormivano ancora – almeno così le era parso – e in bagno, prima di lavarsi la faccia, si è fermata a guardarsi allo specchio. La piega lasciata dal cuscino, fra la guancia destra e il mento. Dormire a pancia in su, bisognerebbe, ma se non le è riuscito finora non può certo sperare di cambiar posizione a cinquant’anni. La raggera di rughe intorno agli occhi, che non scompare più quando smette di ridere, resta. Come un castigo definitivo. Scombussolante, osservarsi per la prima volta con quello sguardo. Tanto che le è venuto di provare a vedere com’è la situazione se ride di meno, se sgrana un po’ gli occhi sollevando le sopracciglia, se invece di abbandonarsi e ridurre tutta la faccia in frantumi si controlla un po’. Increspare il giusto, ecco. Quel tanto che serve a dimostrare contentezza, ma con misura. Tenere a bada occhi bocca guance. Era così presa dal fare l’attrice davanti allo specchio che non si è accorta che Samantha era dietro di lei che la fissava, la faccia assonnata, un occhio aperto e l’altro chiuso per difendersi dalla luce. Ed era arrossita come in flagranza di reato. “Che ci fai già in piedi, Sami!”, aveva esclamato, voltandosi di scatto verso di lei. Sua figlia aveva abbassato lo sguardo, aveva spostato il peso da una gamba all’altra, e affondando le dita nella nuvola di capelli che le incorniciano il viso, se li era portati davanti agli occhi, come a calare un sipario. Poi, da lì dietro, aveva bofonchiato: “E’ che oggi vado prima, la versione di greco… Devo controllarla con la Cri, non c’ho capito niente”. Cri, la sua amica. Una brava ragazza, sembra. Ma chissà se lo sa, la madre, che ha una cotta per Luca. Se lo domanda mentre toglie dalla lavatrice un carico di lenzuola. Cristina ne parlava a Sami l’altro giorno, mentre studiavano assieme. Era stato facile ascoltarle, senza far rumore, dalla stanza a fianco. E mentre se ne stava lì e si meravigliava di stare facendo proprio lei quella cosa di origliare, di spiare le ragazze come una guardona, mentre si diceva di smetterla che non era giusto – che in fondo significava non fidarsi di sua figlia e, se continuava, voleva anche dire che qualcosa di Sami le era sfuggito per sempre, e il fatto di stare lì non glielo avrebbe certo restituito – ecco, mentre ferma in silenzio tratteneva il respiro, aveva sperato che Sami ripagasse le confidenze di Cristina rivelando qualcosa di sé, se c’è qualcuno che le piace, se è poi quel romano conosciuto in montagna, il motivo per cui ha sempre la testa fra le nuvole, come dicono le sorelle prendendola in giro. Ma niente, Sami non aveva detto niente. “Ok, mi lavo la faccia e ho finito”, ha detto alla figlia quella mattina, e dopo essersi voltata si è piegata velocemente sul lavandino. Lo specchio la chiamava ancora, ma lei ha ignorato il suo richiamo, ha fatto finta che non esistesse più, sul muro, un palmo sopra la sua testa. E si è buttata due manate di acqua gelida sugli occhi, sperando servisse a lavar via un po’ di anni. Tutti quelli che le sono caduti addosso da quando anche Samantha è diventata maggiorenne. E’ stato tre giorni prima. Ora ripensa a quanto ha cucinato quel giorno, il menu speciale con tutte le cose che piacciono alla figlia – i pansoti con la salsa di noci, la zuppa inglese con il pan di Spagna imbevuto di marsala e latte, strati di crema al cioccolato, crema pasticcera e copertura finale di panna montata. S’era dimenticata la guarnizione di amarene, però, e Sami, prima di spegnere le candeline, glielo aveva fatto notare davanti a tutti. “C’era cibo anche per i beati, dai!”, le aveva detto quella sera suo marito, mentre spegnevano la luce e si davano il bacio della buonanotte, per consolarla di quella che lei aveva patito come una vera e propria défaillance. Quella sera, in realtà, aveva sperato invano in complimenti più circostanziati – qualcosa del tipo “anche la punta di vitello è venuta una delizia” – ma poi, senza aspettarne di altri, s’era addormentata di schianto. Ma chi lo dice, pensa ora, risentita, chi lo dice che i diciott’anni sono importanti per chi ci arriva. Siamo noi genitori, in quel giorno, a varcare una soglia, per la quale non saremo mai abbastanza preparati. È per noi, non per i nostri figli, che è cruciale quel compleanno. Una molletta le sfugge di mano e con la molletta anche la federa che teneva per un angolo con due dita. Vede entrambe atterrare due piani più in giù, sul balcone sporco della vicina. È a quel punto che le arriva l’odore del ragù
Due cucchiaini di zucchero. Ogni mattina, alle 10:30, massimo 10.35, e il pomeriggio verso le 16:15, Michela (32 anni) chiedeva un caffè. Anzi ne esprimeva il desiderio ad alta voce, con tono fermo e quasi arrogante, in modo che Giulia (20 anni) a poche scrivanie di distanza, potesse sentirla. Caffè nero di Gabriele Carretta E Giulia, già dal tono della voce, e abbassando lo sguardo per intravedere l’ora sullo schermo del pc, sapeva cosa doveva fare. Apprezzava in fondo che Michela almeno fosse puntuale e abitudinaria in modo quasi patologico, così poteva organizzare il suo lavoro in modo da non doversi interrompere sul più bello, magari durante la trascrizione di un atto, o di qualsiasi altra cosa noiosa, ripetitiva e pesante toccasse fare ad una giovane e inesperta stagista in un affermato studio legale genovese. Alle 10:29 salvava il documento (cliccava 2 volte sull’icona a forma di floppy disk, per sicurezza o per scaramanzia forse) su cui stava lavorando, e poi lo rileggeva, giusto per non dare l’idea di tergiversare. Il momento arrivava, sempre abbastanza puntuale. Il suono fastidioso della voce di Michela, da 10 anni segretaria in quello studio, aveva un che di fatale; Giulia lo attendeva quasi come si aspetta la pioggia sotto un cielo plumbeo, fa sempre meno paura della minaccia che la precede. Due cucchiaini di zucchero, di canna se ce n’era ancora, in quel armadietto un po’ dozzinale che mal si abbinava con l’eleganza dello studio. La macchina del caffè, posta proprio sotto quel mobile distribuiva caffè decenti, non ci si poteva davvero lamentare. Dopo aver messo lo zucchero, due cucchiaini mi raccomando, Giulia mescolava lentamente, e nel frattempo cercava di capire con discrezione se qualcuno nello studio la stesse osservando. Quando era sicura di non essere nel campo visivo di nessuno, si girava col caffè in mano verso l’armadietto per chiuderlo o per dare l’idea di cercare qualcosa. In quell’attimo, col viso nascosto al mondo e il cigolante rumore dell’anta dell’armadietto che si chiudeva, Giulia guardava il colore nero del caffè nella tazzina, in cui specchiava ogni mattina il suo umore, e ci sputava dentro. Durava pochi secondi , il tutto, e dopo, Giulia si sentiva meglio. Era una specie di gesto catartico, le sembrava quasi innocente, privo di conseguenze. E in effetti Michela beveva il suo caffè con gusto, o comunque senza dare segni di insofferenza. Poche gocce di saliva, sciolte nel caffè, la piccola, meticolosa e quotidiana vendetta di una ragazza, una donna in difficoltà. In grossa difficoltà, perché a 20 anni, finito il liceo, entrare in quello studio era davvero una bella occasione, ma le difficoltà ambientali erano oggettivamente molte. E non solo per la sua inesperienza; gli avvocati dello studio erano tutto sommato cordiali, o comunque non le davano la sensazione di escluderla, almeno non del tutto, dall’attività lavorativa. Certo non era a scuola, non c’erano sorrisi e benevoli pacche sulle spalle quotidiane, ma tutto sommato andava bene così. O meglio, sarebbe andata bene così, se in quel borghese studio del centro cittadino non avesse lavorato anche Michela. Giulia ricorda ancora perfettamente lo sguardo diffidente e curioso con cui la aveva accolta, il suo primo giorno. E quella diffidenza palese, ma anche quella malcelata curiosità sarebbero stati i punti fermi del loro rapporto negli anni successivi. Michela, da 10 anni in quello studio, era una donna alta, elegante come figura, dai lineamenti del viso duri, che la facevano sembrare più grande della sua età , soprattutto nei suoi momenti di collera. E Michela si arrabbiava spesso, con tutti, avvocati compresi. Soprattutto con Giancarlo, l’avvocato con più anni di anzianità lì dentro; se lui si dimenticava qualcosa o magari la rimproverava sommessamente per il ritardo con cui lei svolgeva alcuni suoi compiti, lei non si faceva problemi di mandarlo a quel paese, a voce alta, davanti agli altri, con un eccesso di confidenza (e di maleducazione) che inizialmente aveva sorpreso parecchio Giulia. Aiutami a trascrivere questo atto, Giulia; sbrigati con quella pratica; oggi non ci siamo, Giulia; capisco che sia importante, ma non credo che tu possa prenderti quel giorno libero, Giulia. Non correva buon sangue tra loro; o meglio, semplicemente Michela la aveva presa di mira, dal primo momento in cui era entrata in quello studio. Urla, frasi sarcastiche, velati insulti, uno stillicidio di vessazioni, goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, stavano portando Giulia all’esaurimento. Michela aveva creato un ambiente ostile, aveva alzato un muro, che Giulia non aveva le forze di sormontare, e anzi ne era schiacciata. Preparami un caffè, quello almeno lo sai fare? E mi raccomando, due cucchiaini di zucchero. Giulia ogni mattina si metteva l’elmetto, si sedeva davanti alla scrivania e affrontava quel piccolo, odioso inferno che era diventata la sua vita in ufficio. Sopravvivere alle intemperie, una specie di naturale istinto di conservazione, che le permetteva di stare a galla. Dopo circa un anno nello studio arrivò un nuovo avvocato, giovanile di aspetto, dai capelli brizzolati; e Giulia notò subito come anche Michela nei suoi confronti nutriva una certa soggezione. Finì che Michela e il nuovo avvocato si misero insieme, ma la storia non durò che pochi mesi. E quel muro, lentamente iniziò a sgretolarsi. E forse anche Giulia, lo avrebbe rimpianto. Giulia, quel mattino vestiva di rosso; sulla scrivania aveva la borsa appoggiata, insieme ad un sacchetto di una nota profumeria. Stava svogliatamente cercando qualche idea su internet, qualche destinazione esotica per un viaggio che non avrebbe mai fatto. Cercava di darsi un tono, di fingere comunque di essere impegnata in qualcosa di serio e urgente, per sfuggire al pericolo Michela. Ormai Giulia era da circa 4 anni lì dentro, e ne erano passati circa 2 da quando Michela aveva deciso che lei sarebbe diventata la sua migliore amica. E no, non era stata un reciproco convincimento, non c’era stata nessuna evoluzione positiva nel rapporto che giustificasse questa inversione a U; era stata una scelta di Michela, punto. Dopo la fine della storia col collega, Michela era finita in un turbinìo di relazioni
La morte, che fino all’ultimo temiamo e ricusiamo, interrompe la vita, non la rapisce. Verrà un giorno che ci riporterà una seconda volta alla luce… tutte le cose che sembrano perire sono soltanto mutate. (Seneca, La dottrina morale) Satollità di Samantha Tortora Milano, Stazione Centrale, ore 8;35. Domenica. Tiro le ultime boccate alla sigaretta, la butto sulle rotaie e a passo veloce arrivo sul binario due schivando uomini d’affari, lacrime d’addio e trolley di giapponesi che vanno veloci come treni. Il cielo azzurro è l’unica macchia di colore in fondo al grigiore della galleria, dei pilastri e delle volte in ferro nero. Eccolo lì, rosso e grigio, puntuale, in attesa dei suoi passeggeri. Sembra dire guardate come sono imponente, sono il più fiero di tutti. Mi ricorda l’astronave di Star Wars del Luna Park, solo molto più grossa; portami via, a 400 km all’ora, più veloci del vento. Salgo gli scalini, sperando di trovare un po’ di sollievo nell’aria condizionata. Il mio posto è l’ A3. A3, A3… ripeto nella mente lungo gli stretti corridoi, rendendomi conto di essere salita dalla parte sbagliata del treno. Mi fermo al vagone ristorante per un caffè, stamattina non sono neanche riuscita a berlo. Ora sono più reattiva, continuo la mia ricerca. A 7, A 5, A 2, eccolo A3. Mi lascio cadere sul sedile, con la valigia ancora sulle gambe, non è pesante e posso tenerla come scudo verso gli altri. Stringo la maniglia forte con entrambe le mani e chiudo gli occhi. Mi Chiamo Allegra Izzo, ho 19 anni e sto tornando a casa, l’arrivo è previsto alle 12:41, in tempo per il pranzo organizzato da papà. Bologna, ore 9:40. Mi sto godendo la pelle della poltrona, sono allergica a quelle in tessuto, mi repellono coi loro rifiuti dei passeggeri precedenti: forfora e pidocchi, sudore, pellicine, unghie, residui di cibo, anche sangue che esce da minuscoli tagli. La pelle è figa e igienica, anche nei ristoranti dovrebbero eliminare le sedie in tessuto. Intorno a me ci sono altre sette poltrone, tutte occupate ma separate da una giusta distanza che ti permette di evitare di parlare coi compagni di viaggio. Sistemo la valigia sopra di me e sfilo dalla borsa il libro che mi ha regalato Andrea, La dottrina morale di Seneca. Non lo ricordo, nonostante la maturità classica di Giugno, o meglio, non avevo notato la saggezza e la contemporaneità che la caratterizza. Me l’ha fatto scoprire Andrea, dopo che facevamo l’amore io abbracciavo il cuscino e lui leggeva e traduceva dal latino, il libro appoggiato sulle mie natiche. Inizio a leggere, inciampo nelle frasi su cui discutevamo, penso a noi. Il suo modo di scoparmi, le sue fissazioni sull’ideale femminile e la sua “intellighenzia harvardiana” hanno iniziato a darmi l’angoscia. Maledetto schiavo della libidine. Provo a dormire. Firenze, ore 10:48. L’andamento soporifero del treno è cessato e mi sveglio di soprassalto con un filo di saliva che bagna il mio mento. Sono sudata, i miei capelli lunghi e biondi scaldano come una coperta, ma hanno il vantaggio di coprirmi le orecchie a sventola. Mi osservo nello specchietto attaccato sulla parete alla mia sinistra, tocco il mio viso con l’indice e il medio: la fronte spaziosa, le sopracciglia dritte e sottili, le guance rosse, il girocollo di perle e zaffiri che è il secondo regalo di Andrea. Non è proprio il mio genere, ma lui vuole che lo diventi. Maledetto schiavo dell’ambizione. Il mio cuore batte troppo veloce. Roma, ore 11:45. Andrea avrà aperto gli occhi da poco, forse è sotto la doccia che canta col suo inglese impeccabile e fastidiosamente americano. Senza fare colazione pranzerà con le polpette che ho cucinato ieri sera, permettendomi però una piccola variazione: ho sostituito i pinoli con polvere di nocciole. Andrea le adora, ma è gravemente e meravigliosamente allergico alle nocciole. Non dimenticherò mai quando gli ho spalmato una manata di Nutella sulla faccia, nel giro di pochi minuti il suo viso è diventato gonfio e rosso. Il collasso circolatorio e la morte avverranno nel giro di pochi minuti. Shock anafilattico. Nessuno sentirà la tua mancanza Andrea, maledetto narciso insicuro. Ti ho fatto un favore, e ti ho dato la possibilità di giocare un’altra partita. Io sono innocente e la mia coscienza è limpida.
Sai, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, ama il prossimo tuo come te stesso a meno che non sia diverso da te. E che senso ha? Penso di averla inventata l’ultima parte. Perché la prima chi l’ha detta? Un tizio. Il tizio di Francesca Refano Quale tizio? Non so bene. Pare fosse un mezzo uomo e mezzo fantasma. Era trasparente? Non si vedeva? No, si vedeva. E faceva vedere anche chi non vedeva… E come è possibile? … E camminare chi non poteva. MA DAI! E chi era morto, pensa un po’, non lo era! E cos’era? Resuscitato. Si vabbè! Comunque morti o vivi, zoppi o cecati, pare che questo tizio sopportasse tutti ma non i diversi. Un uomo morto è uguale al vivo? No ormai è morto. Ma questo tizio si può sapere chi è? Non so, ha 100 nomi… forse 3… Anche lui è parecchio confuso. Bipolare? Può essere. E a te chi l’ha detto? Un altro tizio che l’ha conosciuto ma mai visto. E la fonte ti sembrava sicura? Che vuoi che ti dica, quel che mi ha detto riferisco. E nessuno l’ha mai visto? No! E come è possibile? Cosa?! Che questo tizio fa vedere i cecati, camminare gli zoppi ma nessuno l’ha mai visto! Ormai penso sia morto. Ma non è mezzo fantasma? Sì! E i fantasmi muoiono? No… E allora vedi!? Io si! Non in quel senso, dai. Non è mai esistito. Ma se ci sono le foto! E chi le ha scattate? Nessuno. Sono ritratti di un uomo che lo vide, credo. Non è possibile! Vabbè, ti dicevo, non gli piacciono i diversi. Perché? Perché non sono uguali. Uguali a cosa? Alla normalità. E cos’è la normalità? Noi. Sì? Forse. E ha creato confusione con i suoi millemila nomi. A chi? A quelli che si sono ammazzati. Chi si è ammazzato? L’uomo che ha sparato a una donna che aveva in braccio un figlio. Sono morti solo in due? No. Sono morti in tanti. Mi correggo: sono morti i diversi. Ma diversi per cosa? Per la pelle. Un po’ bianchi, neri, gialli e qualcuno rosso. Ah capisco… Pure perché chiamavano questo tizio con un nome diverso. Comunque, sono tutti morti. E perché? Perché il tizio con i tanti nomi ha creato confusione. E non poteva chiarire? No. Perché? Perché non è mai esistito.
La nonna non ci ha chiamate, così ce ne stiamo ancora un po’ al calduccio, pensava Teresa, mentre accarezzava i lunghi e biondi capelli della sua bambola, Lisa. Quella settimana era il turno del pomeriggio, scuola dalle 14 alle 18. Questa storia delle settimane alternate era un po’ una rottura, ma la scuola era appena iniziata, era divertente andare in classe a disegnare, giocare, scrivere e la maestra era brava, anche se l’altra volta l’aveva messa in punizione insieme a Marta, la sua compagna di banco, perché si erano rincorse per la classe durante la lezione. Marta aveva pianto, ma lei no. C’era rimasta parecchio male, ma l’umiliazione del pianto, no. Mentre si stiracchiava, indecisa se alzarsi o aspettare ancora un po’, pensò che avrebbe dovuto invitare Monica a giocare a casa sua. La casa delle bambole di Silvia Conte Monica era la figlia del dentista del secondo piano e la settimana precedente sua mamma aveva chiesto alla mamma di Teresa se le due bambine potevano giocare insieme. Quindi lei era scesa per l’ora della merenda nella casa del dottor Olivieri, che faceva anche studio, perché prendeva tutto il piano. Al numero otto entravi per andare dal dentista e al numero 9, andavi a casa loro. Ad aspettarla c’erano la signora Carla e Monica, che ha la sua stessa età, ma che va alla scuola privata, la vengono a prendere tutte le mattine con un pulmino e non deve fare i turni, per l’improvviso boom demografico e la mancanza di edifici scolastici nel quartiere. Le due mamme avevano insistito molto per questa merenda insieme, la famiglia Olivieri si era trasferita da meno di un anno e Monica non aveva molti amici nel circondario. D’altro canto nemmeno che Teresa era libera di uscire e di vedere le sue compagne di classe a suo piacimento e visto che la mamma lavorava tutto il giorno e la nonna non poteva scorazzarla avanti indietro, un’amica nel palazzo le faceva comodo. Il giorno della merenda, lei era scesa verso le quattro e subito era stata introdotta nella cameretta dell’altra bimba, che non doveva dividere con sua sorella, perché aveva un fratello maggiore di due anni, che aveva la sua, di camera. Nella stanza, molto ordinata, troneggiava una casa delle bambole a tre piani, con delle bellissime finestre in legno di colore rosa, nelle quali era intarsiato un cuore. Ogni stanza era perfettamente arredata, salotto, cucina, bagno due camere da letto e una stanza dei giochi in soffitta. E per giunta Monica possedeva l’intera serie delle “Lucie”, come le chiamavano Teresa e sua sorella: Lisa, Lucia, Lola e Laura, mentre loro ne avevano solo due, una a testa. Avevano iniziato a giocare con quella casa e le sue abitanti, ma Teresa si era sentita una traditrice, perché la sua Lisa era rimasta a casa, da sola, perché la nonna le aveva detto: “Scordati di fare avanti e indietro da una casa all’altra e fare chiasso per le scale”. Quindi aveva deciso di prendere Lola, quella con i capelli rossi, in segno di rispetto per la sua Lisa. Il pomeriggio era trascorso piacevolmente, anche se Monica era un po’ dispotica e non le lasciava prendere grandi iniziative sulla casa delle bambole, che per giocare in due era anche un po’ scomoda, a suo parere. Verso le cinque avevano fatto merenda con pane e Nutella. Lei era stata zitta, come le era stato insegnato, e lo aveva mangiato, anche se la cioccolata non le piaceva molto, come tutti i cibi troppo colorati. Avrebbe preferito pane burro e zucchero. Nel tardo pomeriggio era passata la mamma a prenderla, con grandi ringraziamenti. Le due bambine si erano salutate con la promessa di passare insieme un altro pomeriggio. “Questa volta a casa nostra”, aveva aggiunto la mamma di Teresa. Poi la descrizione minuziosa dei giocattoli di Monica che Teresa aveva fatto a mamma, nonna e Caterina, sua sorella, quel fiume in piena che era quando aveva delle novità. E quindi l’idea geniale di costruire un appartamento delle bambole. Ne avevano incominciato a discutere con la sorella, di cinque anni più grande di lei e avevano convenuto che, siccome nella loro cameretta non avevano lo spazio per una casa delle bambole, che poi era anche un po’ leziosa, così aveva detto Caterina, potevano creare una serie di mobili, che avrebbero costituito l’appartamento delle Lucie. Riesumarono un piccolo armadio di legno che decisero di ridipingere di rosso e chiesero alla nonna di confezionare un nuovo piumone per il letto di Lisa, con una stoffa che si adattasse al rosso. Decisero di fare dei cuscini per fare salotto da sparpagliare su un tappetino che già utilizzavano. E poi colpo di genio: crearono dei cassettoni con le scatole dei fiammiferi svedesi, quelle che avevano gli scomparti a scorrimento, incollandole due a due o tre a tre a seconda della grandezza che desideravano ottenere. Ciascun mobiletto venne poi rifasciato di carta da pacchi, per dare l’idea del legno. La cucina era forse un po’ fuori misura per la grandezza delle Lucie, ma aveva molti accessori e avrebbero potuto fingere di prendere un tè. Per li bagno ci avrebbero pensato, e se la nonna avesse fatto loro usare l’acqua vera con lo shampoo, sarebbe bastata anche una scodella rettangolare per fare vasca. Avevano lavorato tantissimo, le due sorelle, per creare l’appartamento delle bambole, perché Teresa potesse ricambiare l’invito di Monica e poi magari invitare Marta, che si sarebbero divertite anche di più. E quel giorno, che era fuori discussione perché c’era scuola al pomeriggio, divenne il giorno. Teresa era pronta alle due meno un quarto: stivali rossi, mantellina rossa con berretto uguale, cartella rosso-blu già sulle spalle, ma poi la mamma aveva chiamato dall’ufficio. A Brignole era un gran casino: pioveva da ore con troppa intensità, si vociferava che il Bisagno potesse straripare. Meglio non andare a scuola, troppo rischioso. E la nonna l’aveva convinta a restare a casa, anche se lei voleva andare a tutti i costi. Le piaceva la scuola e saltare nelle pozzanghere lungo
Ogni giorno è un passo in più che facciamo dandoci la schiena. Ho rinunciato a tutto per lui, ai miei sogni, alla mia famiglia, alla carriera. Ma ero così innamorata e mi sembrava che non ci fosse nulla di più affascinante delle sue fotografie. Shirley di Giulia Barone Una volta ho pianto vedendo gli scatti fatti durante una giornata trascorsa insieme al mare un pomeriggio d’inverno. Avevamo fatto una passeggiata, poi ci eravamo riparati dietro ad una roccia e distesi sul plaid ci eravamo addormentati. Dopo un po’ lui si era svegliato e aveva iniziato a fotografarmi mentre dormivo, mentre mi stavo svegliando e non aveva smesso neanche quando da seduta lo guardavo con la mano a visiera per proteggermi gli occhi dal sole. Erano immagini incredibili, non sembravo neppure io tanto ero bella, ma lui diceva di vedermi così. Era andato tutto bene fino a quando avevo desiderato un bambino. Lui non voleva figli, diceva che non se la sentiva, i suoi genitori erano morti in un incidente stradale quando aveva sette anni e il dolore provato era stato così violento da convincerlo a non volere figli per paura di poterlo arrecare lui stesso. Ne avevamo discusso per sere intere, per giorni e settimane ma lui era irremovibile. Ci avevo rinunciato, ma lui aveva già smesso di toccarmi, non mi cercava più, forse per paura di essere ingannato. Ricordo una mattina, era estate, lui si era alzato per andare a fare una passeggiata. Quando era tornato, io ero ancora a letto, stavo leggendo ma sentendo la chiave nella toppa avevo fatto finta di dormire e, girata di schiena, avevo lasciata scoperta parte del mio corpo nudo. Lui era entrato in camera, si era avvicinato ma aveva solamente riposto sul comodino il libro che avevo lasciato tra le lenzuola. Mi ero immaginata una vita diversa. Io che avevo così tanti sogni, ho scelto di dare più importanza al suo lavoro perché mi sembrava giusto: io ero solo una semplice aspirante attrice. Quanti provini ho fatto prima di sposarmi; passavo le giornate a leggere i copioni, a provare e riprovare i dialoghi che dovevo presentare, viaggiavo sola recandomi nelle città dove stavano girando un film e così ho fatto la comparsa in vari lungometraggi, una volta sono riuscita ad entrare nel corpo di ballo di un musical. Ma Carl diceva che non ne valeva la pena insistere, era uno spreco di denaro ed energie. E così mi sono dedicata a lui, seguendolo nei suoi viaggi di lavoro perché in fin dei conti aveva ragione. Ora non è più l’uomo di cui mi sono innamorata, è cambiato, non accetta neanche più ingaggi che lo potrebbero allontanare da casa. Ogni fine settimana ripete sempre lo stesso rituale. Si alza presto, va a fare colazione al bar sotto casa, compra il giornale e una stecca di sigarette che poi fuma seduto sulle scale del giardino di casa. Si procura ciò che gli serve per vivere due giorni barricato. Dice che è l’unico modo per rilassarsi, ma io lo so che ha attacchi di panico. In questo rito ci sono anch’io ovviamente, lo rassicura avermi vicino, sono come uno i punti di riferimento della casa che riconosciamo quando va via la luce e camminiamo a tastoni. Sono come il pianoforte nell’angolo del salotto o la cassettiera bombata che c’è in ingresso sulla quale appoggia le chiavi quando entra in casa. Ma io mi sento soffocare. Mi sembra di non vivere più. Quando abbiamo smesso di viaggiare ho trovato lavoro come maschera in un cinema di città, è veramente la fine più triste per un’attrice, ma almeno è un lavoro che mi permette di uscire nei weekend, altrimenti impazzirei. Il fatto è che lo amo ancora. Un paio di anni fa è successa una cosa che mi ha fatto credere che avremmo potuto ricominciare. Aveva accettato un lavoro per un’agenzia pubblicitaria, doveva fare delle fotografie artistiche per un elegante albergo di Manhattan, mi aveva chiesto di fare da modella ed era uscito un capolavoro. Mentre mi muovevo intorno al letto di quella camera d’albergo mi sentivo sensuale, ammiccavo all’obiettivo e i suoi stimoli a cambiare posa mi eccitavano. Sono sicura che anche lui abbia sentito quell’elettricità. A lavoro finito tutto era tornato come prima. Non so se me la sento di continuare questa farsa. La vita è davvero buffa, il ruolo da protagonista che ho sempre desiderato interpretare è stato nella commedia drammatica della mia vita.
Vorresti prenderla e descriverla, aggiungendo mille particolari, tutto ciò che vedi. E credi che, trovato il punto di vista giusto si possa andare avanti con un certo ordine. Ma è impossibile aggiungere qualcosa a Venezia, fossero solo parole. È lei che, per prima, ti deve scegliere. Venezia di Laura di Biase È lei che decide cosa darti, cosa concedere della propria essenza. E non per gelosia, o per diffidenza, ma perché l’intero sarebbe troppo per chiunque. E lei lo sa. Sono a Venezia per la prima volta. Prima di partire ho cercato di organizzarmi con una cartina: e se mi fossi persa? E se avessi girato e rigirato per le calli senza ritrovare la strada? Mi sento più sicura, adesso, e dal finestrino del treno mi tuffo nella laguna. È il suo primo avvertimento: non sono una città di mare, sono una città nel mare, lascia tutto, che ti porto io. Con il fiato sospeso supero il lungo tratto di ferrovia e Venezia mostra il viso familiare di una stazione come un’altra. Allora prima era suggestione, oppure ho solo immaginato, a furia di sentire nelle orecchie Venezia e il mare, Venezia e il mare, ad ogni giro di ruota. Finalmente scendo e trascino dietro di me la valigia. Anche lei ha delle ruote, piccole in verità, forse è per quello che non sento il loro avvertimento, lo stesso delle ruote del treno: Venezia e il mare, Venezia e il mare… Avevano cercato di dirmelo in tutti i modi, perché fossi preparata. Esco dalla stazione. Ho appena lasciato il mare dietro di me e me lo ritrovo davanti. Che strada può aver fatto? Non ci siamo detti ci vediamo là. Ed è arrivato prima lui. Bello scherzo, allora giochiamo. Mi guardo intorno e riconosco la mia strada, che corre parallela al grande canale e dopo poco se lo lascia alle spalle. Così questa volta vinco io, e sparisco. Ma Venezia sa attendere e sa dare tempo. Sa essere regina, senza essere dispotica e superba. Da vera regina sa accogliere chi arriva nel suo regno, non svela subito ricchezze e tesori. Lascia che ognuno decida quali siano i più preziosi per sé. Il tempo passa, e intanto il sole scende un po’, mitigando uno splendore che intuisco appena. È generosa, questa regina. Mi sa aspettare, finché mi ripresento al punto di partenza per continuare il gioco. La torta è talmente ricca, e bella, che si fa fatica a tagliarla. Ma per sentirne il sapore bisogna pur farlo e così scelgo una stradina, sottile, che non intacchi il tutto. Si comincia. La città mi prende per mano, e con lei inizio il mio cammino. Costeggiamo il grande canale, ci lasciamo alle spalle un ponte, arriviamo all’inizio del suo cuore. E a quel punto mi lascia andare. Mi volto, e rapisco con gli occhi l’immagine della strada fatta fin lì, nel timore di non saperla riconoscere. La città che mi ha preso per mano si è sciolta e si è fatta acqua. Davanti a me rimane la regina. Prendo un respiro, mi tuffo. Con me ho una cartina, la spiego, ma lei non ricambia e resta muta. Venezia è irriducibile, immensa grandiosità e ciò che ho in mano è troppo poco per contenerne l’anima. Ripiego il foglio e prendo un altro respiro, questa volta impercettibile, quello che basta per superare il primo ponticello. La corrente mi prende e mi spinge ad andare avanti, ogni passo un tesoro, ogni respiro una meraviglia. Davanti a me, dietro di me, e dentro di me. Venezia è ovunque, la sua essenza si espande all’infinito e riempie l’aria che respiro. Una corrente mi porta lontano. Torno sui miei passi, lei li incrocia, li moltiplica. Inizio ad avere il fiato corto. La luce, la gente, tutto in una volta. Dovrei tornare indietro, il ritmo è troppo alto. Non posso continuare così per molto. E la regina esprime la sua grandezza, accogliente. Attenua il suo splendore, lo offusca con une luce grigia, avverte che è l’ora di tornare, di invertire la marcia e mi fa da guida. Un tuono lontano mette fretta. La corrente si fa incerta, si ritrae, come una marea. Perdo l’attimo, catturata dal cambio di luce. Il buio si è fatto intenso, me ne accorgo, finalmente, e la corrente non è più con me. Sono sola. La piazza mi contiene e accoglie anche le prime gocce di pioggia. Qualche passo basta per capire che quella è la prima prova che Venezia mi regala. Mi guardo intorno e inizio. Da un ponte all’altro, seguendo l’istinto, seguo tracce invisibili. Guardo il cielo, non lo trovo. Trovo un quadro di centinaia di anni fa, luce di centinaia di anni fa, muri di centinaia di anni fa. Solo l’acqua è viva. Non so cosa seguo. Me stessa? La strada sarà lunga. Per confondermi, arrivano lampi da chissà dove. Bisogna sentire il proprio battito sopra quello del cielo. Seguo un ritmo, poi un altro. Ormai la pioggia si è fatta intensa e lava i colori, più vivi a dispetto dell’assenza di luce. La poca che è rimasta rimbalza da una pietra all’altra. Passando da una pietra all’altra arrivo a casa. Venezia ha mille voci. Nel silenzio ascolto quelle della notte, che mi tengono sveglia. È una città viva, e rimane viva in ogni istante. È bella. Intera. Piena. Le grida dei gabbiani mi avvisano che possiamo ricominciare a giocare in strada, come una volta. La città mi fa vedere come si fa e la seguo. Prima regola, cambiare. Cambiare occhi, polmoni, tutto, e di nuovo a cercare una strada per il suo cuore. Non mi perdo più. Ora che la conosco posso dare uno sguardo al foglio appena spiegato, adesso mi svela le sue vene e le sue arterie. Per sentirmi sicura basta guardarla negli occhi, non c’è più bisogno di proteggermi e la luce della sera resta piena. Niente cambio, questa volta. Scendo qualche gradino, mentre mi accompagna sulla riva, dove il grande canale cerca di salire sulle pietre che lo trattengono. Per provarci
A sei anni fui colpita da una fastidiosa forma di gastroenterite e, considerato che si era in estate, il gelato mi era proibito. Come se questa tragedia non bastasse, fui spedita a trascorrere le vacanze a casa di nonna Antonia, sull’Appennino lucano. Per par condicio, non fosse mai che si offendesse permalosa com’era, i miei dovettero promettere un mio soggiorno anche dall’altra nonna, quella materna, a Barletta sulla costa pugliese. Fu un’estate interessante, a suo modo. Conobbi bambini con accenti diversi e vite diverse, ma imparai soprattutto a conoscere le mie nonne; i nonni un po’ meno perché, pur essendo presenti, erano entrambi figure a lato. Nessuna delle due donne tendeva a sprecare parole: erano le loro case a parlare anzi a chiacchierare incessantemente. Le case delle nonne di Luciana Verre Nonna Antonia aveva una casa grande, sparsamente arredata e senza l’ombra di un soprammobile. Alla sera, con le finestre chiuse, le parole rimbombavano e rimbalzavano da una stanza all’altra e, di sicuro, non si potevano sussurrare segreti. Tutte le porte avevano pannelli in vetro smerigliato; quella del bagno mi creava non poco disagio considerato il mio problema di salute, ma la nonna ebbe pietà di me e mise una tendina. La cucina era la centrale operativa, ma le dispense, ben due, erano basi di stoccaggio. La più piccola approvvigionava i cibi giornalieri freschi; quella più grande, una vera e propria stanza, era per i cibi non-si-sa-mai-chi-può-arrivare La più piccola approvvigionava i cibi giornalieri freschi; quella più grande, una vera e propria stanza, era per i cibi non-si-sa-mai-chi-può-arrivare: in bell’ordine vi erano stivati damigiane di olio e di vino; vasi di verdure e di salame sott’olio; forme di formaggio coperte da canovacci; ceste con peperoni secchi; mazzetti di erbe aromatiche appese alle travi, in primis origano e l’adorata malva che Antonia raccoglieva sulla collina di fronte a casa. Mia nonna materna si chiamava Maria Sterpeta. Ancora oggi rabbrividisco all’idea che i miei avrebbero potuto essere meno illuminati e affibbiarmi quel nome in suo onore. In realtà, era un omaggio alla Madonna Nera dello Sterpeto , il cui Santuario sorge appena fuori Barletta. Donna enigmatica, votata all’apparenza, non si toglieva mai la maschera perché ciò che più temeva era il giudizio altrui, ma non perdeva occasione di criticare e spettegolare. Viveva in condominio all’ultimo piano, in un appartamento piuttosto piccolo ma carico di mobili e fronzoli. Nella sala da pranzo, c’era un mobile-vetrinetta talmente carico di cristalli che una notte decise di tirare le cuoia con un tale botto che ebbi problemi poi a prendere sonno per tutto il resto della vacanza. La polvere sui mobili era considerata fuorilegge e ogni superficie doveva brillare, ma si guardava bene dal farlo personalmente limitandosi a dirigere le sue figlie più giovani nelle pulizie di primavere quotidiane. Non c’era una vera e propria dispensa perché non amava cucinare e spesso si finiva per mangiare pane e pomodoro.
È una di quelle mattine in cui niente può andar male. In cui tutto gira per il verso giusto. Non sai neanche tu perché. E non lo sa neanche Emilia, con le dita delle mani ancora fredde dalla notte precedente. Andrai nel posto più noioso e triste del mondo, lo sai vero? E da sola, pure. Mamma mia, non ti invidio. Persone che le parlavano prima della partenza. Con tutti i loro consigli saggi e non richiesti. Emilia si stringeva nelle spalle, sì sì va bene. Come se fosse importante, ascoltare gli altri. E soprattutto, dargli retta. E così, niente. È partita… Incomprensibile felicità di Laura Caruzzo È partita come ha sempre fatto. Perché il problema non è partire; il problema è tornare. Ogni volta che si lascia alle spalle la sua città, la sua nazione, tutto l’amore e tutto l’odio verso casa si ingarbugliano in un nodo inestricabile, si intrufolano nel cassetto dei cd, non ne escono fino al ritorno. Che se ne stiano lì, incollati. Ha guidato su strade lunghissime, ha mangiato cose immangiabili, ha conosciuto persone alte e poco simpatiche. Si è perfino innamorata, una volta o due. Il tempo di una sera, in uno di quegli scenari da film romantico o d’avventura, uno di quelli che non si avverano mai. E poi via, senza voltarsi indietro, avanti verso tutto il nuovo e tutto il bello che sicuramente la stanno aspettando da qualche parte. E adesso è qui, in ciabatte e maglione, quello sformato, quello blu e bianco, con il vago retrogusto di un Natale norvegese particolarmente freddo. Davanti a una colazione così calorica e deliziosamente belga. Saluta con un cenno i signori della camera di fronte alla sua, una coppia di tedeschi sulla sessantina che leggono il giornale con una concentrazione fuori luogo per una mattina nebbiosa che in realtà è ancora un’alba. Non sa spiegarsi il perché, Emilia, ma davvero sente che niente potrebbe andar male. Né quel giorno, né in quelli a venire. Non è una sensazione chiara, è solo strana. Non le capita così spesso di sentirsi così inutilmente felice, o forse così felice per cose inutili. Per niente in particolare. È come se, per una volta, bastasse il semplice fatto di essere lì. Sprofondata tra giornali francesi, profumo di caffè, quella che non è nebbia ma solo foschia che preme sulle finestre. Sarà una giornata di sole. Sicuramente. Potrebbe anche fumarsi una sigaretta, prima di mettere definitivamente in moto il cervello, vestirsi, iniziare il solito tour culturale in cui si trascina (‘trascinare’, in realtà, non è il verbo corretto. Non rende l’idea di tutto l’entusiasmo che sicuramente le salterà in spalla una volta svegliatasi definitivamente) ogni volta che visita una città nuova. Sale nella sua stanza, un buco di una manciata di metri quadrati che però è riuscito a farla sentire a casa dal primo momento in cui ci è entrata. Prende le sigarette e nient’altro. Si chiude dietro la porta, percorre il corridoio salterellando, si lascia alle spalle quell’adorabile pensione. Cammina senza pensare a niente in particolare. Osserva i primi negozi che tirano su le saracinesche, i bar, gli uomini stretti in giacche pesanti che vanno a lavorare. Prova anche un leggero senso di pena per loro, perché andranno presto a rinchiudersi in un ufficio, in una banca, ovunque siano pagati per fare qualcosa che non vogliono fare Emilia no. Arriva in piazza. Sospesa in quest’atmosfera irreale, sonnolenta, senza contorni definiti. La sigaretta è quasi finita e le brucia l’indice. È allora che qualcosa nella sua testa pare scattare, o accendersi: è buffo, perché fino a quel momento non si era resa conto di essere in ciabatte e senza pantaloni nel centro della città. E fa anche un discreto freddo, a dire il vero. Probabilmente è il caso di tornare indietro. Vestirsi, magari. Tornare nel mondo dei civili e delle persone razionali. Abbandonare quell’attimo di pura e incomprensibile felicità. Poi, un altro dramma. Un urlo incrina quel silenzio di vetro. Un uomo le si avvicina di corsa. A pensarci, a ripensarci tempo dopo, Emilia non è per niente sicura che abbia gridato. O che le si sia gettato incontro con l’irruenza che le è rimasta scolpita nella memoria. Il signore belga si ferma davanti a lei. Le fa una domanda che perfettamente si adatta a quel clima surreale: non è importante la lingua in cui si esprime. Emilia lo capisce, e tanto basta. «Può allacciarmi la scarpa, per favore?» La risposta le esce dal cuore. Che in realtà non è una risposta, ma è un’altra domanda. «Perché?» Forse anche un po’ sgarbata. «Perché è l’unica cosa che non riesco a fare da solo», e sembra parlare con quel braccio che non ha, per dimostrare di non essere del tutto ammattito. Emilia non ci rimane male, non ci rimane in nessun modo. È normale. Si china e gli allaccia la scarpa.
Noi non ce la volevamo passare la notte a Orio. Noi, con i nostri bagagli a mano, le valige piene di caciotte e capicolli come sul Torino-Reggio Calabria, gli zaini che sapevano di strada e la biancheria di sapone sciacquato, noi avevamo orari e mete precise: arrivo a Francoforte alle 22, recupero bagagli, baci, abbracci, e via, a casa. E invece… Noi che abbiamo passato una notte a Orio di Emilia Cesiro … E invece, quel giorno lì, che era luglio, era umido. D’estate. Capita. L’aeroporto rimbombava, completamente isolato dall’esterno. Decolli, atterraggi, annunci, chiacchiere, scherzi, bambini,musica dalle cuffiette, dagli altoparlanti, dai negozi. E poi il tuono. E poi la pioggia. Quella pioggia obliqua e dura, che danneggia le foglie e le ali. Tutti i voli, subito, come se non aspettassero altro, erano annullati. E c’era una grande calma. Un minuto prima tutti a guardar su, i monitor, gli orari, gli annunci,. E un minuto dopo, quasi in silenzio, quasi obbedienti, eravamo tutti in fila, quasi ordinati, ognuno verso la sua compagnia. Eravamo educati. Tutti noi, ormai, sapevamo che c’era di peggio, ma la rapidità e l’efficienza ci avevano stordito. E qualcuno vagava, non sapeva cosa fare. C’eravamo accalcati alle porte a vetro dell’aeroporto, imbambolati, col broncio o col sorriso, a guardare quella pioggia obliqua, da cartone animato, a sud di Bergamo, a guardare i taxi che passavano, ed eravamo sempre di meno, sempre di meno. E poi siamo rimasti in cinque, o quasi. Avevamo un posto sul volo delle 6 per Francoforte. Non eravamo gli unici passeggeri, ma… Gli altri, qualcuno aveva preso la macchina e era tornato a casa perché abitava vicino, qualcun altro magari più avvezzo, s’era procurato una stanza in albergo. Perché c’erano gli alberghi attorno all’aeroporto. Però noi no, perché noi avevamo la testa in altre faccende, nella pioggia, nel broncio, nelle caciotte, nell’Italia a piedi che è tanto bella, e poi qualcuno di noi, i soldi in più, per quell’albergo, per quella macchina che poteva farla dormire su un materasso e sotto delle lenzuola pulite, e niente, i soldi per gli imprevisti non ce li aveva. C’era chi, tra di noi, era stato derubato proprio quel mattino lì, prima di partire, prima di prendere il treno, prima ancora di chiudere la valigia, i soldi dell’affitto, i soldi del viaggio, e allora di corsa in banca, di corsa a denunciare e a chiudere la valigia. E chi invece, tra di noi, aveva girato a piedi e in autostop e non vedeva proprio la differenza tra una sala d’aspetto in stazione, le stelle e l’aeroporto. E c’era chi era innamorato e allora troppi stupori per pensare pure a dove dormire. Tra noi, c’era anche qualcuno che, con grande sapienza, aveva fatto solo viaggi sul ponte, senza cabina, arrangiandosi per terra, anche se non aveva più l’età. Così, alla fine eravamo rimasti in cinque, in tutto l’aeroporto. C’eravamo guardati, noi cinque, e avevamo i capelli di chi viaggia da troppo tempo, e c’eravamo scelti e come i musicanti di Brema, aveva detto qualcuno, che però erano in quattro, avevamo cercato un riparo per la notte. Tra noi c’era qualcuno che aveva visto la cappella e allora aveva detto che si poteva dormire lì, e tra noi era stata quella innamorata a tradurre e quello derubato di noi aveva detto “vediamo”, gli altri due che avevano camminato tanto avevano già capito e erano pronti, ma la cappella era piccola e piena. Allora quella innamorata e quello derubato avevano detto, corriamo al duty free, perché c’era solo un bar e non aveva più neppure le pringles, e bisognava mangiare qualcosa, perché le caciotte e i capicolli nella sua valigia erano per il suo amore, ce l’aveva detto per onestà, e non si potevano toccare, e noi avevamo capito perché l’amore è fatto di formaggio, aveva detto in tedesco uno di noi. Avevamo comprato l’acqua e i tuc e la cioccolata e avevamo diviso, e quello di noi che era stato derubato ci aveva raccontato quando usciva da calcio con i suoi compagni e andavano a comprare l’estathè e le merendine, e niente, gli era piaciuto e noi ci sentivamo così, che ci sorridevamo a vicenda, pensando tutti che era una cosa così strana e così piacevole che forse ce la saremmo ricordata per sempre. Era una cosa così strana e così piacevole che forse ce la saremmo ricordata per sempre. Ma non c’era dove potersi sdraiare perché c’erano dei sedili ma erano saldati a terra e avevano i braccioli. smembravano fatti apposta per impedire che qualcuno ci si sdraiasse, come nei parchi i barboni, ma quale barbone prende e arriva fino a Orio, che non c’è nulla se non l’aeroporto e le sue aiuole strettissime e gli alberghi che i barboni non li fanno entrare. E allora, come barboni, come adolescenti le ultime sere di agosto avevamo trovato un posto, uno qualsiasi che ci stessimo tutti, perché è un aeroporto non una stazione e gli aeroporti una volta erano posti sicuri, c’eravamo seduti e avevamo tirato fuori dalla valigia qualcosa di più pesante e qualche asciugamano e a avevamo dormito lì, uno accanto all’altro, ma non proprio dormito perché magari si perdeva l’aereo e c’era una di noi che si preoccupava che le guardie ci cacciassero e che allora sarebbe stato un problema ma chi tra noi era innamorato e chi tra noi era derubato e chi tra noi aveva camminato tanto sapeva che non era così, e allora noi c’eravamo abbracciati tutti, e alla fine un po’ avevamo anche dormito. E poi al mattino, che aveva la stessa luce della notte, perché negli aeroporti è come all’autogrill, c’eravamo tranquilli messi in fila, prima al bar, poi al check in e al terminal, quasi in silenzio, e sull’aereo eravamo tutti separati e all’inizio ci guardavamo sereni, poi abbiamo smesso. Ad Amburgo, ci siamo aspettati e ci siamo abbracciati di nuovo, in una luce ancora più asettica e strana e non ci siamo visti mai più.