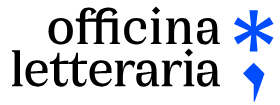di Marco Usai, racconto vincitore del concorso di Officina Letteraria
“Prima o poi entrerò nel cuore del mondo” era la frase che si era fatto tatuare l’estate della maturità. Parole ad effetto poco sopra le natiche, un’esca a caratteri gotici da aggiungere al piercing al sopracciglio che incorniciava lo sguardo scuro, fermo. Anche quando sorrideva, per lo più se in compagnia di qualche bella biondina glitterata, ad Alex restava appiccicato agli occhi qualcosa di malinconico. Mi faceva pensare a “Boys don’t cry”, con quel sound triste-allegro, tipo “vita innegabilmente amara ma stiamo quieti che così deve essere”. Insomma era un viveur con qualcosa di rotto dentro. Probabile che nei momenti felici gli capitasse di inciampare nel ricordo del fratello. Gli aveva insegnato i rudimenti dello stare al mondo per poi abbandonarlo senza neppure un ciao. Gente molto legata nonostante la differenza di età, con la stessa frase impressa sulla pelle, come uno stargate per l’aldilà, o forse un memo sul giungere al nocciolo di quel frutto succoso che la vita può essere solo a vent’anni.
C’è chi pensava fosse solo un buffone esibizionista Alex, io credo che semplicemente provasse a seguire quel dettame lasciatogli in eredità. Certe sere s’impossessava di lui una follia gaudente e rabbiosa che a stargli accanto la vita poteva sembrare un gioco infinito. Passavamo nottate a esplorare stradine deserte, mentre la città dormiva rubavamo caschi e specchietti per rivenderli a pochi euro. Mi sentivo libero mentre gli facevo da spalla nell’ennesima rissa che scatenava per futili motivi, eravamo immortali anche nel tornare a casa con il viso segnato o mentre improvvisavamo un rally nelle mulattiere sopra Genova a bordo dell’auto sottratta a chissà quale schiavo sfortunato. Eravamo i sovrani di un mondo popolato da comparse in bianco e nero, in noi l’anarchia assumeva un significato più di stomaco che d’idea, eravamo i soli ad esser vivi… Fino a che mio padre non perse il lavoro. Quella che sarebbe dovuta essere la mia estate indimenticabile divenne quella in cui appresi le regole del giogo. Trovai impiego in un discount in periferia, la mia vita venne scandita da turni e pause caffè, pranzi cronometrati e anima scherzata da frustrati dalla vita. Era brutto ma era necessario, lavoravo molte ore e molte non mi erano pagate ma non c’era altra via. Avevo perso le ali e il mondo intorno perdeva colore, uscivo sempre meno spesso, la stanchezza veniva a riscuotere il suo conto. Alex era sempre lo stesso cercava, il cuore del mondo mentre io sistemavo scatolette. Mi veniva spesso a trovare e mi piaceva vedere come fosse ancora indomito, lui che non aveva crucci. Non lo invidiavo, era lo stendardo della mia anima sopita e adoravo quando rispondeva maleducatamente a miei superiori che mi bistrattavano nelle tediose ore salariate. Era un potenziale cliente, poteva tutto e mi tributava indirette rappresaglie che non tardarono a ritorcersi contro di me. Dovetti dirgli di non tornare a trovarmi a lavoro, la prese a male e non lo vidi più neppure fuori. I giorni passavano tutti uguali, lavoravo sempre, unica nota positiva di quei mesi fu la notizia del furto a danno del gran capo.
Lo avevano alleggerito della sua moto da sogno, giusto mentre era parcheggiata sotto il discount.
Una sera uscii dopo mesi di ascetismo forzato, mi sentivo spaesato ma risi di gusto quando sotto casa trovai Alex in sella a quella stessa moto. La usava da settimane come fosse sua. Mi disse che si vive davvero solo intorno ai duecento orari o facendosi una tipa diversa ogni sera. Che io stavo al mondo come un morto. Sorrideva, sembrava volermi martoriare ma aveva gli occhi tristi, forse era ferito, forse si sentiva abbandonato. Non lo vidi più. Una mattina grigia d’autunno lessi un trafiletto che parlava di lui. Aveva perso il controllo di quella bestia da cento cavalli fuggendo dalla polizia. Mi piace pensare che abbia avuto un’estate indimenticabile, che almeno lui abbia vissuto il cuore del mondo che sogno ogni mattina.