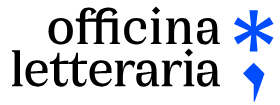di Massimiliano Maestrello
Racconto primo classificato al concorso letterario “Il mio vestito, una seconda pelle” di Officina Letteraria e Lo Spaventapasseri
Ci volle un incidente, perché Asso si liberasse del vecchio chiodo.
Quella giacca di pelle ce l’aveva sempre addosso, anche in estate. Arrotolava le maniche fino ai gomiti, e nelle serate più calde – quando l’afa schiacciava la campagna e non c’era un filo d’aria che attraversasse la terra piana e secca – portava solo quella. A petto nudo, con le costole appuntite che spingevano da sotto la pelle, sembrava una versione più giovane di Iggy Pop, magari di quello fotografato sulla copertina di Raw Power. E Iggy era apparso – in versione di toppa – anche su una manica del chiodo nero: un profilo in stoffa accompagnato dalla scritta The Idiot. Era durato qualche mese, Iggy, come succedeva a quasi tutte le toppe che finivano sulla giacca di Asso, in una sorta di rotazione continua che seguiva i suoi umori e le nuove scoperte musicali.
Il mio migliore amico era Ale, il fratello di Asso, e le nostre frequenti incursioni in camera sua, alla ricerca di fumetti e dischi di band che non avevamo mai sentito nominare, mi aveva permesso, in alcuni casi, di prevedere cosa Asso si sarebbe fatto cucire sulla giacca. C’erano vinili che per lunghi periodi rimanevano fissi sul piatto, le custodie con i testi abbandonate sul letto sfatto; oppure cassette che – nei pochi pomeriggi in cui Asso stava a casa, rinchiuso in camera, mentre io e Ale facevamo i compiti in cucina, aspettando che se ne andasse per andare a frugare tra le sue cose – si sentivano andare di continuo. I Doors, i Ramones, gli Iron Maiden, gli Exploited e poi, ancora, i Clash, i Sex Pistols e i Black Flag, io e Ale li scoprimmo in camera sua. E i loghi di queste band andarono a coprire, a turno, gli spazi liberi sulla giacca. Solo due toppe non cambiarono mai: la A cerchiata di anarchia, sulla manica sinistra del chiodo (che andò a sostituire la fugace apparizione dell’immagine di un hippy, visto di schiena, con la chitarra e un sacco a pelo arrotolato a tracolla: qualcosa che Asso dovette interpretare presto come troppo gentile per i suoi gusti) e quella che occupava tutta la schiena: un gigantesco dito medio sollevato, accompagnato da un esplicito Fuck You!
Ed era proprio quel dito che Asso, dalla schiena, ci sbatteva in faccia ogni mattina, quando ci sorpassava in sella al suo Ciao per andare a scuola. Noi salivamo sull’autobus che ci portava dal nostro piccolo paese verso il comune più vicino, a venti chilometri, che poteva contare su una sede staccata del liceo e su un paio di istituti tecnici superiori. Salivamo a un orario imbarazzante – le 6 e 40 del mattino – e subivamo questo giro assurdo tra i paesi e le frazioni limitrofe, con il rumore dei freni che fischiavano, lo sbuffo delle porte che si aprivano e poi si richiudevano e il sobbalzo della ripartenza che ci entrava nelle orecchie e nel corpo tipo duemila volte ogni mattina, visto che il bus faceva tutte le fermate. “L’autobus della sfiga”, lo chiamava Asso, che si svegliava all’ultimo minuto e, tagliando per un paio di strade in mezzo ai campi, riusciva sempre a raggiungerci sul tratto di statale che immetteva al paese. Faceva gracchiare il clacson del Ciao mentre eravamo fermi alla penultima fermata dove salivano questi due tizi che avevano sempre degli zaini enormi e non si capiva perché non andassero a scuola a piedi o in bicicletta; ci superava, Asso, e, mentre noi schiacciavamo le facce sui finestrini – come se non bastasse l’immagine sulla schiena – ribadiva il concetto alzando in aria la mano con il dito teso. Era divertente quando pioveva a dirotto o c’era una nebbia talmente fitta che non si vedeva a un palmo di distanza: anche in quelle occasioni, Asso ci superava, bagnato fradicio, con i capelli lunghi incollati alla testa per via dell’acqua, i jeans completamente zuppi; oppure appariva d’improvviso, la luce fioca del fanale del Ciao che spuntava in mezzo alla foschia di un mattino invernale, alzava il dito e si buttava nell’altra corsia, superando il bus, senza badare minimamente al fatto che dall’altro senso di marcia potessero arrivare, nascosti dalla nebbia, macchine, camion o trattori. Qualche volta, quando il Ciao lo lasciava a piedi, Asso era costretto a salire sull’autobus della sfiga. Attraversava il corridoio, e lungo il tragitto poteva fare cose tipo spaccare i righelli da cinquanta centimetri che spuntavano dalle cartelline di educazione tecnica. Poi, andava a sedersi nel sedile al centro dell’ultima fila, un posto che riteneva suo senza bisogno di alcuna parola. Si annoiava, a stare seduto lì, e starlo a guardare poteva farti venire l’ansia: era in continuo movimento, infilava le dita nei buchi dei poggiatesta, strappava pezzi di gommapiuma e li lanciava in giro; bruciacchiava la plastica attorno ai finestrini con la fiamma dell’accendino, scriveva e disegnava con l’Uniposca sui sedili – cazzi tracciati con mano tremante, perlopiù. Sembrava alla ricerca costante di nemici, Asso, e questi potevano mutare forma in ogni momento: potevano essere i ragazzini ordinati che mettevano gli zaini poggiati sulle ginocchia mentre viaggiavamo sull’autobus della sfiga – glieli tirava a terra con una manata e diceva «Cos’è, la mamma ti ha detto che non devi sporcarti?» – o il materiale scolastico, dai banchi agli strumenti del laboratorio (era stato sospeso tre giorni per aver dato fuoco a un cestino della spazzatura durante l’ora di educazione fisica e averlo lanciato in palestra al grido di «Palla di fuoco!»); oppure potevano essere i vigili urbani o semplici passanti che incrociava e che, per qualche motivo, non gli andavano troppo a genio. Aveva però questo strano senso di appartenenza al paese, perciò lo stesso ragazzino che poteva prendersi uno schiaffo potente sul collo quando scendeva dall’autobus, diventava una specie di suo protetto quando era in mezzo agli altri; o meglio, lo eravamo un po’ tutti, suoi protetti, per il semplice fatto di venire dallo stesso posto sperduto in mezzo alla campagna, e le poche volte in cui qualcuno aveva avuto da questionare, Asso si era messo in mezzo andando direttamente dal tizio foresto e dicendogli secco cosa gli avrebbe fatto se avesse avuto voglia di mettere le mani addosso a uno del paese. E c’era il rischio che lo facesse davvero, perciò nessuno aveva troppa voglia di mettersi contro quel tipo che sembrava un matto venuto da chissà dove. In tutto questo – mentre crescevo con la convinzione che buona parte della vita di un adolescente fosse governata da delle dinamiche che erano una versione agreste de I guerrieri della notte – io, da Asso, ricevevo una specie di trattamento di favore: perché ero il migliore amico di suo fratello e perché – credo – sapevo suonare la chitarra abbastanza bene, cosa che a lui non riusciva. Ogni tanto, quando io e Ale ci trovavamo a strimpellare, spuntava dalla sua camera e mi chiedeva di rifargli un riff o un paio di strofe di una canzone – quasi tutte le avevo ascoltate da lui, la prima volta – e, se ne andava poi via annuendo soddisfatto, proprio come se lui fosse il mio maestro, e io un allievo che stesse facendo dei grandi progressi.
L’incidente avvenne nell’inverno in cui io e Ale frequentavamo il primo anno di università.
L’incidente avvenne nell’inverno in cui io e Ale frequentavamo il primo anno di università. Io tornai a casa solo due weekend più tardi, perciò mi raccontò tutto Ale, con una telefonata allarmata che si aggiunse alla solita che ci facevamo una volta a settimana per tenerci aggiornati. Era una serata di fine novembre, attorno alle sei e mezza di sera. Asso era uscito dall’officina in cui lavorava e si stava dirigendo al bar dove avrebbe bevuto la solita birra prima di cena. In sella al Ciao, imboccò la statale. Dopo qualche chilometro, dall’altro lato di marcia, vide arrivare una macchina della polizia a tutta velocità, le sirene che illuminavano di blu il buio circostante. Nonostante la strada fosse completamente libera, la macchina, all’ultimo istante, invase la corsia su cui viaggiava Asso. Più tardi, i poliziotti dissero di essere stati impegnati in un inseguimento di un veicolo sospetto. Ma questo non cambiò la sostanza delle cose: Asso se li vide venire addosso, ma non poteva nemmeno provare a gettarsi nel fosso che costeggiava la strada, perché lungo quel tratto correva il guardrail. Perciò – anche se lo ammise solo molto tempo dopo e solo davanti ad Ale – svenne. Ci fu l’impatto. Il Ciao si accartocciò formando, forse, una specie di fragilissimo scudo. Asso, per qualche strana ragione, rimase agganciato al paraurti anteriore e venne trascinato sull’asfalto per tutti i metri che servirono alla frenata. Portava il chiodo, ovviamente, e per un bel po’ di tempo, dopo che era uscito dall’ospedale, mostrava i gomiti e gli avambracci spellati e graffiati in cui la pelle della giacca si era come fusa alla sua, in una miriade di microscopici puntini neri.
«Ma Asso aveva bevuto?» chiesi a Ale, la sera della telefonata. Non era una novità per nessuno, e nemmeno il fatto che ogni tanto esagerasse anche con altre cose. E Ale, che – mi accorsi – sentii preoccupato per suo fratello maggiore per la prima volta, mi disse di no. Mentre era sul Ciao no, non aveva ancora bevuto. «E comunque» aggiunse, «ho visto la strada. Sono andato a vedere. C’è ancora la traccia della frenata. Sono loro che hanno invaso la corsia. Sono loro che gli sono andati addosso». Non so quanto contò il fatto che Asso fosse il personaggio che era: durante il ricovero ne approfittarono per fargli tutti gli esami del caso: risultò – come era ovvio – una certa abitudine al consumo di alcol, e la positività al test delle droghe. Il che – com’era altrettanto ovvio – non influiva minimamente sulla dinamica dell’incidente. Alla fine, comunque, i poliziotti se la cavarono con un rimborso ridicolo, considerato come avevano ridotto Asso. Con un po’ di quei soldi, lui si comprò un’acustica che credo non suonò più di due volte, e poi si apprestò ad affrontare i nove mesi di malattia che gli avevano dato in ospedale. Con la scorza che aveva e la solita arroganza, Asso si rimise in piedi in poco più di due mesi e si trovò di fronte a una sorta di vacanza lunghissima e non attesa. Credo che cominciò tutto in quel periodo, mentre io finivo in maniera incredibilmente positiva la sessione di esami e mi premiavo con una vacanza estiva a Amsterdam insieme a una compagna di corso. Al paese tornavo sempre meno: mi sembrava un mondo distante, di cui mi arrivavano notizie brevi e sfilacciate dalle telefonate con Ale. Iniziai anche a lavorare: quattro sere alla settimana in un pub. Riuscivo a pagarmi l’affitto della casa che condividevo con altri tre studenti e pure a mettere da parte qualcosa. Finì che tornai a casa solo per le vacanze di Natale. Mi vidi con Ale due giorni prima della vigilia, e fu in quell’occasione che mi raccontò del casino successo negli ultimi mesi. Mi sentii piccolo e stupido per aver riempito settimane su settimane di telefonate con impressioni di viaggio e sciocchi drammi da universitario e di notizie su Roberta e di dettagli delle due avventure che mi erano capitate dopo che io e lei avevamo deciso di restare solo amici; e anche un po’ tradito, per il fatto che mi avesse nascosto tutto fino a quel momento. «Volevo dirtelo di persona» disse Ale. Comunque, erano riusciti a convincerlo: Asso entrava in comunità a gennaio.

Il giorno dopo andai in cerca di regali: dovetti girare un bel po’ per trovare un chiodo, sembrava non li mettesse più nessuno. Lo trovai in un negozio, in città, che vendeva abbigliamento per dark e metallari. Lo feci impacchettare; la mattina di Natale andai a casa di Ale. Rividi Asso per la prima volta dopo un bel po’ di tempo e no, non stava decisamente bene. Sembrava invecchiato tutto di colpo e pareva impossibile che avesse solo tre anni più di noi. Però fu contento di vedermi – mi abbracciò, anche, una cosa che non gli avevo mai visto fare, sebbene con un abbraccio che poteva confondersi con quello di due compagni di sbronze che si ritrovano al bar – e fu felice che gli avessi portato un regalo. Aprì il pacchetto da un lato, poi si fermò e disse: «Ti ha detto tutto, Ale?».
«Di cosa?» dissi, fingendo.
Asso sorrise un attimo soltanto: «Lo sai» rispose. Poi strappò il resto del nastro adesivo e scartò il pacco e fu contento di trovarci quel nuovo chiodo. Disse che era dall’incidente che non ne metteva uno e che quei figli di puttana degli sbirri l’avevano trascinato sull’asfalto per così tanti metri che la pelle della giacca gli era entrata dentro lo sua. Ma non alzò le maniche della camicia per farmi vedere dove era successo quel disastro. Se lo infilò e si guardò allo specchio dell’armadio che teneva in camera. «Eccolo qua, il vecchio Asso» diceva, girandosi da un lato e dall’altro. Ma non riuscivo a guardare come – nonostante fosse la taglia più piccola che avessi trovato – gli stesse comunque troppo largo. Era dimagrito ancora, ma della magrezza sana e nervosa di prima non c’era quasi più traccia. Buttai uno sguardo alla camera: il letto era sempre sfatto, ma il piatto del giradischi era vuoto. Le cose erano state sistemate – probabilmente dai genitori di Asso e Ale – e sembrava che da lì, da sopra le mensole e dagli scaffali, non avesse più voglia di muoverle.
Tornai a casa per Pasqua. Nei quattro mesi dall’ultima volta che ci eravamo visti, Ale mi teneva aggiornato su Asso. Il fatto, mi raccontava, era che non potevano trattenerlo contro la sua volontà. Perciò, dopo un periodo iniziale piuttosto buono, aveva cominciato a scappare dalla comunità: prima una notte, poi un giorno, poi per periodi sempre più lunghi. Non sapevo cosa gli facessero fare in comunità, ma mi sembrava di vederlo, Asso, su una sedia, che si agitava come faceva quando era costretto a viaggiare sull’autobus della sfiga. Me lo immaginavo che usciva di notte e scavalcava un muro – nella mia testa la comunità aveva un muro di recinzione come quello di un carcere – con movimenti agili come quelli di Iggy Pop sul palco. Il fatto, mi diceva Ale, è che un tossico, se vuole, trova la roba in due minuti. Era la prima volta che lo sentivo chiamare suo fratello così: tossico.
«Comunque» mi disse Ale, pochi giorni prima che tornassi al paese, «per Pasqua torna a casa. Forse riusciamo a tenerlo meglio sotto controllo».
Non era così. La sera dopo Pasquetta io e Ale stavamo bevendo una birra in un locale in città. Era l’una passata da poco, quando gli arrivò la chiamata dei suoi genitori: Asso era uscito dopo cena e non era ancora rientrato. I suoi avevano provato a cercarlo in giro, ma non erano riusciti a trovarlo da nessuna parte. Avevamo raggiunto il locale con la mia macchina, per cui mi offrii di accompagnare Ale nella ricerca. Guidai, mentre lui si mordeva le unghie e mi diceva di andare in zona industriale e poi nel parchetto dietro il municipio e nella casa abbandonata alla fine del paese. Non lo trovammo. Ale disse: «Dobbiamo provare nei campi». Dopo più di mezz’ora Ale scorse lo scooter che Asso usava da dopo l’incidente col Ciao: era parcheggiato lungo la sterrata che portava in un grande terreno privato. Scendemmo e corremmo in quella direzione. Asso era poco distante, sdraiato sulla riva del piccolo fosso, con i piedi che toccavamo l’acqua verde e marcia. Aiutai Ale a tirarlo su di lì, a metterlo seduto, poi feci un paio di passi indietro. Guardavo il mio amico, in ginocchio davanti a lui, prenderlo a schiaffi sul viso, dirgli: «Oh, ci sei?», mentre Asso prima sbandava soltanto da un lato e dell’altro e poi cominciava a rispondere, mugugnando qualcosa e sputando per terra. Fu allora che sentii le gambe tremare. Ale si alzò. Non sapevo dire che espressione avesse. Prese il cellulare dalla tasca e chiamò a casa. Io rimasi immobile, pochi passi dietro a Asso. Non sapevo nemmeno se avesse capito che ero lì. Mi resi conto in quel momento che aveva addosso il chiodo che gli avevo regalato. Sopra, non ci aveva appiccicato nemmeno una toppa. Lo guardai passarsi una mano sporca tra i capelli, tirarseli indietro dicendo qualcosa che non riuscivo a capire. Guardavo solo la sua schiena, tutto quello spazio vuoto e nero che non sapeva più come riempire.