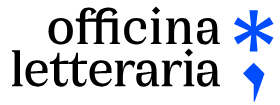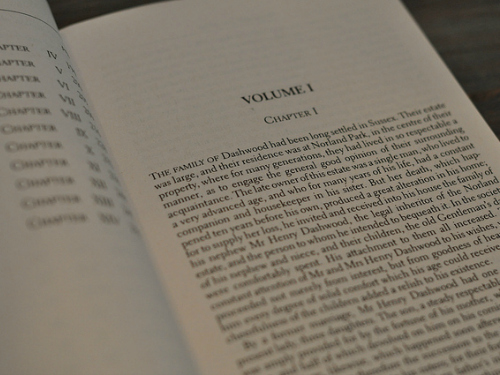Il mio primo libro è stata una rielaborazione per bambini dell’Odissea. Non il primo libro che ho letto, ma il primo che ha avuto un significato. Mi affascinava il personaggio di Atena: astuta, coraggiosa, indipendente, probabilmente bisessuale, una mosca impertinente nel cervello di Zeus che dovette farsi spaccare il cranio per lasciarla nascere. Ognuno di noi lo ha, un primo libro. E un secondo, un terzo, un quarto. Per Giorgio Fontana e Marco Missiroli sono stati, rispettivamente, le storie di Topolino sceneggiate da Rodolfo Cimino e Ti prendo e ti porto via di Niccolò Ammaniti. Non un piacevole ricordo d’infanzia o dell’adolescenza, ma il primo mattoncino che compone la loro identità di scrittori. Di lettori. Hanno scelto questo tema, nel presenziare al Festival della Mente di Sarzana: regalare ai fan, ai lettori, a chi li conosce di sfuggita o per nulla, i libri che hanno fatto di loro i lettori (e gli scrittori) che sono. I mattoncini del percorso letterario che li ha portati fin qui. I loro perché. Perché quella certa opera. Perché quella particolare attenzione alla forma, alla lingua. Perché la vita o la morte di quell’autore li ha colpiti così tanto. Perché quell’opera, quello scrittore, e non altri. Perché io Kafka e tu Carrère. Perché io Philip e tu Joseph (Roth). Perché Il vecchio e il mare e non Addio alle armi. Perché gli scrittori che ti hanno ispirato sono tutti uomini. Perché molti si sono suicidati. Perché alcuni, quando hai la fortuna di incontrarli, ti risultano così antipatici che vorresti non leggerli mai più. Perché, di altri, sei diventato amico. Li ascolto e mi chiedo quanto ci è voluto, per tirare fuori dal cilindro dieci libri (o giù di lì) a testa. Se sono venuti fuori di getto, d’istinto, o dopo lunghe peregrinazioni tra gli scaffali di casa, i taccuini, l’account su aNobii finché lo hanno tenuto aggiornato. Ammesso che l’abbiano mai avuto. Li ascolto e mi viene voglia di comprare tutti i loro libri e cercare una traccia, la traccia di quella volta che hanno pianto mentre il personaggio cieco di Carver disegnava una cattedrale. Di quella volta che hanno ringraziato Buzzati di aver scritto d’amore, mentre i grandi del suo tempo lo ritenevano un tema di poca dignità. Di quella volta che si sono fidati di Bernard Malamud e gli è andata bene, perché Malamud è uno di quelli che non tradisce mai il proprio lettore. Li ascolto e ripenso ad Atena, che questa cosa di Atena la vorrei raccontare a qualcuno. Mentre nella mia testa al mattoncino omerico se ne affianca un secondo, e un terzo, e un quarto. Li ascolto e credo che non ci sia modo più tenero per conoscere meglio una persona. Farla sedere e raccontare. Quale libro ti ha ispirato un viaggio, quale ti ha fatto venire voglia di scrivere, quale ti ha esaurito la scorta di fazzoletti, quale ti ha fatto addormentare alle tre di notte senza renderti conto che era passato tutto quel tempo. Io uno dei miei te l’ho detto, e chi mi conosce sa che non ho la confidenza facile. Vorrei tanto sapere i tuoi. Fai con calma, riflettici, dimmene uno, cinque, otto o dieci. Dimmi perché. Mentre lo dici, emoziónati. Altrimenti non funziona.
Recensione di Marta Traverso. Incontra David Foster Wallace in un autogrill a due ore e mezza da Chicago. Un luogo così remoto che se non fosse per il suo accompagnatore Dan, a cui non sembra vero di poter conoscere di persona il suo idolo, Livia non lo avrebbe mai rintracciato. Mavis Gallant, invece, non sapeva chi fosse. È stato Mordecai Richler (quello de La versione di Barney) a spiegarle – con buona pace di Alice Munro – che era la più grande scrittrice canadese vivente. Oltre cento racconti pubblicati sul New Yorker, fra le altre cose. Livia e Mavis sono diventate ottime amiche, con il passare degli anni. Paula Fox la riceve in casa sua. Ha novant’anni, e fatica a ricordarsi cosa ha detto un istante prima. Suo marito Martin Greenberg, novantacinque anni, è al piano di sopra a lavorare a una traduzione di Von Kleist. Di sua nipote Courtney Love (sì, proprio lei, vedova Cobain) non ne vuole parlare. A onor del vero, sono molti i temi tabù, almeno in quella fase iniziale di diffidenza tra intervistatrice e intervistato. Finché scatta la scintilla, chimica, incontro di anime, chiamatelo come vi pare. Livia Manera Sambuy ha intervistato molti scrittori e scrittrici nei suoi viaggi lungo gli Stati Uniti, e si è sentita spesso dire: non parliamo di questo, né di quest’altro, «ti proibisco di scrivere di me». Da qui il titolo Non scrivere di me (Feltrinelli, 2015), Livia che socchiude la porta del suo mondo, ci lascia scorgere tra le valigie e i passi affrettati, da Parigi a New York, da Milano al Madagascar, in tasca il suo amore per la letteratura americana, uno dei lavori più belli che ci siano, il suo. So solo che è la mia vita, la vita di una persona che ha fatto del leggere il proprio mestiere. Anche Philip Roth era diffidente, tanto che la prima volta non volle neppure incontrarla. Quattordici ore (o giù di lì) di aereo e tutto quello che è disposto a concederle è una telefonata? Si è fatto perdonare con un invito a cena. Ne è nato un legame oltre ogni immaginazione, tanto da far dire a Roth “Avremmo dovuto incontrarci venticinque anni fa. Avremmo cambiato le nostre vite”, tanto da regalare a noi il documentario Philip Roth. Una storia americana, che Livia ha pazientemente diretto. Lei fu tra le prime persone a ricevere la notizia, con mesi di anticipo rispetto al resto del mondo: “Mia cara, è arrivato il momento di tirare giù la saracinesca e chiudere bottega. Perché abbia buttato via la mia vita con i libri e con le donne è un mistero” Ed è stato proprio Roth a suggerirle l’intervista a Judith Thurman, autentica ispiratrice del film La mia Africa. Lui l’ha conosciuta dopo averle scritto una lettera di ammirazione per la sua biografia di Karen Blixen. Sì, ricevere una lettera di ammirazione da Philip Roth. Quando Livia entra nell’ufficio di Joe Mitchell, nella sede del New Yorker, non le sembra vero che quell’anziano redattore così dedito al lavoro non pubblichi più nulla dal 1964. Il suo romanzo più celebre è la biografia di Joseph Ferdinand Gould, il bizzarro scrittore che traduceva poesie nella lingua dei gabbiani. Realmente esistito, googlare per credere. Poi James Purdy, il genio prigioniero di un’epoca in cui l’orientamento sessuale di una persona – se di dominio pubblico – poteva mettere in ombra tutto il resto. E di uomini nell’ombra scrisse, per tutta la vita. Livia lo ha incontrato una sera che c’era una forte tempesta di neve e, come tutti, anche James ha socchiuso davanti a lei un pezzetto del suo mondo. La sua valvola di sfogo fin dall’infanzia? Scrivere rabbiose lettere anonime che poi non spedisce. Il solo scriverle basta a rilassarlo, almeno per un po’. E che emozione Richard Ford, mentre le racconta di quella volta che lui e Raymond Carver videro una ragazza bellissima uccidere e spiumare un’anatra a colpi di accetta, si guardarono l’un l’altro e dissero: «Scommettiamo che ti batto e arrivo prima io a metterla in un racconto?» «Scommettiamo di no?»
Prima di iniziare a leggere Il poeta dell’aria sono andata su YouTube. Già, perché il blog di Chicca Gagliardo lo seguo da tempo, avevo presente la sua faccia, ma non avevo mai sentito la sua voce. Ho trovato un solo video in cui parla di questo libro, una breve intervista, con una frase che mi ha colpita: Ogni lettore troverà il proprio modo di volare. Il sottotitolo è infatti Romanzo in 33 lezioni di volo, e il protagonista è un poeta che dal suo cornicione osserva la città e ne respira l’aria. Quell’aria che è sempre con noi, anche quando non la sentiamo, quando “non tira un alito di vento” e invece l’aria c’è, e ci accompagna, in qualche modo. È grazie all’aria se le parole che pronunciamo arrivano all’orecchio di qualcuno, se i suoni del mondo vibrano al tocco del nostro timpano. L’aria è anche quella forza che le tiene su, le parole, le fa volare. Il poeta che mi insegna, giorno dopo giorno, a volare (sì, a me che sto leggendo, e se anche tu leggerai questo libro capirai il perché), ha imparato a scrivere da Anfibio, un poeta più anziano. Questi versi sono solo belli, nient’altro. (…) Sì, adesso si sente la tua voce, ma solo la tua voce. (…) Nell’aria ciò che scrivi e respiri diventa un’unica nota. (…) Giura che mai scriverai parole costrette a restare inchiodate sulla pagina. Tentativo dopo tentativo, il poeta Volatore dona vita a quella che Italo Calvino definì la poesia dell’invisibile, la poesia delle infinite potenzialità imprevedibili, la poesia del nulla. Chi si diletta di scrittura conosce bene questa sensazione. Volare con la mente, con la fantasia, perché è lì (nell’aria, appunto) che nascono le storie. Ed è solo uno dei molti modi e obiettivi in cui possiamo entrare in comunione con l’aria. Una lezione che il protagonista ci ricorda ben trentatre volte, con il suo tono fiabesco e disincantato, leggero. Ce lo ricorda sulla carta, che è fatta di materia e non di aria, vero, ma non c’è niente di male nel fermarsi ogni tanto, lasciarsi catturare da quello strano senso di vertigine, prendere fiato e poi ricominciare a volare. Basta un respiro per modificare il paesaggio dell’aria. Post Scriptum. Ho iniziato questa recensione citando il blog di Chicca, e siccome repetita iuvant, ti consiglio di volare fin laggiù, quando ne avrai voglia.
Segnaliamo in uscita per la casa editrice Emma Books Verso Sud, il quarto romanzo di Emilia Marasco, coordinatrice di Officina Letteraria. Un viaggio da Genova alla Puglia alla riscoperta delle proprie radici, per rimettere insieme i frammenti del passato. Il viaggio di Nora, il viaggio di Caterina, il viaggio di Paola. Giovedì 12 febbraio alle ore 20:00 si tiene a La Claque (Genova) la prima presentazione del romanzo, nell’ambito della rassegna teatrale Occhiali d’Oro organizzata da Approdo Ostilia Mulas – Arcigay Genova. Introduce Marta Traverso, letture a cura di Sara Sorrentino. Sinossi del romanzo Nora e Caterina, madre e figlia, per tutta la vita hanno avuto una relazione difficile nutrita di silenzi e di gesti mancati. Quando Nora muore, tra gli oggetti appartenuti alla madre Caterina trova i frammenti di una storia che non conosceva. Inizia così un viaggio a ritroso nel tempo, verso sud, da Genova alla Puglia. A spingere Caterina a partire, solo piccoli indizi: un abito da sposa di seta da paracadute, un camicino da neonato, poche lettere, qualche fotografia. “L’estate del ’43. In autobus Caterina pensa a Nora ventenne, nelle foto, che guarda il fidanzato americano. Chissà cosa facevano quando s’incontravano, stavano in famiglia, passeggiavano sulla piazza sotto gli occhi di nonna Rita, chissà se andavano al mare. Il paese è in campagna ma il mare è vicino. Nora amava il sole, amava nuotare, chissà se andava in spiaggia con quei costumi castigatissimi dell’epoca. Finché, un giorno, lui parte per una missione, a bombardare qualche città in Germania, e non torna più. Nora rimane col suo abito da sposa di seta del paracadute. Perché il paese parlò? Uno scandalo? Un segreto? Vorrebbe poter tornare nella casa di Nora, la casa dove lei è cresciuta, sedersi in un angolo e ricostruire le conversazioni, le liti, cercare di rivedere Nora entrare e uscire, muoversi da una stanza all’altra, rivedere nonna Rita, rivedere suo padre.” Caterina non sarà sola nel suo viaggio verso sud. Accanto a lei, Paola. E avvicinandosi alla storia di sua madre, Caterina si avvicinerà anche a una parte sconosciuta di sé. Vi aspettiamo dunque giovedì 12 febbraio a La Claque La presentazione sarà accompagnata da un aperitivo (a partire dalle 19:00). Seguirà, alle 21.15, lo spettacolo Metafisica dell’amore a cura della compagnia Le Brugole.
Scena di apparente vita quotidiana: un ragazzo sotto la doccia. Solo che non vuole lavarsi da solo, o non è in grado, o non gli viene permesso. Sono le infermiere a farlo per lui. Ogni mattina, uno scroscio di resina di pino silvestre, il sangue degli alberi, striscia lungo il suo tronco sotto forma di bagnoschiuma, graffia la sua corteccia, soffoca le foglie tra i suoi capelli. Ogni mattina, l’acqua ripulisce l’emorragia di un albero tramutato in sapone, mentre il corpo del ragazzo resta inerte sotto le mani altrui. Ogni mattina, l’acqua ripulisce l’emorragia di un albero tramutato in sapone, mentre il corpo del ragazzo resta inerte sotto le mani altrui Con questa immagine inizia A testa in giù, romanzo di Elena Mearini appena pubblicato da Morellini Editore. Gioele abita il mondo costruito nella sua mente, confinato in un muro di silenzio che lui stesso cerca e si impone, mentre all’esterno i degenti e il personale dell’istituto tentano inutilmente di “salvarlo”. Gioele è un picchiato in testa: così si definisce, così sa di essere definito. È la sua natura. Eppure, sarebbe così semplice comprendere la verità: non siamo tutti fatti per comunicare attraverso la voce. La voce di Gioele non è quella che esce dalle vibrazioni dentro la bocca: è quella del picchiettio delle mani e dei piedi, della testa contro il muro, degli oggetti che cadono e sbattono. “La mia voce è il suono, io dico con i rumori” Sono i suoni a portarlo fuori dalle mura dell’istituto, un giorno. Sono i suoni a farlo montare su Domingo, mettere in moto, guidare per alcuni metri e quasi investire una signora in bicicletta. Maria monta sul sedile passeggero, vuole andare al Pronto Soccorso, poi no, fuori Milano, in campagna, dov’è nata e cresciuta e dove si annidano i suoi ricordi. Maria è un fiume di parole, parla, parla, parla dell’uomo che da bambina le faceva male in mezzo ai cespugli, delle patate da raccogliere, della sua mamma, del signore Gesù che lei ama così tanto, di suo marito che amava di più il vino, di sua sorella Eleonora che era incinta e nessuno la voleva. Maria parla con la voce, Gioele risponde battendo sul volante, uno-due, uno-due. Finché, chilometro dopo chilometro, sentono l’uno nell’altra il richiamo del sangue che scorre lungo le loro cortecce ferite. Un romanzo che è poesia, che traduce le immagini tipiche della scrittura di Elena Mearini in un crescendo di emozioni, attraverso due voci narranti così in apparenza lontane ma in realtà simili più che mai. Un romanzo che ci ricorda che in ciascuno di noi si nasconde una storia.
Pubblicato lo scorso ottobre, Codice a sbarre è una raccolta di racconti scritta da otto ospiti della Casa Circondariale Femminile di Empoli e curata da Patrizia Tellini. L’antologia è il risultato finale di un laboratorio di scrittura creativa, in cui le esperienze di vita e le emozioni sono state protagoniste, ideato e curato dalla casa editrice Ibiskos Risolo. Per conoscere meglio questo progetto, abbiamo chiesto un contributo a Graziano Pujia, direttore della Casa Circondariale Femminile di Empoli. Questo il suo intervento per il blog di Officina Letteraria. Il progetto è nato quasi per caso: la d.ssa Risolo (Ibiskos editore) ha letto un’intervista rilasciata da Patrizia Tellini e, spinta dalla curiosità di conoscere il lato femminile del mondo penitenziario, si è recata da me, assieme alla stessa Tellini, per propormi il progetto che avrebbe consentito alle ospiti della struttura che dirigo di raccontare il proprio vissuto detentivo e pre-detentivo. Tra i motivi che mi ha spinto ad aderire al progetto con entusiasmo vi è stata l’idea di contribuire ad abbattere i pregiudizi che la società civile ha nei confronti dell’istituzione carcere. Già, ma in che modo? Ritengo innanzitutto che l’istituzione carcere non si debba considerare istituzione “negata”, nei termini messi ben in evidenza da F. Basaglia negli anni ’60 riferendosi ai manicomi criminali, ma, allo stesso modo, non la si debba considerare istituzione “ultima”, ossia necessaria ma residuale, quasi come a volersene dimenticare, salvo poi interessarsene, solo occasionalmente, in presenza di criticità esplose al di fuori dell’ambiente penitenziario, forse proprio per mancanza delle dovute attenzioni. Per fare ciò occorrerebbe creare continue sinergie, in primis, tra le istituzioni (mi vengono in mente le scuole e il mondo universitario, quest’ultimo finora interessato al mondo penitenziario più come oggetto di analisi che con intenti inclusivi). A tal proposito ritengo sia utile rimarcare l’esempio del progetto “oltre i muri”, che si rinnova ormai da diversi anni, tra il liceo Pontormo di Empoli e il carcere femminile della città, che prevede la preparazione di un’opera teatrale i cui protagonisti/attori sono studenti e detenute, diretti da registi professionisti. È dunque importante creare sinergie con gli enti territoriali (comuni e regioni) affinché affrontino le problematiche penitenziarie con gli stessi stimoli con i quali cercano di risolvere le questioni dei cittadini del territorio di propria competenza. In altri termini, considerare i detenuti al pari dei cittadini, perché tali sono e perché il carcere è soltanto una parentesi della loro vita, alla fine della quale sono “a fortiori” re-immessi nel tessuto sociale, che deve essere pronto ad accoglierli, salvo non si voglia che lo stesso venga nuovamente danneggiato dalla recidiva. Nel contesto sommariamente tracciato svolgono un ruolo di primaria importanza la scrittura e ogni altra forma di creatività (vedi teatro), quali fattori di crescita e di ricerca introspettiva, che aiuti a far emergere la parte migliore di sé; quella parte fino ad allora sopita da desideri “finiti”. Per dirla con Richler: la speranza è che come sono stati grandi nel pensiero (attraverso la scrittura), lo siano anche nelle azioni future. Il ricavato di questo progetto andrà, per espresso desiderio delle autrici e condiviso da Ibiskos editore, al Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, che si prende cura di donne che hanno subito violenza di ogni genere. A questo progetto si può contribuire in due modi: acquistando il libro e divulgando l’idea alla base del progetto medesimo. Per acquistare una copia del libro, è possibile contattare la casa editrice Ibiskos all’indirizzo mail segreteria@ibiskoseditricerisolo.it.
“È verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie”. L’incipit di Orgoglio e pregiudizio, forse uno dei più noti nella storia della letteratura, riassume con tagliente semplicità il leitmotiv della scrittura di Jane Austen. La sua vita è trascorsa fra le confortevoli quattro mura della casa nell’Hampshire, in compagnia della madre e delle sorelle, mentre il mondo là fuori esplodeva per gli stravolgimenti economici e sociali derivati dalla rivoluzione industriale e Mary Wollstonecraft (madre di Mary Shelley, autrice di Frankenstein) pubblicava il primo volumetto britannico sul tema dell’emancipazione delle donne, precursore del movimento delle suffragette. Come classificare una scrittrice di estrazione borghese, vissuta alle spalle dell’era vittoriana e morta “senza marito” a soli 42 anni? Conformista o femminista? Inguaribile romantica o unica ispiratrice della Stanza tutta per sé di Virginia Woolf? “Ragione e sentimento”, “Orgoglio e pregiudizio”, “Mansfield park”, “Emma”, “L’abbazia di Northanger”, “Persuasione”. I sei romanzi di Austen dipingono un percorso di formazione dell’io femminile che scardina con ironia le convenzioni sociali in cui la stessa autrice vive e nelle quali ha piena fiducia. Le sue protagoniste-tipo, che non hanno precedenti in letteratura, sono consapevoli del loro ruolo nella società – in cui avere un marito e una dote ha un’importanza cruciale – ma rivendicano la volontà di sposarsi per amore e per libera scelta, non per imposizione o convenienza. Le donne e gli uomini che ambiscono a tale destino, ricordiamo, sono i villain, i “cattivi” (o le “cattive”) della storia (Lucy Steele, Charlotte Lucas, Mr Elton). L’esplosione finale delle sue storie non è il matrimonio, ma la ricerca della felicità. La costante ricerca di qualcuno da amare non si limita alla vita matrimoniale. Nessun personaggio di Austen agisce nella solitudine, ciascuna ha un proprio contraltare in una co-protagonista – quasi sempre diversa per carattere e ambizioni – con cui coltiva un profondo legame di sorellanza. Pensiamo a cos’ha rappresentato Jane Bennett per la sorella Elizabeth, Elinor Dashwood per Marianne, fino a Lady Russell per Anne Elliott. Visti uno dopo l’altro, nell’ordine cronologico in cui sono stati scritti, i sei romanzi costituiscono un inedito percorso di formazione, in cui le protagoniste (come fossero sei facce di una stessa medaglia) sperimentano una «trasformazione del sé in relazione con l’altro.» Il saggio di Liliana Rampello “Sei romanzi perfetti“, edito da Il Saggiatore, analizza dunque la produzione narrativa di Austen nelle sue tre dimensioni essenziali: personaggi, trama e spazio. Uno dei pregi delle sue opere è che a distanza di tempo, anche se non ricordiamo nel dettaglio gli snodi narrativi di ogni singolo romanzo, abbiamo ben visibili nella mente alcuni elementi cardine. Anzitutto le storie avvengono in uno spazio perimetrale ben definito (la tenuta, la villa, il piccolo villaggio, precisi quartieri di Londra), che assume un significato simbolico nel momento in cui il possesso o meno di un’abitazione dignitosa è essenziale per il consenso al matrimonio. La “povertà” di Frederick Wentworth in “Persuasione”e di Edward Ferrars in “Ragione e sentimento” ne sono un esempio. Vi sono poi alcuni topoi che ritroviamo in ogni opera: l’inchino di saluto quando uomini e donne si ritrovano nella stessa stanza, i ricevimenti in maestose sale da ballo, le fanciulle colte da svenimento, l’invio furtivo di lettere e biglietti. Non si trovano riferimenti alla Storia, al mondo che avanza al di fuori delle quattro mura in cui le protagoniste vivono la propria educazione sentimentale. Il mondo descritto da Austen procede lineare, senza svolte improvvise e colpi di scena: sono i dialoghi tra i personaggi, in particolare fra uomini e donne, a essere essi stessi azione. L’eroina è capace di mantenere, nella conversazione con un uomo, il proprio autonomo punto di vista sulla realtà, ed è così profondamente consapevole dell’antica e logora disputa fra uomini e donne sulle possibilità di queste ultime di fare quello che vogliono, da zittire molto ironicamente, quando ne ha l’occasione, il suo interlocutore.