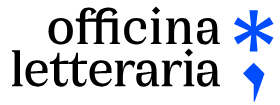Il progetto di Cecilia Campani Ho aggiunto gli ultimi dettagli poco fa, finalmente ho finito il progetto. O almeno, ho finito di disegnarlo. Mi è arrivato l’ordine di costruire una cosa del genere una settimana fa, non ci ho messo neanche tanto. E’ stato difficile capire inizialmente come strutturare la cosa, ma credo di aver trovato il giusto compromesso. Sono delle docce, un po’ particolari. Il profilo della doccia classica è in ceramica, colorato alle volte. Queste le ho dovute fare in metallo: al passaggio del gas non avrebbe retto se no il materiale. Il tubo l’ho di collegamento l’ho fatto sottile mentre il soffione l’ho fatto un po’ più grosso, se no risultava inutile. Il tubo di collegamento dovrebbe proseguire al di sotto del pavimento, non era necessario una piazzola con il buco di scarico quindi l’ho omessa. Prosegue nel pavimento fino alla cabina energetica che lo alimenta. Accanto a essa vi sono i serbatoi: ne ho aggiunti alcuni, magari non bastano. Il resto non era di mio compito ma ho sentito i miei colleghi e dovrebbero aver quasi finito gli ultimi pezzi. Il nome tecnico delle cabine è motori, quello dei serbatoi generatori e le docce le ho nominate scaricatori. Il gas non l’ho scelto, non sta a me tale scelta. E’ stato molto divertente lavorare a questo progetto: uno potrebbe pensare sia una bazzecola per un ingegnere ma non è pr niente così. I primi giorni a ogni aggiunta spuntavano problemi di diverso tipo, sui materiali, la grandezza, l’utilità dei pezzi, la loro posizione. Un lavoro faticoso, molto, ma soddisfacente, molto, ora che l’ho finito. Il capo sarà proprio contento della mia efficienza e velocità. Forse riuscirà anche a togliermi questo dubbio: perché le docce a gas gli servono? Cioè, quelle a acqua lavano, ma queste?
Rom, un uomo di Claudia Badaracco L’estate stava terminando quando in città arrivò una comunità rom. Svernavano nelle periferie urbane, separati da una società di cui non volevano fare parte, ma che poteva fornire un folto pubblico per i loro spettacoli. Ricordo che raggiunsero Trieste una tarda mattinata di inizio settembre. Lavoravo vicino al luogo da loro scelto e vidi che iniziarono subito a montare i loro tendoni. Mi fermai a osservarli. La loro cultura, per quanto diversa dalla mia, mi affascinava. I loro volteggi nell’aria suscitavano in me il desiderio di una leggerezza capace di smorzare le rigidità del mio carattere. Immerso in questi pensieri, soffermai il mio sguardo su una figura in lontananza, asciutta e agile: era certamente un acrobata. Si avvicinò e mi colpì l’espressione pacata, ma sicura di sé che trasmettevano quegli occhi neri e sottili. Mi salutò cortesemente con un cenno. I giorni passavano e arrivammo a scambiare anche qualche parola. Si chiamava Stevan. A poco a poco capii che tutte le tradizioni della sua comunità, dalla musica al viaggio costante, esprimevano un anelito di libertà. La libertà di movimento, tuttavia, era per loro destinata a terminare presto. L’undici settembre, infatti, il governo fascista diede disposizioni per internare tutta la gente come lui, ritenuta “geneticamente criminale”. Dopo qualche giorno non vidi più Stevan né nessuno dei suoi. Vidi che il loro accampamento era deserto e compresi che non erano riusciti a fuggire, ma che erano stati vittime di una legge assurda. Passò un anno e anche a me, oppositore politico, toccò di essere internato. Mi mandarono a Birkenau. Mi spogliarono di tutto. Mi rasarono capelli, barba e peli, tatuarono sulla mia pelle un numero che porto ancora, indelebile. Mi costrinsero a indossare una divisa a righe. Tutto era indistintamente avvolto da una aura grigia di morte. Qualcosa cambiò un giorno. Mi spostarono in una baracca vicino al settore E del campo. E lì, oltre il filo spinato, la vita sembrava diversa. C’era qualcosa che mi era familiare. Vidi che lì erano rinchiusi i Rom e i Sinti. Diversamente dagli settori del campo, lì si trovavano riuniti insieme uomini e donne con i loro figli. Avevano mantenuto i loro abiti e i loro strumenti, con i quali, a dispetto della condizione in cui si trovavano, davano voce alla nostalgia di una libertà che li aveva sempre contraddistinti. Con la loro musica e le loro danze sapevano rimanere in equilibrio in quel mondo letale. Li osservavo e loro sapevano, come un tempo, infondermi il desiderio di una vita diversa. Ma in una notte, tremenda, anche tutto questo finì. Bastarono solo due ore, bastò una decisione di chissà quale pazzo. Improvvisamente sentii cani abbaiare, bambini piangere, donne e uomini strepitare spaventati e poi dolenti. Seguì un silenzio assordante. Il giorno successivo il fumo che usciva dai forni crematori era ancora più nero. Per un attimo il mio pensiero andò a Stevan. Caro mio, nella tua lingua “rom” significa “uomo” e la tua gente non ha mai smesso di esserlo.
di Marcello Mistrangelo I triangoli rosa sono per i pederasti. Ne servono tanti. Si prende una fettuccia già tinta e si taglia in diagonale, prima in un senso e poi nell’altro. Si riprendono poi i bordi perché non si sfilaccino, ma velocemente. Non bisogna perdere tempo, non è alta confezione. Sono solo marchi con cui identificare che veste la divisa. Però è importante la fase di tintura, che il colore sia di qualità e non sbiadisca. Perché giallo è per gli ebrei, rosa per i pederasti, ma rosso per i dissidenti politici. Non deve sbiadire. Un criminale politico non è comunque un sodomita, c’è diversità anche fra i diversi. Il cerchio rosso va cucito dietro, tra le scapole. Identifica chi è stato scoperto a voler scappare. Deve aiutare il soldato di guardia a prendere la mira, se il prigioniero si mettesse a fuggire. Questa commessa ha portato molto lavoro alla sartoria, siamo grate. Era una piccola ditta e la gente ha risparmiato tanto sui vestiti in questi ultimi decenni. Hanno campato a fatica, i padroni, per tenere aperto e riconoscere un po’ di salario a noi operaie. Ripeto, è molto importante la qualità della tintura. Perché nero è per i capi dei prigionieri, marrone per gli zingari. Non è la stessa cosa. Ci sono diversi migliori di altri diversi, in qualche modo. Giallo e blu sono i colori da comprare in maggior quantità, e di buona marca. Perché giallo sono gli ebrei, e blu gli spostati. E sono la maggioranza di coloro a cui danno lavoro, in quei campi.
Grete e Anne di Patrizia Minetto Il Dr. Franz mi deve parlare. Me lo ha mandato a dire da mia madre. E’ più di un medico per noi, un amico, una persona cara. Ha detto che deve parlarmi di una cosa molto importante che riguarda Anne. Ma non so niente di più. Anne è una bambina malata. Ora ha sei anni. Ha un gigantismo cerebrale, così mi dicono. E’ nata grande, troppo grande, con la testa enorme. Non sapevo come fare. Piangevo, piangevo, la guardavo e pensavo che era mostruosa. La baciavo sulla fronte per calmare il suo e il mio pianto. Non ha fatto tutto quello che fanno i bambini della sua età e mai ci riuscirà. Anche Franz me lo ha detto. È ritardata. Poverina. Forse ci sarà qualche notizia per me. Ci spero, ho sentito dire che sono stati aperti dei nuovi centri che studiano le malattie genetiche. La medicina sta facendo passi da gigante. Che emozione! Anche la mia piccola Anne forse è stata scelta per partecipare a questi studi nuovi. Me ne ha parlato la mamma di Frederick, Frieda. Anche lei ha un bambino malato. Ha una malattia diversa da quella di Anne ma anche lui non parla, non capisce proprio tutto. Anche lui, dice Frieda, ha una malattia ereditaria. Mi sono documentata e ho letto che c’è un nuovo filone di studi chiamato eugenetica che si interessa proprio alle malattie ereditarie e che illustri medici incaricati da Hitler in persona, stanno studiando nuove cure. Chissà se anche Anne è stata scelta. Frieda ha acconsentito alla somministrazione di queste nuove cure per suo figlio e mi ha raccontato che sono pericolose. Mi farò spiegare bene dal Dr. Franz quali sono i rischi. Anche un piccolo miglioramento sarebbe meraviglioso per Anne. Piccola mia, la immagino magari giocare con gli altri bambini. Un sogno! Frieda va a trovare Frederick ogni volta che può e so che le è dura stare lontano da lui. Non so se potrei stare lontana da Anne, non ci siamo mai separate, ha bisogno di me. Qualche giorno fa Frieda mi ha detto che Frederick è stato trasferito. Ora è in un altro centro più lontano. L’ho vista molto triste. Mi ha detto che le avevano scritto una lettera ma che ancora non le sapevano dire dove si trovava. La lontananza si può superare se la speranza di una vita migliore per tuo figlio esiste. Sì, posso farcela anche se dovessimo vederci poco per qualche tempo. E poi andrei a trovarla anche fosse in un ospedale più lontano. Sono tanti i bambini che sono stati scelti per ricevere queste nuove cure ma per ora non tutti. Mentre cammino penso a come starei senza Anne e quanta paura se dovesse capitarle qualcosa. Addirittura morire. Mi hanno detto che con queste cure i bambini possono morire. A volte gli devono fare anche una dieta particolare, chiamata dieta E . non so di cosa si tratta ma so che fa parte di questi nuovi metodi che la medicina sta sperimentando. Mentre uso la parola sperimentando mi sento male. Penso che nessun bambino neppure il più malato possa essere trattato come una cavia ma poi penso che tutte le cure nuove, proprio come i vaccini, possono essere pericolosi e all’inizio vengono sperimentati, Si, speriamo che ci sia una speranza anche per Anne. Cammino verso casa e il mio passo, non so perché, sta accelerando e così anche il battito del mio cuore. Il passo si sta trasformando in una corsa. Un brivido mi percorre. Avvicinandomi a casa sento mia madre, mio marito, sento le loro voci. Sono per strada fuori dalla porta. Intravedo le loro sagome ma non vedo quella di Anne. Dov’è ? il cuore in gola, corro sempre più veloce. Anne. L’hanno portata via. Non l’ho salutata, non ho firmato niente. Un foglietto nelle mani di mia madre con il nome dell’ospedale dove la porteranno. Non ho scelto. Non avevo deciso. Volevo sapere. Non avevo deciso. Perdonami bambina mia. Ti troverò. Perdonami .
Ester che ama una donna di Nadia Carì La amo. Ci amiamo. Ci amiamo di un amore che per noi è sincero, ma anche puro. Cosa che non è, oggi, agli occhi del mondo. Ma cosa esiste di più bello, nel creato, dell’amore? E chi lo ha detto che l’unico amore possibile debba essere solo quello tra un uomo e una donna? Se il sentimento dell’amore è proprio di ogni uomo e ogni donna, e ognuno di loro ha nella sua disponibilità quel meraviglioso sentimento, esso può poter essere elargito a qualcun altro che lo ricambi. A chiunque altro. E allora che differenza può mai fare se io, donna, esprimo il mio, verso un’altra donna? E se un’altra donna fa lo stesso, con me? E noi ci amiamo di un amore sincero e puro. Come solo il VERO amore, può essere: PURO E SINCERO. Io, Ester, lesbica ed ebrea. Questo, per il mondo in cui vivo è un binomio inaccettabile. Oh, non è che essere “solo” lesbica, o “solo” ebrea, non sia un problema nel mondo in cui vivo. Il mondo in cui vivo non è il mio mondo.
Ero solo un farmacista di Elena Gallia Ero solo un farmacista, oggi sono criminale Da quel momento divenni responsabile dell’approvvigionamento e della formulazione di nuove preparazioni a base di morfina, scopolamina, luminal e verolan. Mi chiamo Albert Keller, sono nato nel 1901 nel distretto di Wiesbaden. Ho studiato chimica, come mio padre e prima di lui mio nonno, per diventare farmacista e rilevare l’attività di famiglia. Mio fratello maggiore è morto durante la grande guerra, mia sorella è entrata in seminario per divenire suora di clausura, quindi in un certo qual modo sono rimasto l’unico figlio. All’età di sedici anni mi è stata diagnosticata una distrofia della retina all’occhio destro, che mi ha impedito di entrare nell’esercito, fanteria, come è stato per mio fratello. Nel 1924 mi sono sposato e mia moglie ha dato alla luce 4 bellissimi bambini, Alfred, Erich, Helmut e la piccola Annette. Era il 4 marzo del 1936 quando mi venne recapitata a casa una lettera dal Ministero della Sanità, nella quale mi veniva richiesto di prendere servizio presso il centro di Eichberg come responsabile chimico-farmaceutico. Dal 1936 al 1940 la Farmacia Keller venne gestita ad orario ridotto da mia moglie, mentre io tutte le mattine dal lunedì al sabato, timbravo la presenza presso l’Istituto di Salute Pubblica. Dapprima mi venne chiesto di riorganizzare i magazzini, inventariando e trovando nuovo destino ai farmaci scaduti. In un secondo momento mi venne chiesto di firmare un plico di documenti nel quale garantivo segretezza e discrezione circa il mio operato al servizio del governo. Da quel momento divenni responsabile dell’approvvigionamento e della formulazione di nuove preparazioni a base di morfina, scopolamina, luminal e verolan. Ogni settimana arrivavano ricarichi di materia prima, era quindi mio compito saggiarli, stoccarli e via via formularli in mono-somministrazioni iniettabili. Avevo a disposizione un laboratorio non più grande di 12 metri quadri, adiacente a un magazzino grande tre volte tanto. Trascorrevo le mie giornate li dentro, scandite da 4 campane. La prima del mattino all’arrivo del carico. La seconda a distanza di circa tre ore, per il ritiro del primo lotto di siringhe. In 2 ore riuscivo a preparare all’incirca 30 mono dosi. La terza a metà giornata indicava la pausa pranzo. E con l’ultima veniva ritirata la seconda tornata. A quel punto potevo rientrare a casa. Non mi era concesso di parlare con nessuno, non disponevo di nessun collaboratore. Gli stock di monodose pronti all’uso dovevano essere lasciati al suono della campana sul carrello metallico dell’anticamera. Sarebbero stati recapitati pochi minuti dopo da un’infermiera. Per molto tempo non conobbi il destino di quelle fiale. Un giorno chiesi al mio superiore, l’uomo che in origine mi fece firmare le carte, e rispose che l’ospedale aveva aumentato i posti letto accogliendo pazienti in fase terminale. La mattina dovevo entrare dalla porta sul retro, quella dell’ala nord ovest, e dovevo obbligatoriamente accedere al mio laboratorio attraverso le scale interne. Non mi era permesso transitare per i corridoi, accedere ai reparti. Dissero per ragioni di sicurezza e riservatezza. Venni a sapere per caso. Non si accorsero che la porta dell’ultimo bagno in fondo era chiusa e che in quel momento non mi trovavo in laboratorio. Stavano in piedi davanti all’orinatoio con l’uccello tra le mani. – Nelle ultime due settimane abbiamo avuto 32 decessi e nessuno dei genitori può sospettare non si tratti di morte naturale. Quelle iniezioni discrete sono miracolose, la polmonite è salvifica .- Scrollarono l’uccello, chiusero i bottoni e risero come rapaci appagati. Dopo allora ricordo solo la puzza di vomito tra i piedi.
Diversa di Cristina Colombo Bolla Non avrei mai pensato che la mia ribellione giovanile si potesse concretizzare in una stella gialla. “Io sarò diversa” era la mia frase preferita, quella che concludeva la discussione, quando litigavo con i miei genitori e uscivo dalla stanza sbattendo la porta. Ora lo sono davvero – diversa – ma come hanno deciso loro, non come intendevo io. Mi sentivo diversa perché a diciotto anni volevo continuare a studiare invece di accasarmi con un marito scelto dai miei genitori e crescere pargoli. Invece mi hanno detto che non potrò più andare a scuola, nè tantomeno iscrivermi all’università. Mi sentivo diversa perchè avevo cominciato a lavorare come cameriera in un ristorante per guadagnare qualcosa per i miei studi. Invece mi hanno licenziata, perchè il ristorante ora è riservato agli ariani. Mi sentivo diversa perchè alla sera non stavo chiusa in casa a ricamare e pregare come mia madre ma uscivo con i miei amici e andavamo a ballare. Ora non è più possibile. Molti di loro non mi possono più frequentare ed il buio è diventato pericoloso perché questa stella gialla brilla più di quelle nel cielo e rischio di essere aggredita e insultata senza che nessuno muova un dito per difendermi. Volevo essere diversa e ora vorrei solo urlare: “Non mi riconoscete più? Sono sempre io, sono la stessa di prima. Che cosa è cambiato? Che cosa ho fatto di male? Io sono uguale a voi”.
Famiglia mista di Silvia Casaccio Mio marito è di razza ariana, io sono ebrea. Il nostro è un matrimonio misto privilegiato, come lo definiscono loro. Non sono stata costretta ad abbandonare casa né i nostri figli e portare la stella, ma i vicini non ci rivolgono più la parola e siamo isolati. A me non pesa, mi ferisce il comportamento di Frank che mi costringe a stare lontana dalla mia famiglia. “E’ pericoloso, non possiamo fare mosse false” dice lui. Protegge i nostri figli. Frank mi riferisce che al lavoro i colleghi lo ignorano. Li sente parlare della nostra situazione. Lui non ha il coraggio di affrontarli. Non è mai stato un uomo coraggioso e si fa forza attribuendomi delle colpe. Non apertamente ma coi fatti: cenando in silenzio, non guardandomi negli occhi, non sfiorandomi. Sono sempre io! Vorrei gridarglielo ma le parole mi si strozzano in gola e scoppio a piangere. Ottengo così solo il suo biasimo. Avrei dovuto ascoltare mio padre quando mi diceva di non sposarlo “non è l’uomo per te”. Io però ne ero innamorata. Le persone appaiono migliori quando non ci sono criticità. Con mia madre ci scambiamo delle lettere. Le nascondiamo ogni volta in un posto diverso. In ogni nostra corrispondenza c’è l’indicazione di dove si trova il messaggio successivo. Frank non sospetta nulla. I miei genitori se la passano male, sono senza lavoro nonostante siano due medici stimati. Almeno prima. Ora praticano la professione di nascosto e solo per gli ebrei come noi. Sono stati costretti a vendere i quadri e le porcellane per pochi soldi. Patiscono la fame, mia madre è molto dimagrita anche se non lo ammette. I vestiti gli stanno grandi. Potessi abbracciarla, dirle quanto le voglio bene, portarla via dalla Germania. Non esiterei a lasciare tutto e tutti ma il tempo per fuggire ormai è passato, lasciandoci increduli e senza speranze.
La moglie di un soldato tedesco di Sabrina Branchi Franz dice che è giusto, bisogna farlo per il bene della patria, per la nostra Germania. Come ogni mattina gli ho lasciato la divisa pulita sopra il letto. Quando non la indossa sembra diventare un’altra persona, un padre amorevole che gioca ai soldatini insieme a nostro figlio Thomas. Gli racconta che la sua uniforme è magica perché l’aiuta a sconfiggere gli orchi malvagi. Gli è sufficiente metterla indosso per diventare ancor più forte e coraggioso sebbene non sia lui a dettare le regole. È una guardia ubbidiente e responsabile, qualunque gesto o azione gli vengono ordinati di fare procede senza biasimare perché è un bravo soldato e come tale non si fa troppe domande, non ricerca inutili spiegazioni. Deve soltanto agire in un certo modo, in quel modo considerato da chi sta ben al di sopra di lui come l’unica soluzione possibile ed efficace. Thomas lo ammira e vorrebbe poter avere anche lui una divisa dai simili poteri così da diventare ubbidiente quando mi fa arrabbiare. Ogni sera quando torna a casa il mio caro marito mi bacia sulla fronte, accarezza il viso del nostro bambino e poi ci mettiamo a tavola per cenare. Ogni tanto senza che se ne accorga lo osservo e mi viene in mente proprio la sua favola dell’uniforme magica: “Chissà a quante persone quella bocca calda e carnosa che mi bacia alla mattina e alla sera avrà urlato, umiliato e sputato contro? E le sue mani grandi e forti che fa scorrere lungo la mia pelle nei nostri momenti d’intimità quante frustate avranno dato? Quanti individui avranno impiccato? A quanti esseri umani avranno sparato? Non lo so, meglio non sapere; preferisco pensarla anch’io come la fiaba dell’eroe che salva il suo popolo dai mostri cattivi. Adesso sono stanca e per giunta ho mal di piedi per via di quel paio di decolté nuove. Finisco di riassettare la cucina, metto a dormire il mio piccolo e mi distendo sul divano accanto a Franz.
Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, uno spettacolo itinerante di parole, musiche e installazioni, ci aiuterà ancora una volta a riflettere su quanto accaduto, sulla necessità di ricordare, di mantenere vivo il passaggio di generazione in generazione della conoscenza dei fatti, delle conseguenze, del grado di disumanità che è stato possibile e che è sempre potenzialmente ripetibile. Una responsabilità, quella della memoria, che ci coinvolge tutti. Lo spettacolo Lo spettacolo si intitola Countdown ed è organizzato da Arcigay con la collaborazione dell’Accademia Linguistica di Belle Arti, dell’Università di Genova e di Officina Letteraria Gli allievi di primo livello, insieme ad alcuni maestri di Officina e scrittori genovesi, hanno scritto i testi dello spettacolo. Gli allievi del laboratorio Grammatica delle Storie, condotto da Emilia Marasco, sono: Sabrina Branchi, Claudia Baldracco, Cecilia Campani, Nadia Carì, Silvia Casaccio, Cristina Colombo Bolla, Elena Gallia,Patrizia Minetto, Marcello Mistrangelo. Hanno lavorato su alcuni passaggi dello studio “The ten stage of genocide” di Gregory H. Stanton. Hanno scritto brevi, a volte brevissimi monologhi, e ne hanno prodotti più di quanti servissero per lo spettacolo per entrare profondamente in un clima. I racconti Ne pubblichiamo alcuni, fino al 27 gennaio, come nostro piccolo contributo al Giorno della Memoria. Quelli selezionati per lo spettacolo sono sul sito www.omocausto.it Leggi i racconti. Dove e quando? Lo spettacolo sarà domenica 27 gennaio 2019 alle 17.30 all’Albergo dei Poveri, piazzale E. Brignole, Genova.
Paragrafo Centosettantacinque: La fornicazione contro natura, cioè tra persone di sesso maschile ovvero tra esseri umani ed animali, è punita con la reclusione. […] Eldorado di Camilla Tomiolo Quando è stata l’ultima volta? Due sere fa. E come è stato? Le luci sul palco, il semi buio intorno, euforia nelle gambe, paura nei polsi. E poi? Lo sai: prendi il respiro. Ti tuffi. È qui che ti voglio. Ci sei riuscito? Sì. Di nuovo. Sì! E che mi dici dei pezzi di faccia da gentleman che ti sei portato dietro? Li abbandoni pian piano. Un pezzo al guardaroba, un pezzo sotto a un tavolo, un altro pezzo sul bancone del bar. Qualche frammento microscopico sul vestito nero della folla. Tutto il trucco del mondo non basta mai. No, hai ragione. È un processo più fondo, quando cominci a dimenticarti che sono i tuoi gli occhi che guardano, allora sei libero: sei dentro la folla. Centinaia di persone che sudano, ballano, si baciano. Si spogliano. Scopano qua e là. Sì. È un’altra Legge lì dentro. Maschile femminile. Femminile maschile. (ride) Mostri! (pausa) Se potessi liberarmi di te senza perdere me stesso. Giusto e sbagliato. Bianco e nero. Verità assolute… (ride) Tradizione. Ciò che è sempre stato non può essere cambiato. Il pensiero si disfa di fronte alla realtà. La realtà è una e tu devi rispettarla. Tutto si trasforma. Questo non sono io. Io non sono te. L’unico peccato che ho mai commesso è di pensare di non sapere chi sono. Mi sono messo un paio di calze velate l’altra sera. Ero eccitato e nello stesso istante arrabbiato con me stesso. Nello stesso istante. L’eccitazione dal basso si espandeva, arrivava a sfiorare la rabbia che a quel punto non aspettava altro che scatenarsi contro di lei, ma, senza rendersene conto, tutto ciò che faceva era mescolare se stessa alla voglia: dare forza alla spinta. Le labbra le ho fatte di un rosso violento, troppo acceso per restare dov’era: nel cuore della notte mi è scivolato fuori dalla bocca, una strisciata che mi ha allargato il sorriso. (ride) O forse un livido. Un bacio senza amore. Un morso. Rosso innaturale diventerà viola. Non capisco perché lo fai. Cosa non capisci? Libertà o distruzione? (ride) Tu vuoi offenderci. (ride) Rispondi. Che cosa vuoi?! E tu? (pausa) Chi sei? Chi sei piccola voce che riempi le nostre teste? Da dove arrivi? Da quanto sei qui? (silenzio) Sei la morale? O sei la Legge? Di quale Dio? O sei solo un uomo, come me? Nemmeno. Tu sei un occhio impreparato che tenta di spiare l’universo da un buco di una serratura. Che cosa credi di vedere? (silenzio) Che cosa hai visto? Dillo! Che cosa credi di avere visto?! (silenzio) Non tutto ciò che non conosci è sbagliato, sai? Forse è perfino il contrario! Ci hai mai pensato? Eh?! Che cosa senti? Rabbia? Sì! Vorresti infilare tutto questo fango di nuovo dentro al secchio! Sì! (pausa) Io ho questo senso sulla lingua, che non è il senso comune, è la colpa. Io ho fame. E non posso farci niente. La mia anima c’è, e c’è, e c’è. Riesci a capirlo? Forse mi sono innamorato. Guarda come ti sei ridotto. Mi sono innamorato della libertà. Tutta questa libertà è solo una follia. Tu sei cattivo. Ero affamato. Avevo sete. La sete che avevo era una lama rovente. Ma volevo la luce. Volevi il buio. Volevo la luce. La tua luce è una terribile illusione. (silenzio) Tu non sai amare. È quello che dicono. Ma nessuno mi odia più di quanto io mi odi. Dentro di me c’è una voce che parla come loro, sei tu. È la mia guerra, è proprio qui. Se perderò… la perderò solo qui dentro. Tu amami piuttosto. Mostrami l’Amore. Si può insegnare? E se lo insegni a me, imparerai anche tu? Dicono che si deve educare al bene attraverso il male. Che siamo deboli. Tollerati. Per quanto ancora? (pausa) Se solo potessi essere quello che sono. Ma io non posso sopravvivere a te. E tu a me. Solo uno, solo uno di noi può restare. (pausa) Io non voglio morire. Monologo teatrale scritto da Camilla Tomiolo, rappresentato durante l’evento Blackout – giorno della memoria al Munizioniere di Palazzo Ducale il 29 gennaio 2017, organizzato da Arcigay Genova.
Un calcio alla porta e sono dentro. La guardia con un occhio blu e l’altro grigio grida: “hey tu, invertito, in piedi!”. “Si, signore”, risponde Hans, con quella sua vocina sottile da topolino. “Qui! In ginocchio!”. “Si, signore”, il topolino si mette giù, in ginocchio, con la testa tra le mani. Eldorado di Michela Armenia Il trucco, è non reagire, recitare una parte. E io sono bravo a recitare, Sei nato per questo mi diceva mia madre. Meine Liebe. E’ semplice. Io faccio la valigia e pouff, me ne vado. E mi infilo, piccino come sono diventato, in quella fessura nell’asse di legno che ho un palmo sopra la faccia. Proprio lì, sotto le ossa del bacino di Otto. Prima il polso, poi il braccio e la spalla, poi l’altro polso, l’altro braccio e l’altra spalla, e poi qualcuno da sotto mi spinge su, sotto i piedi, e appoggio le mani su travi di abete ruvido. Abbasso anche io la testa, e annuso questo palcoscenico e mi alzo in piedi sui miei tacchi di vernice, neri. Sistemo le calze, velatissime, l’abito è quello di raso, rosso, con lo spacco, profondo. I pendenti di brillanti e il decolletè, liscio. Le perle dorate. Sono pronta. C’è il mio pubblico, qui, all’Eldorado. Il giovedì è la mia serata, la serata di Evah. Ho messo un velo di cipria sotto il rossetto, me lo ha consigliato Constance, così non sbava, nel caso ti sudassero i baffi sotto le luci forti della scena. Constance, l’unica puttana ebrea di cui ti potevi fidare. Piccolo angelo, c’eri anche tu su quel vagone. Stella gialla a te, triangolo rosa, a me. A me, che nemmeno piace il rosa. Non ha passione. Rosso doveva essere. Rosso, come l’inferno. Come questo vestito di raso che scivola sulle mie gambe e odora di tabacco e di rum. La parrucca è quella nera, ondulata. Sono pronta, tra il pubblico ci sono tutti quanti, ancora una sniffata di cocaina. Sapessi, Guardia, come fa star bene un po’ di coca, una sigaretta e un bicchiere di vino rosso. Mi aiuterebbe, sai, Guardia, quando ti chiedo una porzione in più di sardine e tu mi spingi la faccia contro il tuo grosso cazzo ariano, non sai quanto mi aiuterebbe un po’ di coca, una sigaretta e un buon bicchiere. Inizio a cantare, ieri si è esibita Marlene, l’Angelo Azzurro, Dietrich su questo stesso palco e adesso tocca a me, ho cancellato le mie sopracciglia, con la cipria, e le ho ridisegnate sottili, due sorrisi sottili, all’ingiù, proprio come le sue. Ma il boa di struzzo no, io no, io sono Eva e voglio che mi vedano per bene, la mia faccia, la mia bella faccia tutta intera, con i miei zigomi forti e gli occhi allungati. Le mie gambe. E la mia voce. Inizio la mia canzone. Ridi, Guardia? Ridi della mia testa rasata da un barbiere distratto? dei miei capelli castani e lucidi lì per terra, sopra mucchi di capelli di criminali, pazzi, di comunisti, ebrei e zingari? Ridi dei miei denti che sembrano così grandi e gialli tra queste labbra cotte dal sole e dalla neve, tagliate da solchi dove scorre sangue e pus? Ridi delle mie mani che non sanno stare ferme? E’ il mio segreto, sai Guardia? Io sento la musica, io la seguo sulla punta delle dita. Dovevo stare più attento, oh lo so. Lo! So! Me lo diceva sempre lo Zio, sai Guardia? Mi diceva che dovevo essere un finocchio discreto. Tu puoi essere un finocchio ma non puoi vivere come un finocchio, diceva lo Zio. Non devi nemmeno sognare o immaginare come un finocchio. Il caro, vecchio, Zio. Era così infelice povero Zio, si eccitava come un bimbo davanti a un treno a vapore, per uno sguardo rubato, per una mano sfiorata, Ogni sua stretta di mano era il ristagno di una carezza, povero Zio. E ogni suo respiro, il ristagno di un grido. Io, Io la volevo tutta, questa mia vita, tutta così, come mi chiedeva di essere vissuta, io non volevo rosicchiare gli angoli. Io ho baciato, abbracciato, ho toccato e scopato così tanto e non ho mai dovuto pagare, sai Guardia? Ma certo che lo sai, quanta bella carne c’era attaccata a queste ossa. Io sono pronta, ora inizio la mia canzone, in prima fila c’è Christopher, che mi sorride, il mio piccolo Chris, con quel suo accento inglese, era adorabile. Avrei dovuto seguirlo, “Scappa con me a Londra”, mi ripeteva, “la mia vita è qui, all’Eldorado, dolcezza”, gli rispondevo. Chissà dove sei con i tuoi occhi verdi, mio piccolo Chris. Chissà se ci pensi ogni tanto… ti ricordi? Berlino. 1930… autunno. Io ti posso ancora sentire mio dolce Chris, nelle mie mani c’è il ricordo della tua pelle, nelle mie dita, la linea del tuo profilo. Mi sorridevi, dalla prima fila. Cherie. “Qualcuno porti via Hans”. Vogliono che ce ne occupiamo noi dei corpi. Non ci vogliono toccare. Non c’è nessuno che ci tocchi qui. Per noi con il triangolo rosa non ci sono più abbracci o carezze. Noi con il triangolo rosa sappiamo che siamo ancora vivi perché quando tossiamo, pisciamo o caghiamo sentiamo fitte di dolore. Quando ci bastonano le gambe se non scattiamo subito al suono della sirena, Fitte di dolore quando ci spingono per terra per vedere quanti secondi impiega un invertito a cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, cadere. Il dolore dell’amore che se ne va, E’ la mia canzone. Meine Liebe. Mi dicevi “Scappa con me a Londra” “La mia vita è qui, all’Eldorado, dolcezza”, ti rispondevo sempre. Mi dicevi con il tuo adorabile accento inglese, mi dicevi “Questa non è la Terra Promessa” La Legge, mi dicevi, “We are bandits”. [Voce fuori campo] Paragrafo Centosettantacinque: La fornicazione contro natura, cioè tra persone di sesso maschile ovvero tra esseri umani ed animali, è punita con la reclusione; può essere emessa anche una sentenza di interdizione dai diritti civili. (ride e canta) Sei andato via da solo, meine
Secondo gli ultimi censimenti, in Germania ci sono dai 67 ai 68 milioni di abitanti e, quindi, 34 milioni di uomini in cifra tonda. Di conseguenza, abbiamo circa 20 milioni di uomini capaci di procreare (…). Se ammetto che ci sono da uno a due milioni di omosessuali, vuol dire che il 7 oppure l’8 o addirittura il 10 % degli uomini sono omosessuali. Se la situazione non cambia, il nostro popolo sarà annientato da questa malattia contagiosa. (dal discorso ai generali delle SS di Heinrich Himmler, 1936) Domenica 2 febbraio 2014 (ore 16:00) Officina Letteraria sarà alla Commenda di Prè per l’evento Leggere la memoria: un reading di otto racconti, pensati e scritti sulla base di documenti e testimonianze storiche, per dare il nostro contributo al Giorno della Memoria. Questa ricorrenza internazionale, stabilita dalle Nazioni Unite nel 2005, cade ogni anno il 27 gennaio, giorno della liberazione di Auschwitz da parte dell’esercito sovietico. Una giornata che vuole ricordare tutte le vittime dell’Olocausto: ebrei e omosessuali, disabili, rom e sinti. Il reading si svolge nel luogo che ospita Dimenticare a memoria, mostra di arte contemporanea a cura di Arcigay Approdo. Letture a cura di Emilia Marasco ed Elena Mearini e degli scrittori di Officina Letteraria Giulia Cocchella, Andrea Fabiani, Federica Kessisoglu, Dario Manera, Ilaria Scarioni, Marta Traverso. Ingresso libero.