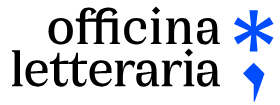Recensione di Marta Traverso. Un’americana a Parigi, di origini alto-borghesi, divorziata, intima amica di Henry James, scrittrice prolifica, arredatrice e giardiniera nel tempo libero, impegnata in opere di carità durante la prima guerra mondiale, prima donna a vincere il Pulitzer per L’età dell’innocenza, il suo romanzo più celebre. Nel 1903 Edith Wharton scrive un saggio di circa 40 pagine, intitolato The Vice of Reading. Un’opera rimasta inedita nel nostro Paese, finché Pier Luigi Olivi non la trova per caso in una bancarella di Barcellona e la fa pubblicare nel 2014 (editore Olibelbeg, Venezia). In difesa della buona lettura. Il vizio della lettura è un pamphlet in difesa della buona letteratura, intesa non solo come forma d’arte, ma anzitutto come veicolo di interpretazione del mondo che ci circonda. La priorità (la missione) di chi scrive è consentire a chi leggerà di apprendere cose che prima non conosceva, di ragionare e riflettere, di elaborare pensieri. Se ciò non avviene, l’esistenza stessa di un’opera letteraria perde significato. Il valore di un libro è commisurato alla sua plasticità, cioè, alla sua capacità di stimolare la mente del lettore creando nuove forme di pensiero Quando diventa vizio. La lettura, secondo Wharton, è “il mezzo che rende possibile uno scambio di idee fra lo scrittore e il lettore”. Essa diventa vizio quando si trasforma in un’azione puramente meccanica, o in pretesto per esercitare la propria vanità (leggo perché fa figo, diremmo oggi). La pratica della lettura non va confusa con la cultura: c’è una differenza, sostiene Wharton, tra il leggere tanto e il leggere bene. La scrittrice, vissuta agli albori della società dei consumi (è morta nel 1937), ha presagito la sorte del libro: non più il prodotto di una ristretta elite culturale, ma un bene di consumo disponibile a chiunque lo desideri. I migliori libri sono quelli dai quali il lettore riesce a trarre maggior beneficio. Sì, ma quale lettore? Se l’editoria determina (almeno sulla carta) una meritocrazia tra chi è degno di pubblicare il proprio scritto e chi non lo è, dovrebbe esistere un’analoga distinzione anche per chi legge? Wharton introduce qui il concetto di “lettore meccanico”. Il lettore meccanico. Il lettore meccanico, secondo Wharton, è nocivo dallo sviluppo di una buona letteratura, perché incapace di discernere la qualità dei libri che legge. Ne legge molti, troppi, freneticamente, ma il suo criterio di scelta sta nella popolarità del libro, nelle copie vendute, nel suo essere “la moda del momento”. Caratteristiche che fanno un gran bene al marketing, ma solo talvolta si accompagnano a una degna qualità letteraria. Il lettore nato. Solo il “lettore nato”, quello che sa discernere, e sa interpretare, e sa accogliere il platonico scambio di pensieri che si crea tra se stesso e l’autore, può nobilitare la lettura e fare in modo che essa non sia più un vizio. Il lettore nato è colui che sa distinguere un buon libro dalla spazzatura. Colui che legge a prescindere dalle mode, dalle opinioni altrui (e dalle top ten e dalle comparsate nei talk show, diremmo oggi). Il lettore meccanico è schiavo del suo segnalibro che ogni notte deve essere spostato in avanti. Il lettore nato è il segnalibro di se stesso. Riflessione puntuale e pungente quella di Wharton. Poiché condivido la sua premessa, che la lettura o induce riflessioni o non ha valore, ecco la mia domanda: chi siamo noi, che leggendo questo post abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché ci sentiamo immuni dal vizio e ci definiamo con fierezza “lettori nati e lettrici nate”, chi siamo noi per decretare un oggettivo giudizio sulla qualità (o assenza di qualità) di un qualunque libro?